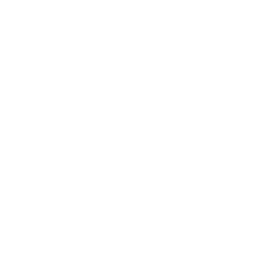Orizzonte Altro

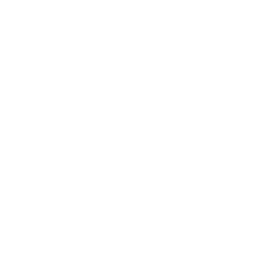
Rivoluzione Conservatrice
Max Scheler
Il Borghese di Werner Sombart, 1914
Edizione originale:
Der Bourgeois
Edizione italiana: Mimesis, Milano 2020
In,
Alberto Iannelli,
Dieci saggi sulla Rivoluzione Conservatrice
Il crepuscolo dell’Antico e le migliori controsoggettualità katechontiche nella fuga del Moderno
Orizzonte Altro Edizioni, 2023, pp. 93 - 108.
Lettura integrale ➤➤➤➤➤

Nel 1913, presso lo storico editore di Monaco Duncker & Humblot, Werner Sombart pubblica Der Bourgeois (Il borghese), capitale opera e cruciale per comprendere l’orizzonte della più rimarchevole saggistica politica tedesca del Primonovecento. L’anno successivo, la rivista Die Weißen Blätter ospiterà tre saggi di Max Scheler dedicati al commento di quel testo: l’omonino Der Bourgeois, Der Bourgeois und die religiösen Mächte (Il borghese e i poteri religiosi) e Die Zukunft des Kapitalismus (L’avvenire del capitalismo). Ebbene, immersi pressoché noi tutti e tutti viepiù avviticchiati e avvinti al suolo e al canto del capitalismo ormai in predicato d’ecumenico compimento, tanto maliosamente avviluppante l’integralità delle terre emerse, quanto persino retroattivamente adeguante ovvero, piuttosto, omologante, all’iperetelismo del “così io voglio che sia stato” l’alterità del “così fu”, quale conseguenza concretamente agente sul mondo potrebbe mai comportare l’affronto di concetti sì tanto eccentrici e al nostro illaqueato udire sfrontati da definire il borghese un “tipo bio-psichico d’uomo”?
Dovremmo dunque consegnarci a un’esegesi esclusivamente storico-erudita di questi scritti, quando non, come invero già da più parti si esige, al loro abbandono leteo o financo al di essi ostracismo e proscrizione de iure? Decisamente così perderemmo, riteniamo, un’occasione così eccelsa come decisiva di elevare eccezione e contesa al nostro Tempo, un’opportunità precisamente consistente nell’indicare, con Scheler e Sombart, quello squarcio che lumeggia divergenza nell’incontro degli orizzonti, disadombrando epperò la pretesa d’omniafferrante atrescenza proiettata dall’intorno nostro coevo altrimenti autodimostrantesi intrascendibile.
È nostra profonda convinzione, infatti, che lo sviluppo del Capitalismo moderno – ora, come testé scritto, noi viepiù così completamente circondante da non lasciarci spazio d’eccedenza e ulteriorità alcuna se e finché indulgiamo presso la sua cronotopia – abbia proceduto, pur, edace, lungo un tracciato carsico e teleologicamente costante, per accelerazioni e strappi rivoluzionari. Pertanto, ponendoci nell’ascolto desto degli epifenomeni affioranti in tali cesure eminentemente eversive e per noi elettive, potremmo anzitutto definire con maggiore precisione di tratto ciò che, per essenza invece avverso all’imposizione di forma, procede tra le ombre dell’indistinto antitipico. E, per noi, imporre confine e chiarore all’altrimenti atro, rappresenta il fondamento teoretico di ogni conseguente prassi avversativa.
Si è già profilativamente posta contro diafania la cesura del Seicento elisabettiano nella precedente analisi dell’opera di Carl Schmitt, e non possiamo se non tangenzialmente invitare il cortese lettore a fare in proprio altrettanto col Duecento italiano, epoca di pari fondamentale importanza nella preparazione dell’avvento dell’estremità del nostro Tempo, dormiente eppur arguto, magari attraverso un’interrogazione – possibilmente emancipata dall’ermeneutica “istituzionale” a noi contemporanea – dei rievocativi canti di Cacciaguida (soprattutto: Paradiso, Canto XV, e l’insistenza anaforica in esso della negazione), dei loro stessi lessico e retorica carichi così di nostalgia, come di livore e pathos della distanza.
Pertanto, è nostra intenzione qui ulteriormente trattenerci presso il Primonovecento tedesco, nel radicato convincimento che – epicentralmente se ci basiamo sulla qualità e sulla quantità dei “reperti” ivi rinvenibili – in tale tramontante Kultur l’Antico, progressivamente spodestato dalla rivoluzione del sedicente Nuovo (ovvero, piuttosto, per noi, dalla civilizzazione manchesteriana), trovi l’ultima sua dimora elettiva, quasi estrema appendice celtica ante l’abisso dell’Atlantico e dell’Anglico.
[…]
È esattamente poiché presta da secoli si approssima – con moto allora rivoluzionariamente accelerato – l’estremità dell’Era dell’enantiosi inautentica o, seconda, esogena, che la conformazione impressa alla Terra da quell’ulteriore esondazione primonovecentesca, apparve – lì, ovvero nelle appendici ancor protese all’aria dell’Antico, elettivamente – quale epoca dell’“abnormità” divenuta norma, del sovvertimento della regola eretto a regola, e l’archetipo antropico in quel tempo trionfante e in quel mondo, giacché “l’uomo che sta in equilibrio sulla testa e cammina con le mani” (W. Sombart).
[…]
Un ulteriore epifenomeno attestante il retto rapporto causale tra borghesia e sistema capitalistico, ovvero tra antropologia ed economia, è rinvenuto, sul finire del primo saggio critico di Scheler, in una sorta di paradosso intrinseco al capitalismo già ostenso dal medesimo Sombart: l’impresa capitalistica comporta doti e qualità eccelse; occorre saper condurre e organizzare discordia d’uomini e complessità di mezzi verso un fine unico elevato nell’astratto del remoto e della non immediata sovraindividualità, occorre epperò saper anzitutto elevare poieticamente tale télos e pianificare con lungimiranza la strategia complessa per raggiungerlo nell’atto con efficienza. Come, dunque, divenne possibile che uomini di tale vaglia non riversassero più – come altresì un tempo – quelle qualità e doti eccelse nelle attività da sempre degne di lode per gli uomini (“la guerra, il servizio verso lo Stato e la Chiesa...”), per, al contrario – adesso – rivolgerle verso attività da sempre degne di biasimo e ignominia (“il negozio, il commercio, l’industria”), ebbene proprio verso gli esercizi del bottegaio?
(M. Scheler)
«Già per il fatto che Sombart intitoli il suo libro Il borghese, dimostra che è lo spirito borghese quello al quale assegna il primato genetico nella formazione dello spirito capitalistico. Ciò che parla a favore di questa sua concezione è soprattutto il chiedersi come delle nature positive, forti e ardite, impegnate a organizzare, che concepivano e ponderavano vasti piani, che si mostravano qualificate all’“impresa” in grande stile, si rivolsero proprio alla vita economica e a questa, poi, nella sua dimensione ordinaria, vi riversarono addirittura le loro forze. Giacché è proprio qui il paradosso del capitalismo, che uomini dalle qualità di valore elevato (in senso biologico e spirituale), qualità che certo non li spingevano originariamente all’impegno nella vita di guadagno economico, divengano a questo punto proprio i capi della vita economica. La guerra, il servizio verso lo stato, il servizio della Chiesa, l’impresa coloniale, tutto ciò “si trova” originariamente assai più vicino a questo tipo di spirito che non il negozio, il commercio, l’industria […]. Perché queste forze fluirono nella vita economica? Come avvenne che dettero la loro anima bruciante, grande, tempestosa a questo ramo dell’attività umana disprezzato nell’antichità e nel Medioevo? Come fu spinto il tipo d’uomo eroico e geniale su un terreno la cui essenza è lavoro e calcolo arido e continuo?»
Proprio poiché il bio-tipo del bottegaio antecede, cronologicamente ed eziologicamente, il sistema capitalistico e la sue “imprese”, esso ha anzitutto pazientemente e sotterraneamente imposto al Mondo e alla configurazione del Tempo la propria assiologia, il proprio ethos, il proprio orizzonte, conformandoli a immagine e somiglianza del sé. Pertanto, quelle nature forti e intrepide, quegli individui eccezionali che ogni epoca ha sempre da offrire e sacrificare, da allora – ebbene oltre il “trionfo” di cotale millenaria azione carsico-con–formativa – non potevano se non rivolgere le proprie gesta verso quei valori e quegli ideale già perversi e adesso invece, nella profligazione rivoluzionaria dell’Antico, divenuti eminentemente licei e financo anagogici.
(M. Scheler)
«Si può soltanto pensare che quelle forze, le quali una volta presenti esigevano di essere messe in funzione, si rivolsero necessariamente al nuovo campo, e questo perché l’ordine della società, già lentamente trasformato dallo spirito borghese, la sua nuova morale, la sua nuova consapevolezza giuridica ecc., escludeva l’abbracciare campi più adeguati, anzi li stigmatizzava in parte come male e delitto (per esempio la morale commerciale, nei confronti della guerra), e con ciò spingeva quelle forze a divenire, sul piano dei nuovi fini economici, la forza motrice per il nuovo progresso. Le vecchie forze avevano perso la loro “morale” – e la nuova morale borghese le prese al suo servizio e le legò al suo carro. Non è dunque lo spirito di impresa la componente eroica del capitalismo, non il “regale commerciante” e organizzatore, ma il piccolo borghese risentito che ha sete di maggiore sicurezza vitale e di una maggiore prevedibilità nella sua vita angustiata (che costituisce, come Sombart così acutamente descrive, il nuovo sistema di valore e di virtù del borghese), a precedere nella formazione dello spirito capitalistico».
Posto, ulteriormente, come questo particolare sistema economico, giacché ha per fondamento e causazione il sistema etico-valoriale e ideologico del borghese, possa essere superato e sostituito solo dall’imporsi di un nuovo ethos, e non già dal superamento – rivoluzionario o riformistico – della struttura marxianamente intesa, è forse possibile, in ultimo – come allora si chiesero Scheler e Sombart, e come maggiormente noi ora, tanto più afflitti quanto ancor più protesi salmodianti (Nur noch ein Gott kann uns retten), ci domandiamo –, un superamento del capitalismo, dobbiamo ebbene attendere e confidare nel sopraggiungere di un nuovo tipo bio-psichico d’uomo in grado di imporre al Mondo e al Tempo il proprio viride ethos defenestrante l’attuale, un nuovo soterico uomo o non piuttosto il ritorno restaurativo dell’antico?