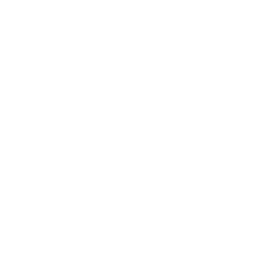Orizzonte Altro

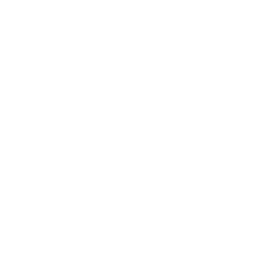
Antologia filosofica del 900
Martin Heidegger
Meßkirch 1889 - Friburgo in Brisgovia 1976
Secondo l'Ordine del Tempo
Essere e Tempo
Sein und Zeit, 1927
Edizione italiana: Longanesi, Milano, 1980
Il raggiungimento della totalità da parte dell’Esserci mediante la morte è nel contempo la perdita dell’essere del Ci. Il passaggio al non Esser–ci–più sottrae all’Esserci la possibilità di esperire questo passaggio e di concepirlo come esperibile. Un’esperienza siffatta è impossibile per ogni Esserci nei confronti di se stesso. Tanto più importante è perciò la morte degli altri. Essa ci fa vedere “oggettivamente” la fine dell’Esserci. Poiché l’Esserci è essenzialmente con–Esserci con gli altri, esso può esperire senza difficoltà la loro morte. Questa datità “oggettiva” della morte dovrebbe quindi render possibile anche una delimitazione ontologica della totalità dell’Esserci […]. Con la morte degli altri diviene esperibile un fenomeno importante, cioè il decadere di un ente dal modo di essere dell’Esserci (o della vita) al non–Esserci–più. La fine dell’ente come Esser–ci rappresenta l’inizio di questo ente come semplice–presenza. Questa interpretazione del passaggio dell’Esserci all’esser solo una semplice–presenza fallisce tuttavia il suo contenuto fenomenico, perché l’ente che rimane non può essere considerato una semplice cosa corporea […]. Il “defunto” che, a differenza del semplice “deceduto” è stato rapito a “coloro che restano”, è oggetto del “prendersi cura” nella forma di funerali, inumazione e culto della tomba. E ciò, di nuovo, perché il defunto, nel suo modo di essere, resta “ancora qualcosa di più” di un mezzo di cui ci si prende cura come utilizzabile intramondano […]. Quanto più adeguatamente si considera il fenomeno del non–esserci–più del defunto, tanto più si fa chiaro che l’essere–con i morti non esperisce affatto l’autentico essere–pervenuti–alla–fine da parte dei defunti. La morte si rivela certamente come una perdita, ma è qualcosa di più di quanto coloro che rimangono possono esperire. Nei patimenti per la perdita del defunto non si accede alla perdita dell’essere quale è “patita” da chi muore. Noi non sperimentiamo mai veramente il morire degli altri […]. Il problema è quello del senso ontologico del morire del morente in quanto possibilità d’essere del suo essere e non in quanto forma del con–Esserci e dell’Esserci–ancora del defunto con coloro che rimangono. Il proposito di assumere come tema dell’analisi della fine e della totalità dell’Esserci la morte esperita presso gli altri non può offrire, né onticamente né ontologicamente, ciò che con esso ci si ripromette di poter ottenere […]. Nessuno può assumere il morire di un altro […]. Ogni Esserci deve assumersi in proprio la morte. Nella misura in cui la morte “è”, essa è sempre essenzialmente la mia morte. Essa esprime una possibilità di essere caratteristica, in cui ne va dell’essere puro e semplice di un Esserci sempre di qualcuno. Nel morire si fa chiaro che la morte è costituita ontologicamente dal carattere dell’essere–sempre–mio e dell’esistenza.
Poiché l’essere dell’Esserci porta con sé questo auto–presupporsi, “noi” dobbiamo presupporre anche “noi stessi” come determinati dall’apertura […]. La comprensione dell’essere, propria dell’Esserci, concerne perciò cooriginariamente la comprensione di qualcosa come il “mondo” e la comprensione dell’essere dell’ente accessibile all’interno del mondo […]. L’in–essere non è quindi una “proprietà” che l’Esserci abbia talvolta sì e qualche volta no e senza la quale egli potrebbe essere com’è né più né meno che avendola. Non è che l’uomo “sia” e, oltre a ciò, abbia un rapporto col “mondo”, occasionale e arbitrario. L’Esserci non è “innanzi tutto” per così dire un ente senza in–essere, a cui ogni tanto passa per la testa di assumere una “relazione” col mondo. Questa assunzione di relazione col mondo è possibile soltanto in quanto l’Esserci è ciò che è, solo in quanto essere–nel–mondo […]. Ma che significa l’affermazione che ciò rispetto–a–cui l’ente intramondano è innanzi
tutto rimesso, deve essere preliminarmente aperto? All’essere dell’Esserci
appartiene la comprensione dell’essere. La comprensione ha il suo essere in
un comprendere. Se all’Esserci è proprio, in linea essenziale, il modo di esse-re dell’essere–nel–mondo, ne viene che, in linea egualmente essenziale, è
proprio della sua comprensione dell’essere la comprensione dell’essere–nel–
mondo. L’apertura preliminare di ciò rispetto–a–cui avviene il disvelamento
di ciò che si incontra nel mondo, è null’altro che quella comprensione del
mondo a cui l’Esserci, in quanto è, già da sempre si rapporta […]. L’Esserci,
in quanto essere–nel–mondo, ha già sempre scoperto un “mondo” […]. Né lo
spazio è nel soggetto, né il mondo è nello spazio. È piuttosto lo spazio a essere
“nel” mondo, perché l’essere–nel–mondo, costitutivo dell’Esserci, ha già
sempre aperto lo spazio. Lo spazio non è nel soggetto, né il soggetto considera
il mondo “come se” fosse in uno spazio; la verità è che il “soggetto”, autenticamente
inteso nella sua ontologicità, l’Esserci, è in se stesso spaziale.
Ed è appunto perché l’esserci è spaziale, in questo senso, che lo spazio si manifesta
a priori […]. La spazialità esistenziale dell’Esserci, che ne determina
il “posto”, si fonda nell’essere–nel–mondo […]. “Qui” e “là” sono possibili
solo in un “Ci”, cioè solo se esiste un ente che, in quanto essere del “Ci”, ha
aperto la spazialità. Nel suo essere più proprio questo ente ha il carattere della
non–chiusura. L’espressione “Ci” significa appunto questa apertura essenziale.
Attraverso essa, questo ente (l’Esserci) “Ci” è per se stesso in uno con
l’esser–ci del mondo […]. L’Esserci comporta il suo Ci in modo originario;
senza di esso non solo non esisterebbe di fatto, ma non potrebbe essere l’ente
della propria essenza. L’Esserci è la sua apertura.
L’Esserci, non solo ha l’inclinazione a cadere in quel mondo che gli appartiene
e in cui è, e ad interpretarsi alla luce riflessa da esso, ma, nel contempo,
cade anche dentro la propria tradizione più o meno esplicitamente afferrata
[…] Gettato nel suo “Ci”, l’Esserci è già sempre assegnato effettivamente a
un determinato (cioè al suo) “mondo”.
L’estremo “non–ancora” ha il carattere di qualcosa cui l’Esserci si rapporta. La morte […] è prima di tutto un’imminenza che sovrasta […]. La morte è una
possibilità di essere che l’Esserci stesso deve sempre assumere da sé. Nella
morte l’Esserci sovrasta a se stesso nel suo poter–essere più proprio. In questa
possibilità ne va per l’Esserci puramente e semplicemente del suo essere–nel–
mondo. La morte è per l’Esserci la possibilità di non–poter–più–esserci. Poiché
in questa possibilità l’Esserci sovrasta a se stesso, esso viene completamente
rimandato al proprio poter–essere più proprio […]. Questa possibilità assolutamente
propria e incondizionata è, nel contempo, l’estrema. Nella sua qualità
di poter–essere, l’Esserci non può superare la possibilità della morte. La morte
è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell’Esserci. Così la morte si
rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile […]. La
sua possibilità esistenziale si fonda nel fatto che l’Esserci è in se stesso essenzialmente
aperto e lo è nel modo dell’“avanti–a–sé” […]. La possibilità più
propria e incondizionata è insuperabile. L’essere–per questa possibilità fa
comprendere all’Esserci che su di esso incombe, come estrema possibilità della
sua esistenza, la rinuncia a se stesso. L’anticipazione non evade l’insuperabilità
come fa l’essere–per–la–morte inautentico, ma, al contrario, si rende libera per
essa. L’anticipante farsi libero per la propria morte affranca dalla dispersione
nelle possibilità che si presentano casualmente, di guisa che le possibilità effettive,
cioè situate al di qua di quella insuperabile, possano essere comprese e
scelte autenticamente. L’anticipazione dischiude all’esistenza, come sua estrema
possibilità, la rinuncia a se stessa, dissolvendo in tal modo ogni solidificazione
su posizioni esistenziali raggiunte. Anticipandosi, l’Esserci si garantisce
dal cadere dietro a se stesso e alle spalle del poter–essere già compreso, e dal
“divenire troppo vecchio per le sue vittorie” (Nietzsche) […]. Poiché l’anticipazione
della possibilità insuperabile apre nel contempo alla comprensione delle
possibilità situate al di qua di essa, essa porta con sé la possibilità
dell’anticipazione esistentiva dell’Esserci totale, cioè la possibilità di esistere
concretamente come poter–essere totale. La possibilità più propria, incondizionata
e insuperabile è certa. La modalità del suo esser–certa si determina a partire
dalla verità (apertura) corrispondente. Ma la possibilità certa della morte apre
l’Esserci come possibilità solo se esso, anticipandosi nella morte, rende possibile
a se stesso questa possibilità come il poter–essere più proprio. L’apertura della
possibilità si fonda nella possibilizzazione anticipatrice […]. Nell’anticipazione,
l’Esserci può accertarsi del suo essere più proprio, della sua totalità insuperabile.
L’Esserci esiste sempre come autenticamente o inautenticamente storico. Ciò
che, sotto la designazione di quotidianità, costituiva l’orizzonte immediato
dell’analitica esistenziale dell’Esserci, si rivela ora come la storicità inautentica
dell’Esserci [...]. L’analisi della storicità dell’Esserci tende a mostrare
che questo ente non è “temporale” perché “sta nella storia”, ma che, al contrario,
esiste e può esistere storicamente soltanto perché è temporale nel fondamento
del suo essere […]. L’Esserci è forse, dapprima, “semplicemente–
presente”, per entrare, successivamente, “nella storia”? L’Esserci diviene storico
solo mescolandosi a circostanze ed eventi? O invece è l’essere stesso
dell’Esserci a esser tale da storicizzarsi, cosicché, soltanto perché l’Esserci è
storico nel suo essere, sono possibili circostanze, eventi e destini? […]. Primariamente
storico è l’Esserci […]. Primariamente storico, noi diciamo, è
l’Esserci. Secondariamente storico è ciò che si incontra nel mondo; non solo
il mezzo utilizzabile in senso larghissimo, ma anche l’ambiente naturale in
quanto “territorio storico” […]. Ma se il destino costituisce la storicità originaria
dell’Esserci, la storia non ha il suo centro di gravità né nel passato né nel presente e nella sua “connessione” con il passato, ma nello storicizzarsi
autentico dell’esistenza quale scaturisce dall’avvenire dell’Esserci. La storia,
in quanto modo di essere dell’Esserci, getta così profondamente le sue radici
nel futuro che è proprio la morte, come possibilità caratteristica dell’Esserci,
a rigettare l’esistenza anticipante verso il suo esser–gettato effettivo, conferendo
così all’essere–stato il suo caratteristico primato in seno alla storia.
L’essere–per–la–morte autentico, cioè la finitudine della temporalità, è il
fondamento nascosto della storicità dell’Esserci.
Lo spostarsi, in quanto cambiamento di direzione, appartiene, in linea essenziale,
all’essere–nel–mondo proprio dell’Esserci. L’Esserci è sempre in qualche
modo diretto verso... in cammino.
L’Esserci non è una semplice–presenza che, in più, possiede il requisito di
potere qualcosa, ma, al contrario, è prima di tutto un esser–possibile. L’Esserci
è sempre ciò che sa essere e nel modo della possibilità […]. L’Esserci è
la possibilità dell’essere libero per il più proprio poter–essere […]. Anche
“l’unità” del molteplice delle semplici–presenze, la natura, non è scopribile
che sul fondamento dell’apertura della sua possibilità […]. La comprensione
ha in se stessa la struttura esistenziale che noi chiamiamo progetto. Essa progetta
l’essere dell’Esserci nel suo “in–vista–di–cui” […]. Il carattere di progetto
della comprensione costituisce l’essere–nel–mondo rispetto all’apertura
del suo Ci in quanto Ci di un poter–essere. Il progetto è la costituzione ontologico–
esistenziale dell’ambito di un poter–essere effettivo. L’Esserci, in
quanto gettato, è gettato nel modo di essere del progettare […]. L’Esserci, in
quanto tale, si è già sempre progettato e resta progettante sin che è. L’Esserci si comprende già sempre e si comprenderà fin che c’è, in base a possibilità.
Nell’essere che è proprio di esso, questo ente si rapporta sempre al proprio
essere. Come ente di questo essere, esso è rimesso al suo aver–da–essere
[…]. L’Essere di cui ne va per questo ente nel suo essere, è sempre mio […].
L’ente a cui nel suo essere ne va di questo essere stesso, si rapporta al suo essere
come alla sua possibilità più propria. L’Esserci è sempre la sua possibilità,
ed esso non l’“ha” semplicemente a titolo di proprietà posseduta da parte
di una semplice–presenza. Appunto perché l’Esserci è essenzialmente la sua
possibilità, questo ente può, nel suo essere, o “scegliersi”, conquistarsi, oppure
perdersi e non conquistarsi affatto o conquistarsi solo “apparentemente”.
Ma esso può aver perso se stesso o non essersi ancora conquistato solo perché
la sua essenza comporta la possibilità dell’autenticità, cioè dell’appropriazione
di sé […]. Più in alto della realtà si trova la possibilità.
Nell’Esserci c’è sempre ancora qualcosa che manca, qualcosa che può essere,
ma non è ancora divenuto “reale”. Nell’essenza della costituzione fondamentale
dell’Esserci si ha quindi una costante incompiutezza. La non totalità significa
una mancanza rispetto al poter–essere. Nel momento preciso in cui
l’Esserci “esiste” in modo che in esso non manchi più nulla, esso è anche
giunto al suo non–Esserci–più. L’eliminazione della mancanza di essere importa
l’annichilimento del suo essere. Finché l’Esserci è come ente, non ha
ancora raggiunto la propria “totalità”; ma una volta che l’abbia raggiunta, tale
raggiungimento importa la perdita assoluta dell’essere–nel–mondo. Da allora
non è più esperibile come ente.
L’Esserci non comincia ad essere soltanto quando sia soppresso il suo “non-ancora”,
tant’è vero che proprio allora cessa di essere. L’Esserci esiste già da sempre in modo tale che
il suo “non-ancora” gli appartiene […]. L’Esserci deve, nel suo stesso essere, divenire, cioè
essere, ciò che non è ancora […]. L’Esserci, fin che è, è già sempre il suo “non-ancora” […].
Alla chiamata della coscienza corrisponde un sentire possibile. La comprensione del richiamo
si rivela come un voler-avere-coscienza. Ma in questo fenomeno ha luogo quella scelta
esistentiva di scegliere se-Stesso che noi, per la sua struttura esistenziale, chiamiamo
decisione.
L’esserci non è soltanto un ente che si presenta fra altri enti. Onticamente, esso è
piuttosto caratterizzato dal fatto che, per questo ente, nel suo essere, ne va di questo essere
stesso. La costituzione d’essere dell’Esserci implica allora che l’Esserci, nel suo essere,
abbia una relazione d’essere col proprio essere […]. La determinazione dell’essenza di
questo ente non può avere luogo mediante l’indicazione della quiddità di un contenuto
reale, in quanto la sua essenza consiste piuttosto nell’aver sempre da essere il suo essere
in quanto suo.
Il problema non può essere posto così: “In qual modo il tempo infinito “derivato”,
in cui le semplici–presenze sorgono e passano, si muta nella temporalità
originaria finita?”; ma va posto così: “In qual modo la temporalità inautentica
infinita scaturisce dalla temporalità autentica finita, e in qual modo la
temporalità inautentica temporalizza come tale un tempo infinito a partire dal tempo finito?” Solo perché il tempo originario è finito, è possibile che il tempo
“derivato” si temporalizzi come non–finito.
La decisione anticipatrice fu determinata come l’autentico essere–per la possibilità
caratterizzata come la pura e semplice impossibilità dell’Esserci. In
tale essere–per la propria fine, l’Esserci esiste autenticamente e totalmente
come l’ente che esso, “gettato nella morte”, può essere. L’Esserci non ha una
fine, raggiunta la quale semplicemente cessi, ma esiste finitamente. L’avvenire
autentico che temporalizza primariamente la temporalità e che esprime il
senso della decisione anticipatrice si rivela pertanto come anch’esso finito.
Ma allora, con la mia morte, “il tempo non andrà più oltre”? E non potranno
esserci ancora “nell’avvenire”, e provenire da esso, innumerevoli cose? A
queste domande bisogna rispondere affermativamente […]. Il carattere estatico
dell’avvenire originario sta proprio nel chiudere il poter–essere, cioè
nell’essere esso stesso chiuso e nel rendere quindi possibile la conclusiva–decisiva comprensione esistentiva della nullità. Il pervenire a se stesso autentico
e originario è il senso dell’esistere nella nullità più propria.
L’andarsi a riprendere dal Si, cioè la modificazione esistentiva del Si-stesso in
autentico essere se-Stesso, deve aver luogo come ripresa della scelta. Ma ripresa della
scelta significa scelta di quella scelta stessa, decisione per un poter-essere fondato nel
proprio se-Stesso. Scegliendo la scelta, l’Esserci rende in primo luogo possibile a se
stesso il proprio poter-essere autentico [...]. La decisione per la sua stessa natura
ontologica è sempre propria di un singolo Esserci, nella sua effettività. L’essenza di
questo ente è la sua esistenza. La decisione “esiste” solo come decidersi comprendente e
autoprogettantesi. Ma rispetto a che l’Esserci si apre nella decisione? A che deve
decidersi? La risposta può essere data solo dal decidersi stesso […]. Il decidersi è, in
primo luogo, l’aprente progettamento e la chiara determinazione delle possibilità di volta
in volta effettive. Alla decisione appartiene necessariamente l’indeterminazione che
caratterizza ogni poter-essere dell’Esserci effettivamente-gettato. La decisione è sicura di
se stessa solo in quanto decidersi. Ma l’indeterminazione esistentiva della decisione
determinantesi nel decidersi ha tuttavia la sua determinatezza esistenziale.
Nella decisione ne va per l’Esserci del suo poter–essere più proprio, il quale, in
quanto gettato, può progettarsi soltanto in possibilità determinate ed effettive.
La decisione, in cui l’Esserci ritorna su se stesso, apre le singole possibilità effettive
di un esistere autentico a partire dall’eredità che essa, in quanto gettata, assume. Il ritorno
deciso all’esser-gettato porta con sé un tramandamento di possibilità ricevute, benché non
necessariamente in quanto ricevute. Se ogni “bene” è ereditato e se il carattere dei “beni” sta
nel render possibile un’esistenza autentica, nella decisione si costituisce sempre un
tramandamento di eredità. Quanto più autenticamente l’Esserci decide, ossia quanto più si
comprende senza ombra d’equivoco a partire dalla possibilità più propria e caratteristica
nell’anticipazione della morte, tanto più il trovamento scegliente le possibilità dell’esistenza
si fa inequivoco e inarbitrario. Soltanto l’anticipazione della morte elimina ogni possibilità
casuale e “provvisoria”. Solo l’essere libero per la morte offre recisamente all’Esserci il
proprio fine e installa l’esistenza nella sua finitudine. La finitudine, una volta afferrata, sottrae l’esistenza alla molteplicità caotica delle possibilità che si offrono immediatamente
(i comodi, le frivolezze, le superficialità) e porta l’Esserci in cospetto della nudità del suo
destino. Con questo termine designiamo lo storicizzarsi originario dell’Esserci quale ha
luogo nella decisione autentica, storicizzarsi in cui l’Esserci, libero per la sua morte, si
tramanda in una possibilità ereditata e tuttavia scelta. L’Esserci è esposto ai colpi del
destino solo perché, nel fondo del suo essere, è destino nel senso suddetto. Carico di
destino, esistente nella decisione autotramandantesi, l’Esser-ci, in quanto essere-nelmondo,
è aperto al “venire in contro” delle circostanze “felici” e delle crudeltà del caso. Il
destino non nasce dallo scontro delle circostanze e dei fatti. Anche l’indeciso è colpito da
essi e talvolta più di colui che ha scelto; tuttavia, egli non può “avere” un destino. Se
l’Esserci, anticipando la morte, la erige a padrona di sé, allora, libero per essa, si
comprende nella ultrapotenza della sua libertà finita e in questa, che “consiste” sempre
nell’aver-scelto la scelta, può assumere su di sé l’impotenza dell’abbandono a se stesso e
venire in chiaro delle circostanze della situazione aperta. Ma poiché l’Esserci, carico di
destino per il fatto di essere-nel-mondo, esiste sempre e per essenza come con-essere con
gli altri, il suo storicizzarsi è un con-storicizzarsi che si costituisce come destino-comune.
Con questo termine intendiamo lo storicizzarsi della comunità, del popolo […]. Solo nella
comunicazione e nella lotta, la forza del destino-comune si rende libera […]. Solo un ente
che nel suo essere sia essenzialmente AD-VENIENTE, cosicché, libero per la propria
morte, possa, infrangendosi in essa, lasciarsi rigettare sul proprio Ci effettivo; cioè, solo
un ente che, in quanto ad-veniente, sia cooriginariamente ESSENTE-STATO, può,
tramandando a se stesso la possibilità ereditata, assumere il proprio essere-gettato ed
essere, NELL’ATTIMO, per “il suo tempo”. Solo una temporalità autentica, che è nel
contempo finita, rende possibile qualcosa come un destino, cioè una storicità autentica.
Non è necessario che la decisione conosca esplicitamente l’origine delle possibilità su cui
essa si progetta. Ma è invece nella temporalità dell’Esserci, e solo in essa, che è riposta la
possibilità di andare a prendere esplicitamente, a partire dalla comprensione dell’Esserci
tramandata, quel poter-essere esistentivo in cui esso si progetta. La decisione, ritornante
su se stessa e autotramandante, diviene allora la ripetizione di una possibilità di esistenza
trasferita. La ripetizione è il tramandamento esplicito, cioè il ritorno alle possibilità
dell’Esserci essenteci-stato. La ripetizione autentica di una possibilità d’esistenza essentestata
(il fatto che l’Esserci si scelga i suoi eroi), si fonda esistenzialmente nella decisione
anticipatrice: infatti è in essa che viene primariamente scelta quella scelta che rende liberi
per la lotta successiva e per la fedeltà a ciò che è da ripetere. Il ripente
autotramandamento di una possibilità essente-stata, non apre l’Esserci essenteci-stato a
una pura e semplice restaurazione del “passato”, né consiste in un semplice collegamento
del “presente” con ciò “che fu prima”. La ripetizione, scaturendo da un autoprogettamento
deciso, non si lascia sedurre dal “passato”, per lasciarlo ritornare come il reale di prima.
La ripetizione è piuttosto una replica alla possibilità dell’esistenza essente-ci stata. La
replica alla possibilità del decidersi, in quanto concentrata nell’attimo, è anche la revoca
di ciò che al momento sta per mutarsi in “passato” […]. Noi definiamo la ripetizione il
modo della decisione autotramandantesi mediante cui l’Esserci esiste esplicitamente come
destino.
L’esserci, una volta che si è deciso, assume autenticamente nella propria esistenza
di essere il nullo fondamento della propria nullità. Noi concepiamo esistenzialmente la
morte come la possibilità già chiarita dell’impossibilità dell’esistenza, cioè come la pura e
semplice nullità dell’Esserci […]. La nullità, che domina originariamente l’essere
dell’Esserci, gli si svela nell’essere-per-la-morte autentico.
Nella morte l'Esserci non è né compiuto né semplicemente dissolto né, tanto
meno, ultimato o disponibile. L'Esserci, allo stesso modo che, fin che è, è già
costantemente il suo “non-ancora”, è anche già sempre la sua morte. Il finire proprio della
morte non significa affatto un essere alla fine dell'Esserci, ma un essere-per-la-fine da
parte di questo ente. La morte è un modo di essere che l'Esserci assume da quando c'è.
“L'uomo, appena nato, è già abbastanza vecchio per morire” […]. L'essere per la
possibilità, in quanto essere-per-la-morte, deve rapportarsi alla morte in modo che essa, in
questo essere e per esso, si scopra come possibilità. A questo modo di essere della
possibilità noi diamo il nome di anticipazione della possibilità […]. La vicinanza
massima dell'essere-per-la-morte come possibilità coincide con la sua lontananza
massima da ogni realtà. Quanto più questa possibilità è compresa senza veli, tanto più acutamente la comprensione penetra nella possibilità in quanto impossibilità dell'esistenza
in generale. La morte, in quanto possibilità, non offre niente “da realizzare” all'uomo e
niente che esso possa essere come realtà attuale. Essa è la possibilità dell'impossibilità di
ogni comportamento verso... ogni esistere […]. Conformemente alla sua essenza, questa
possibilità non offre alcun punto d'appoggio per protendersi verso qualcosa, per “colorire”
il reale possibile e quindi obliare la possibilità. L'essere-per-la-morte come anticipazione
della possibilità, rende possibile la possibilità e la rende libera come tale. L'essere-per-la morte
è l'anticipazione di un poter-essere di quell'ente il cui modo di essere ha l'anticiparsi
stesso. Nella scoperta anticipante di questo poter-essere, l'Esserci si apre a se stesso nei
confronti della sua possibilità più estrema. Ma progettarsi sul poter-essere più proprio
significa: poter comprendere se stesso entro l'essere dell'ente così sveltato: esistere.
L'anticiparsi si rivela come la possibilità della comprensione del poter-essere più proprio
ed estremo, cioè come la possibilità dell'esistenza autentica […]. Se la decisione,
anticipandosi, ha incluso nel suo poter-essere la possibilità della morte, l’esistenza autentica
dell’Esserci non può più essere superata da nulla. Col fenomeno della decisione ci
troviamo in cospetto della verità originaria dell’esistenza. L’Esserci che ha deciso è
svelato a se stesso nel suo mutevole poter-essere effettivo […]. Inoltre il voler-aver coscienza,
determinato come essere-per-la-morte, non implica alcun atteggiamento di
distacco o di fuga dal mondo, ma porta l’Esserci, affrancato da ogni illusione, nella decisione
dell’“agire”.
Che la realtà si fondi ontologicamente nell'essere dell'Esserci, non significa che il
reale possa essere ciò che è soltanto se, e fintanto che, esiste l'Esserci. Certamente solo finché
l'Esserci è, cioè finché è la possibilità ontica della comprensione dell'essere, “c'è” essere. Se
l'Esserci non esiste, allora non “è” né l'“indipendenza”, né l'“in-sé”. Allora queste espressioni
non sono né comprensibili né incomprensibili; e l'ente intramondano non è né scopribile né
tale da poter esser-nascosto. Allora non si può dire né che l'ente ci sia né che non ci sia. È
invece ora, ossia fin che c'è la comprensione dell'essere e quindi la comprensione della
semplice-presenza, che si può dire che l'ente vi sarà ancora anche allora […]. L'Esserci, in
quanto costituito dell'apertura, è essenzialmente nella verità. L'apertura è un modo di essere
essenziale dell'Esserci. “C'è” verità solo perché e fin che l'Esserci è. L'ente è scoperto solo
quando, e aperto solo fin che, in generale, l'Esserci è. Le leggi di Newton, il principio di non
contraddizione, ogni verità in generale, sono veri solo fin che l'Esserci è. Prima che l'Esserci,
in generale, fosse e dopo che l'Esserci, in generale, non sarà più, non c'era e non ci sarà verità
alcuna, poiché la verità, in quanto apertura, scoprimento ed esser-scoperto non può essere
senza che l'Esserci sia […]. Che ci siano delle “verità eterne” potrà essere concesso come
dimostrato solo se sarà stata fornita la prova che l'Esserci era e sarà per tutta l'eternità. Finché
questa prova non sarà stata fornita, continueremo a muoverci nel campo delle fantasticherie
che non accrescono il loro credito per il fatto d'essere generalmente “credute” dai filosofi.
Con l'esistenza dell'essere-nel-mondo storico, l'utilizzabile e la semplice-presenza
sono già sempre coinvolti nella storia del mondo. I materiali e le opere, i libri ad esempio,
hanno il loro “destino”; costruzioni e istituzioni hanno la loro storia. Ma anche la natura è
storica. Certamente non nel senso in cui noi parliamo di “storia naturale”, ma come
paesaggio, come luogo di coltivazione e di espansione, come campo di battaglia e come luogo
di culto.
La condizione esistenziale-temporale della possibilità del mondo sta nel fatto che la
temporalità, in quanto unità estatica, ha qualcosa come un orizzonte. Le estasi non sono
semplicemente un “esser-fuori-da...”. Esse importano in primo luogo un “verso-dove” dell’“esser-fuori” [...]. Sul fondamento della costituzione orizzontale dell’unità estatica della temporalità,
qualcosa come un mondo aperto appartiene a quell’ente che è sempre il suo Ci. Allo stesso
modo che nell’unità estatica della temporalizzazione della temporalità il presente scaturisce
dall’avvenire e dall’essere stato, così, con gli orizzonti dell’avvenire e dell’essere-stato, si
temporalizza cooriginariamente quello del presente. Temporalizzandosi l’Esserci, anche un
mondo è […]. Se non esistesse alcun Esserci, non “ci” sarebbe neppure alcun mondo […]. Il
mondo è trascendente e lo è sul fondamento dell’unità estatica della temporalità. Il mondo
deve essere già estaticamente aperto perché sia possibile incontrare in esso l’ente intramondano
[…]. Con l’esistenza effettiva dell’Esserci, si incontra anche già l’ente intramondano.
“Che” un ente siffatto sia già scoperto col Ci dell’esistenza, non è a discrezione dell’Esserci.
Sono a disposizione della sua libertà, benché sempre nei limiti del suo esser-gettato, solo il
“che cosa” esso possa via via scoprire e aprire, nonché la direzione, l’ampiezza e il modo di questo scoprimento e di questo aprimento.
Dell’essenza del Fondamento
Vom Wesen des Grundes, 1929
Edizione italiana: in, Segnavia, Adelphi, Milano 1987
Nell’accezione terminologica che qui ci proponiamo di chiarire
e di giustificare,
la trascendenza significa qualcosa che è proprio dell’esserci
umano, non
però come un suo comportamento possibile fra altri, talvolta
attuato, talvolta
no, ma come costituzione fondamentale di questo ente che
precede qualsiasi
comportamento […]. Nell’oltrepassamento, l’esserci perviene
anzitutto a
quell’ente che esso è, e vi perviene come a se
“stesso”. La trascendenza costituisce
l’ipseità [...]. Ciò rispetto a cui l’esserci, come tale,
trascende, noi lo
chiamiamo il mondo, e determiniamo ora la trascendenza
come essere–nel–mondo. Il mondo è costitutivo della
struttura unitaria della trascendenza; in
quanto fa parte di essa, diciamo che il concetto di mondo è
trascendentale
[…]. In che senso dimora nella trascendenza l’intrinseca
possibilità di qualcosa
come il fondamento in generale? Il mondo si dà all’esserci come
la rispettiva
totalità dell’“in vista di” se stesso […]. In questo modo
l’esserci può
essere in rapporto con se stesso in quanto tale, solo se
oltrepassa “se stesso”
nell’“in vista di”. Questo oltrepassamento “in vista di” accade
solo in una
“volontà” che, come tale, si progetta nelle sue possibilità.
Questa volontà,
che per essenza progetta e quindi getta oltre l’esserci l’“in
vista di” se stesso,
non può dunque essere un volere determinato, un “atto di volontà”
da distinguere
da altri comportamenti […]. Ora, qualcosa che, secondo la sua
essenza,
progettando, anticipa in generale qualcosa come l’“in vista di”,
e non lo produce
come un risultato occasionale, lo chiamiamo libertà.
L’oltrepassamento
verso il mondo è la libertà stessa. Ne consegue che la
trascendenza non si imbatte nell’“in vista di” come un un valore
o in un fine per sé sussistenti, ma è la
libertà, proprio in quanto libertà, a pro–porre a se
stessa l’“in vista di”. In questo
trascendente autoproporsi l’“in vista di”, l’esserci accade
nell’uomo, cosicché
questi, nell’essenza della sua esistenza, può essere obbligato a
sé, cioè essere
un se stesso libero [...]. Solo la libertà può lasciare che
all’esserci un mondo
si imponga e si faccia mondo. Il mondo, infatti, non
è mai, ma si fa mondo […].
La libertà è il fondamento del fondamento […]. Ma in
quanto è questo fondamento,
la libertà è il fondo abissale dell’esserci. Non nel
senso che il singolo
comportamento libero sia senza fondamento, ma nel senso che la
libertà, che
nella sua essenza è trascendenza, pone l’esserci, come poter–
essere, in possibilità
che si spalancano davanti alla sua scelta, cioè al suo destino.
Ma l’esserci,
oltrepassando l’ente nel suo progetto di un mondo, deve
oltrepassare se stesso
per potere, da questa altezza, comprendere se stesso
come fondo abissale.
Siccome il fondare che istituisce è il progetto delle proprie
possibilità, in esso
l’esserci si slancia ognora in avanti. In conformità
alla sua essenza, il progetto
delle possibilità è via via più ricco del possesso in cui il
progettante si
trova già precedentemente. Ma un simile possesso appartiene
all’esserci perché,
in quanto progettante, esso si sente situato in mezzo all’ente.
Con ciò sono
già sottratte all’esserci determinate altre possibilità,
e precisamente solo
per la sua fatticità. Ma proprio questa sottrazione di
certe possibilità al suo
poter–essere–nel–mondo, inclusa nel coinvolgimento nell’ente, è
ciò che pone
di fronte all’esserci, come costitutive del suo mondo,
le possibilità “realmente” coglibili nel progetto di un mondo.
In corrispondenza ai due modi di fondare, la trascendenza è
ad un tempo uno
slancio in avanti e una sottrazione. Il fatto che il
progetto di un mondo, slanciandosi
in avanti, acquisti forza e diventi un possesso solo nella
sottrazione,
è una testimonianza trascendentale della finitezza della
libertà dell’esserci.
Ogni progetto di un mondo è dunque un progetto gettato.
La chiarificazione
dell’essenza della finitezza dell’esserci, che prende le
mosse dalla costituzione del suo essere, deve precedere tutte le
“ovvie” posizioni della “natura” finita dell’uomo, tutte le
descrizioni delle proprietà derivanti dalla finitezza, e quindi
anche più che mai tutte le “spiegazioni” avventate circa la loro
provenienza ontica. L’essenza della finitezza dell’esserci si
svela nella trascendenza come libertà di fondamento. E
così l’uomo, che come trascendenza esistente si slancia in avanti
verso delle possibilità, è un essere della lontananza.
Solo attraverso lontananze originarie che egli si forma nella sua
trascendenza rispetto a ogni ente, cresce in lui la vera
vicinanza alle cose”.
Che cos’è la Metafisica?
Was ist Metaphysik?, 1923 (Vittorio Klostermann, 1943)
Edizione italiana: La Nuova Italia, Firenze 1979
Come e che cos’è il Niente? Già al
primo presentarsi della domanda, avvertiamo
qualcosa di strano: noi ammettiamo in precedenza il
niente come qualcosa
che “è” così e così — come un essente. E tuttavia esso è
del tutto, assolutamente,
altra cosa. Far questione del niente — che cosa e come esso sia —
è convertire ciò di cui si fa questione nel suo contrario. La
questione si priva
da se stessa del suo oggetto […]. La norma del pensare in
generale comunemente
accettata, la “Logica” universale col suo principio di non
contraddizione,
sopprime la questione, poiché il pensiero — che è sempre
essenzialmente
pensiero di qualcosa — dovrebbe qui agire contro il suo
proprio essere
come pensiero del niente. E però, essendoci negato in
generale di prendere ad
oggetto il niente, non ci sarebbe più niente da fare — nel
presupposto, tuttavia,
che in questa questione la “Logica” rappresenti la suprema
istanza, e che
l’intelletto sia il mezzo, e il pensiero la via, per comprendere
originariamente
il niente e decidere del suo possibile disvelamento. La
supremazia della “Logica
” si può mettere in dubbio? Non è l’intelletto realmente
l’arbitro supremo
in questa questione intorno al niente?
Poiché il niente è la negazione di tutto l’essente,
l’assoluto non–essente, noi
portiamo, così, il niente sotto la superiore determinazione di
ciò che è affetto
di nullità, e però negato. Ma il negare è, secondo la
dominante e non mai
messa in dubbio teoria della “Logica”, una specifica operazione
dell’intelletto. Come possiamo, dunque, noi volere, nella
questione del niente,
anzi nella questione della sua questionabilità stessa, mettere da
parte
l’intelletto? Eppure, è proprio sicuro ciò che qui presupponiamo?
Il non, la
negatività, e però la negazione, rappresenta la determinazione
superiore, sotto
la quale cade il niente come modo particolare del negato? C’è
il niente soltanto
perché c’è il non, ossia la negazione? O viceversa: c’è la
negazione e il non, soltanto perché c’è il niente? […] Noi
affermiamo: il niente è più originario del non e della
negazione.
Comunque sia di ciò, certo è che noi conosciamo il niente,
sebbene solo in
quanto di esso, per un verso o per l’altro, parliamo ogni giorno.
Questo volgare
niente, che così inavvertitamente si insinua nei nostri discorsi,
scolorito
nell’incolore uniformità dell’evidenza, noi ce lo possiamo
finanche, brevi
manu, aggiustare in una “definizione” così: il niente è la
negazione pura e
semplice di tutto l’essente. Non dà, alla fine, questa
caratteristica del niente,
un’indicazione della direzione, dalla quale soltanto, esso può
venirci incontro?
Il tutto dell’essente deve essere già dato per poter,
come tale, cadere vittima
della negazione semplicemente, sì che in questa potrà, poi, far
la sua
comparsa il niente stesso.
Tuttavia, anche se prescindiamo dalla dubbia questione del
rapporto tra la
negazione e il niente, come possiamo noi, esseri finiti, far
accessibile in sé e
soprattutto a noi, l’insieme nell’essente nella sua totalità? Noi
possiamo,
tutt’al più, pensare la totalità dell’essente nell’“idea”, e,
formatala, così nel
pensiero, negarla e “pensarla” negata. Certo, su questa strada
noi acquistiamo
il concetto formale del niente così formato: non mai, tuttavia,
il niente stesso.
Ma il niente è niente, e tra il niente “vero e proprio” e quello
da noi formato
può non sussistere differenza solo a patto che il niente
rappresenti la perfetta
indifferenza.
Si verifica realmente nell’essere esistenziale dell’uomo un
tale stato, in cui egli sia portato innanzi al niente stesso?
Esso può verificarsi
realmente e — sebbene abbastanza di rado — soltanto in momenti di
quella
disposizione fondamentale che è l’angoscia […].
L’indeterminazione di ciò
di cui e per cui noi ci angosciamo, non è mero difetto di
determinazione, ma
un’essenziale impossibilità di determinazione […]. Nell’angoscia
[…] non
resta alcun sostegno; resta solo e ci piomba addosso — nello
scomparire
dell’essente — questo “nessuna cosa a cui appigliarsi”.
L’angoscia rivela il
niente. Nell’angoscia noi “siam sospesi”. Meglio: l’angoscia
ci tien sospesi,
perché porta l’essente nella sua totalità a scomparire.
Il niente si scopre nell’angoscia —, ma non come
essente; e tanto meno vien
dato come oggetto. L’angoscia non è affatto una comprensione del
niente.
Tuttavia il niente si fa per essa e in essa manifesto, sebbene
non come se il
niente si mostrasse, per suo conto, “accanto” all’essente nella
totalità immanente
a tale sgomento. Noi diremo piuttosto: il niente viene incontro
nell’angoscia in uno con la totalità dell’essente. Che
significa questo “in uno
con”? Nell’angoscia l’essente come totalità diventa
vacillante. In qual senso
ciò avviene? L’essente non viene annullato
nell’angoscia, sì che resti, così, il
niente […]. Il niente, anzi, si attesta proprio, con e
nell’essente, in quanto essente
che ci sfugge e scompare nella totalità. Nell’angoscia non
avviene nessun
annullamento dell’essente totale in sé, e tanto meno noi
compiamo una
negazione dell’essente nella sua totalità per
conquistare una buona volta il
niente […]. Nell’angoscia c’è un retrocedere innanzi a … […].
Questo “retro–
innanzi” prende le sue mosse dal niente. Questo non trae a sé,
anzi respinge
essenzialmente. Ma il suo respingere da sé è, come tale, un
rimandare
a ciò che, respingendo, fa scomparire: un rimandare all’essente
che affonda
nella totalità. Questo respingere che è un rimandare all’essente
scomparente
nella totalità, qual è quando nell’angoscia il niente preme
l’esistenza, è
l’essenza del niente: il nientificare. Non è un
annullare l’essente, né deriva da
una negazione. Il nientificare non si può ridurre all’annullare e
al negare. Qui
è il niente, proprio esso, che nientifica, e nientificare
non è un accidente pur
che sia, ma, in quanto respinge rimandando all’essente che
scompare nella totalità,
rivela questo essente, nella sua piena e fino allora nascosta
straneità,
come l’assolutamente altro — dirimpetto al niente. Nella
chiara notte del
niente dell’angoscia spunta l’originaria rivelazione
dell’essente come tale:
che è essente, cioè — e non niente. Questa
aggiunta “e non niente” non è affatto
un chiarimento aggiunto dopo al discorso, ma è, anzi, il
precedente che
rende possibile la rivelazione dell’essente in generale.
L’essenza
dell’originario niente nientificante è qui: esso porta
l’essere esistenziale originariamente
innanzi all’essente come tale. Solo sul fondamento
dell’originario
rivelarsi del niente, l’essere esistenziale dell’uomo può
dirigersi verso
ciò che è, e penetrare in esso […]. Il niente, come “altro”
dall’essente, è il velo
dell’Essere.
Esserci vuol dire: trovarsi ritenuti interiormente
al niente. Tenendosi interiormente
al niente l’essere esistenziale è già sopra e al di là
dell’essente nella
totalità. Questo essere “al di là e sopra” l’essente noi lo
chiamiamo Trascendenza.
Se l’essere esistenziale nel fondo della sua essenza non
trascendesse,
ossia — come ora possiamo dire — non si tenesse interiormente sin
da
principio nel niente, non potrebbe mai riferirsi all’essente, e
però neanche a
se stesso. Senza un’originaria rivelazione del niente non c’è
un essere se
stesso, non c’è libertà.
Si è, così, ottenuta la risposta alla questione sul niente: esso
non è un oggetto, né
in generale un essente; esso non si presenta per sé, né accanto
all’essente, al quale
pure inerisce. Il niente è la condizione che fa possibile la
rivelazione dell’essente
come tale per l’essere esistenziale dell’uomo. Il niente non
dà soltanto il concetto
opposto a quello di essente, ma appartiene originariamente
all’essenza dell’essere
stesso. Il nientificare del niente avviene nell’essere
dell’essente.
“Il puro essere e il puro niente è, dunque, lo stesso”. Questa
sentenza dello
Hegel è giusta. Essere e niente coincidono, ma non perché
entrambi — guardati
dal punto di vista del concetto hegeliano del pensiero —
concordano nella
loro indeterminatezza e immediatezza; ma perché l’essere stesso è
limitato
essenzialmente, e si rivela soltanto nella trascendenza
dell’essere esistenziale
che si trova tenuto dentro al niente.
L’essere esistenziale umano può riferirsi all’essente soltanto se
si tiene dentro al
niente: l’uscir fuori dall’essente, per vederlo dall’alto,
avviene nell’essenza
dell’essere esistenziale. Questa uscita è la Metafisica stessa.
Ed ecco che la Metafisica
appartiene alla “natura dell’uomo” […]. La Metafisica è
l’accadimento
fondamentale nell’essere esistenziale. Essa è l’essere
esistenziale stesso.
Sull’essenza della verità
Vom Wesen der Wahrheit, 1930
Edizione italiana: Editrice La Scuola, Brescia 1977
La libertà è stata da noi poc’anzi definita come libertà per
l’apertura di ciò che
si manifesta. A questo punto, come bisogna pensare questa essenza
della libertà?
Ciò che si manifesta, e a cui un giudizio appresentante si adegua
come ad
una norma, è l’ente che, di volta in volta, è manifesto in un
rapportarsi che si
mantiene nell’apertura. La libertà nei confronti di ciò che si
manifesta nell’apertura lascia che l’ente sia sempre quell’ente
che è. La libertà ora si scopre
come il lasciar–essere l’ente.
Il senso che qui è necessario conferire all’espressione:
lasciar–essere l’ente,
non si riferisce al tralasciare e all’indifferenza, ma al suo
contrario. Lasciar–
essere significa: affidarsi all’ente. Questo affidarsi non è da
intendere, ancora
una volta, come un mero avere–a–che–fare o un mero aver–cura, nel
senso di
custodire o inserire in un piano l’ente che di volta in volta si
incontra o si cerca.
Lasciar–essere — nel senso di lasciar–essere l’ente come
quell’ente che è
— significa affidarsi a ciò che è manifesto e alla sua
manifestazione, in cui
ogni ente entra e dimora, e che ogni ente che si manifesta porta
ad un tempo
con sé. Questo manifestarsi dell’ente è stato concepito dal
pensiero occidentale,
fin dall’inizio, come tà alethéa, il non nascosto. Se
noi traduciamo
alétheia, invece che con “verità”, con “non–
nascondimento”, allora questa
traduzione non è solamente “più letterale”, ma contiene anche
l’indicazione di
pensare e ripensare il concetto abituale di verità, nel senso
della conformità
del giudizio, in quella luce, non ancora compresa, dell’esser–
svelato e dello
svelamento dell’ente. L’affidarsi all’esser–svelato dell’ente non
è un perdersi
in esso, ma è un dispiegare uno sfondo, tirandosi indietro,
davanti all’ente, in
modo che questo si manifesti in ciò che esso è, e come è, sicché
l’adeguazione
appresentativa possa prendere da esso la misura della conformità.
Così inteso,
il lasciar–essere è un es–porsi all’ente come tale, è un porre
ogni rapportarsi in
ciò che è manifesto. Il lasciar–essere, ossia la libertà, è
l’ek–sistente che in sé
si espone. Vista alla luce dell’essenza della verità, l’essenza
della libertà si rivela
come l’es–porsi nell’essere–svelato dell’ente.
L’ek–sistenza, radicata nella verità come libertà, è la es–
posizione
dell’essere–svelato dell’ente in quanto tale. Non ancora
compresa, e neppure
bisognosa di una fondazione essenziale, l’ek–sistenza dell’uomo
storico incomincia
in quell’istante in cui il primo pensatore, ponendosi il problema
della
non–ascosità dell’ente, si domanda: che cos’è l’ente. L’ente
nella sua totalità
si scopre come phýsis, la “natura, che qui non significa
ancora un ambito
particolare dell’ente, ma l’ente come tale nella sua totalità, e
precisamente nel
senso di una presenza che si apre. Solo quando l’ente stesso è
elevato e custodito
nella sua non–ascosità, e solo quando questa custodia è intesa a
partire
dalla domanda sull’ente in quanto tale, solo allora nasce la
storia. L’iniziale
disvelamento dell’ente nella sua totalità, il problema relativa
all’ente come tale e
l’inizio della storia occidentale coincidono e sono simultanei in
un “tempo” che,
non misurabile esso stesso, dischiude l’apertura in cui parte
ogni misura.
Poiché la verità è, in essenza, libertà, l’uomo storico può
anche, nel lasciar–
essere l’ente, non lasciarlo essere come quell’ente che è e nei
termini in cui è.
In questo caso l’ente è coperto e travisato. L’apparenza si
impone e con essa
compare la non–essenza della verità. Ma poiché la libertà ek–
sistente come
essenza della verità non è una proprietà dell’uomo, ma l’uomo
ex–siste solo se
posseduto da questa libertà e così solamente diviene capace di
storia, la non–essenza della verità non può sorgere
successivamente dalla semplice incapacità
o dalla negligenza dell’uomo. La non–verità, al contrario, deve
derivare
dall’essenza della verità. È solo perché la verità e la non–
verità non sono affatto
indifferenti l’una all’altra nell’essenza, ma si
appartengono reciprocamente,
che una proposizione vera può presentarsi in netta opposizione
con la
correlativa proposizione non–vera.
Detta totalità accordante non è un nulla, ma un nascondimento
dell’ente in totalità.
Proprio mentre il lasciar–essere lascia essere l’ente al quale si
riferisce
in un particolare rapporto, e così lo svela, proprio allora
nasconde l’ente in totalità.
Il lasciar–essere è quindi in sé, ad un tempo, un velare.
Nell’ek–sistente
libertà dell’esser–ci avviene il nascondimento dell’ente in
totalità, si realizza
così il nascondersi.
Il nascondimento dell’ente in totalità, che è la vera e propria
non–verità, è antecedente
a ogni manifestazione di questo o quell’ente, anzi, precede anche
lo
stesso lasciar–essere che, mentre svela, già tiene nascosto e al
nascondimento
si rapporta. Che cosa custodisce il lasciar–essere in quel
rapporto al nascondimento?
Niente di meno che il nascondimento dell’ente come tale, nascosto
nella sua totalità, vale a dire: il mistero. Non si tratta di un
particolare mistero
relativo a questa cosa o a quell’altra, ma di quell’unico mistero
(il nascondimento
del nascosto) che in generale penetra e domina come tale
l’esser–ci
dell’uomo. Nel lasciar–essere che, mentre svela, nasconde l’ente
in totalità, il
nascondimento si realizza dapprima come nascondimento di ciò che
è nascosto.
L’esser–ci, in quanto ek–sistente, custodisce il primo e più
ampio non–svelamento, la vera e propria non–verità. L’autentica non–essenza
della verità
è il mistero. Non essenza qui non significa ancora una
degradazione
dell’essenza in ordine all’universale (koinón, génos),
alla sua “possibilitas”
(possibilità) e al suo fondamento. Non–essenza qui significa
essenza pre–
essenziale.
Quando noi riconduciamo l’intera possibilità della conformità di
un giudizio
all’ek–sistente libertà del lascia–essere come suo “fondamento” e
quando insieme
chiariamo che l’origine essenziale di questo fondamento è nel
nascondimento
e nell’errare, intendiamo con ciò indicare che l’essenza della
verità
non è la vuota “generalità” di una universalità “astratta”, ma
quell’Unico che
si nasconde nell’unica storia che scopre il “senso” di ciò che
noi chiamiamo
essere, e che da lungo tempo siamo abituati a pensare solo come
l’ente in totalità.
Verità significa quel luminoso nascondersi che è il tratto
fondamentale
dell’essere. Il problema relativo all’essenza della verità trova
la sua risposta in
questa proposizione: l’essenza della verità è la verità
dell’essenza […]. All’essere,
infatti, appartiene un luminoso nascondersi, l’essere appare
originariamente
nella luce di un sottrarsi che nasconde. Il nome di questa luce è
alétheia.
L’Autoaffermazione dell’Università tedesca
Il rettorato 1933/34
Die Selbstbeauptung der deutschen Universität
Das Rektorat 1933/34
Edizione italiana: il melangolo, Genova 1988
Se vogliamo cogliere l’essenza della scienza, non possiamo non
porci la questione decisiva: se debba esserci ancora per
noi scienza o se dobbiamo lasciarla precipitare verso una rapida
fine. Che in generale debba esserci scienza, non è in nessun caso
incondizionatamente necessario. Ma se deve esserci e deve esserci
per noi e grazie a noi, allora a quale
condizione deve esistere veramente? Alla condizione di sottoporre
noi stessi, di nuovo alla potenza dell’inizio del nostro
essere storico-spirituale. Questo inizio è l’irruzione della
filosofia greca. In quel punto della sua storia, per la prima
volta, l’uomo occidentale sulle salde fondamenta di una stirpe in
virtù del suo linguaggio, fronteggia l’essente nella sua totalità
e lo interroga e lo comprende come l’essente che esso è. Ogni
scienza è filosofia, che lo sappia e lo voglia, oppure no. Ogni
scienza resta vincolata all’inizio della filosofia. Da esso la
scienza trae la forza della propria essenza, posto che di tale
inizio sia all’altezza.
Noi vogliamo qui, in questa sede, riconquistare al
nostro esserci due caratteristiche dimensioni
dell’essenza originariamente greca della scienza. Presso i greci
circolava un antico resoconto secondo cui Prometeo sarebbe stato
il primo filosofo. A Prometeo Eschilo attribuisce una sentenza
che esprime l’essenza del sapere: Téchne d’anánkes
asthenetéra makrõ. “Ma il sapere è molto più debole della
necessità”. Il che vuol dire: ogni sapere intorno alle cose è
innanzitutto alla mercé della tracotante ultra-potenza del
destino, e votato a fallire di fronte ad essa. Ma allora, per
fallire realmente, il sapere deve trarre da sé e dispiegare la
sua suprema ostinazione e caparbietà, grazie alla quale l’intera
potenza della ascosità dell’essente insorge e si dischiude. Così
in vero l’essente si manifesta nella sua insondabile sovranità e
dà al sapere la su verità.
Per i greci la scienza non è un bene culturale, ma il cuore, il
centro più interno dell’intero esserci del popolo e dello stato.
Scienza non è per i greci neppure il puro strumento grazie a cui
ci si rende consapevoli di ciò che non si sa, ma la potenza che
rende acuto e penetrante l’intero esserci e lo domina totalmente.
Scienza è l’interrogante star-saldi nel cuore della totalità
dell’essente che costantemente si cela. E tale attivo perseverare
è consapevole della sua impotenza di fronte al destino. Questa è
l’essenza originaria della scienza.
Ma non sono trascorsi due millenni e mezzo da quell’inizio? Non
ha forse il progresso umano mutato anche la scienza? Certo! Tanto
la concezione teologico-cristiana del mondo che è seguita a
quell’inizio, quanto il più tardo pensiero tecnico-matematico
dell’età modera hanno effettivamente e nel tempo allontanato la
scienza dal suo inizio. Ma non per questo quell’inizio è stato
superato e tanto meno nientificato. Poiché, se si è d’accordo che
l’originaria scienza greca è un evento grandioso, allora il suo
inizio è ciò che in esso vi è di più grande. L’essenza
della scienza non potrebbe venir svuotata e messa fuori uso, come
accade oggi a dispetto di tutti i risultati e della stessa
“organizzazione internazionale”, se la grandezza dell’inizio non
fosse ancora presente.
L’inizio è ancora. Non è alle nostre spalle,
come un evento da lungo tempo passato, ma ci sta di fronte,
davanti a noi. L’inizio, in quanto ciò che vi è di più
grande, precede tutto ciò che è sul punto di accadere e così è
già passato oltre noi, al di sopra di noi. L’inizio è iscritto
nel nostro futuro, ci è di fronte come l’ingiunzione che da
lontananze remote ci chiama a riconquistare di nuovo la sua
grandezza.
Solo se, obbedendo a tale ingiunzione, ci disponiamo a
riconquistare la grandezza dell’inizio, la scienza diviene la più
intima necessità dell’esserci. Diversamente essa resta un fatto
del tutto casuale in cui siamo coinvolti, oppure il tranquillo
diletto di un’occupazione senza rischi che risponde all’esigenza
di un mero accrescimento di conoscenze. Ma se ci disponiamo alla
remota ingiunzione dell’inizio, allora la scienza deve essere
l’evento fondamentale del nostro esserci spirituale-
patriottico.
Se dunque vogliamo l’essenza della scienza nel senso
dell’interrogare star saldi allo scoperto nel cuore
dell’estrema problematicità dell’intero essente, allora
questa volontà d’essenza è in condizione di procurare al
nostro popolo il suo mondo, in cui domina il rischio più intimo e
più estremo, cioè il suo mondo veramente spirituale.
Infatti “spirito” non è né mero ingegno, né il disinvolto gioco
dell’intelligenza, né l’arte di promuovere illimitatamente
distinzioni logiche, né la ragione che governa il mondo, ma
spirito è decisione originariamente e consapevolmente determinata
verso l’essenza dell’essere. E il mondo spirituale di popolo non
è la sovrastruttura di una cultura, tantomeno l’arsenale in cui
vengono di volta in volta conservati conoscenze e valori, che vi
entrano ed escono continuamente, ma è la potenza che scaturisce
dalla più profonda conservazione delle sue forze fatte di terra e
di sangue, potenza che provoca la più intima commozione e il più
ampio sommovimento del suo esserci. Solo un mondo spirituale è
per un popolo garanzia di grandezza. Infatti lo costringe a far
sì che la costante decisione tra volontà di grandezza e
tentazione di decadenza divenga la legge che regola il passo
nella marcia che il nostro popolo ha iniziato verso la sua storia
futura.
Solo la lotta tiene aperto il contrasto e radica nell’intero
corpo di studenti e professori quella disposizione fondamentale a
partire da cui l’autoaffermazione che assegna a sé i propri
limiti, potenzia la decisiva autoriflessione fino a farne genuina
autonomia. Vogliamo o no l’essenza dell’università tedesca?
Dipende essenzialmente da noi se e come impegnare radicalmente e
non casualmente le nostre forze per l’autoriflessione e
l’autoaffermazione – oppure pur con le migliori intenzioni ci
limitiamo soltanto a mutare vecchi e superati indirizzi e a
introdurne di nuovi. Nessuno può impedirci di fare ciò. Ma
nessuno ci interpellerà: “lo volete o no?”, quando la forza
spirituale dell’occidente precipiterà verso il fallimento,
crollerà nelle sue strutture e una moribonda cultura stramazzerà
al suolo e spingerà tutte le forze nella confusione e le lascerà
cadere nella follia.
Che ciò possa accadere o meno dipende dalla nostra volontà, dal
nostro volere noi stessi ancora e di nuovo come popolo storico
spirituale – oppure dal nostro non volerlo –. Ognuno di noi nella
sua singolarità e individualità irripetibile decide su ciò, anche
quando e proprio quando evita di decidere, allorché si ritrae di
fronte a questa decisione. Ma noi vogliamo che il nostro popolo
compia per intero la sua missione storica. Noi vogliamo noi
stessi. Così ha già deciso la giovane e giovanissima forza del
popolo che si muove e che si è posta in cammino al di sopra di
ognuno di noi. Ma comprenderemo interamente la nobiltà e la
grandezza di questa riscossa allorché e solo allorché avremo
iscritto nei nostri cuori quella profonda e ampia riflessione da
cui l’antica saggezza greca trasse la sentenza:
tà… megála pánta episphalê …
Tutto ciò che è
grande … è nella tempesta.
Introduzione alla Metafisica
Einführung in die Metaphysik, 1935
Edizione italiana: Mursia, Milano 1987
Per comprendere la nostra affermazione che il porsi
“metafisico” della domanda
preliminare è radicalmente e totalmente storico, è anzitutto
necessario
riflettere sul fatto che la storia non significa per noi
semplicemente il passato,
poiché questo è precisamente ciò che non avviene più. Ma la
storia rappresenta
ancor meno la mera attualità, la quale neppure essa accade ma
“passa”
semplicemente, ossia sopravvive e trascorre. La storia come
accadere è un
determinarsi a partire dal futuro assumendo il passato, e così
agendo e patento
attraverso il presente. È questo presente che dilegua
nell’accadere. Il fatto
di proporci la domanda metafisica fondamentale costituisce
qualcosa di storico
in quanto, in virtù di ciò, l’accadere dell’essere umano, nei
suoi rapporti
essenziali, ossia nei suoi rapporti con l’essente come tale nella
sua totalità, risulta
aperto su possibilità e su futuri imperscrutati, e così
ricollegato al suo
inizio e reso più acuto e più grave nel suo presente. In questo
domandare, il
nostro essere è convocato davanti alla storia, nel senso pieno
della parola, è
chiamato ad essa e a decidersi in essa.
Non è infatti ancora per nulla pacifico che la logica e le sue
regole fondamentali siano
in grado di offrirci, in generale, un criterio per il problema
dell’essente come tale. Potrebbe
essere, al contrario, che tutta la logica da noi conosciuta, e
considerata come piovuta dal cielo, si fondi già su una
determinata e particolare risposta alla domanda sull’essente,
tale che ogni pensiero che ubbidisce solamente alle regole della
logica tradizionale si trovi fin da principio nell’impossibilità
anche solo di comprendere, in generale, la domanda circa
l’essente, e tanto più nell’impossibilità di svilupparla
realmente e di pervenire a una risposta. Non c’è in realtà che
un’apparenza di rigore scientifico nell’appellarsi al principio
di non contraddizione e in generale alla logica per provare che
ogni pensiero e discorso sul nulla è contraddittorio e perciò
privo di senso. La logica è considerata, da questo punto di
vista, come un tribunale eterno, di cui, naturalmente, nessun
uomo ragionevole può mettere in dubbio la giurisdizione nella sua
competenza di prima e ultima istanza. Chi parla contro la logica
è conseguentemente, in modo tacito o espresso, sospettato di
arbitrio […]. È purtuttavia certo che non si può parlare né
discutere del nulla come se si trattasse si una cosa: della
pioggia che scroscia di fuori, di una montagna o, in genere, di
un qualsiasi oggetto. Il nulla permane fondamentalmente
inaccessibile a ogni scienza. Chi vuole davvero parlare del nulla
deve necessariamente rinunciare all’atteggiamento scientifico. Ma
ciò costituisce una grossa disgrazia solo fintantoché sussiste
l’opinione che il pensiero scientifico sia il solo vero e
autentico pensiero rigoroso e che esso possa e debba venire
assunto come criterio unico anche del pensiero filosofico. È in
realtà vero il contrario. Ogni pensiero scientifico è solo una
forma derivata, e con ciò stesso irrigidita, del pensiero
filosofico. La filosofia non nasce dalla scienza né grazie alla
scienza. La filosofia non si lascia mai coordinare con le
scienze. Essa è loro piuttosto sovraordinata, e ciò non solo dal
punto di vista logico o relativamente a un piano sistematico
delle scienze. La filosofia si trova in tutt’altra zona e in
tutt’altro grado dell’esistenza spirituale. Solo la poesia
appartiene al medesimo ordine della filosofia e del suo modo di
pensare […]. Nel poetare del poeta come nel pensare del pensatore
vengono ad aprirsi così grandi spazi che ogni singola cosa: un
albero, una montagna, una casa, un grido d’uccello, vi perde
completamente il proprio carattere insignificante e
abituale.
Ma il fatto è che è proprio dell’essenza della filosofia di
rendere le cose non più
facili, bensì più difficili. E questo non a caso: infatti il suo
modo di comunicare appare
inconcepibile e addirittura pazzesco per il senso comune. Il
compito vero della filosofia
consiste in realtà piuttosto nell’appesantimento
(Erschwerung) dell’esserci storico, e, in
ultima analisi, dell’essere stesso. L’appesantimento conferisce
alle cose, all’essente, il
loro peso (d’essere). E questo perché? Perché l’appesantimento
costituisce una delle
condizioni fondamentali, essenziali, per la nascita di tutto ciò
che è grande: in primo
luogo il destino di un popolo storico e delle sue opere. Destino
però c’è solo là dove un
vero sapere sulle cose domina l’esistenza. Le vie e le
prospettive di un tal sapere sono
aperte dalla filosofia.
Allora troveremo che tale peculiare domandare sul perché si basa
su di un salto (Sprung) mediante il quale l’uomo
abbandona ogni anteriore sicurezza, vera o presunta, nei riguardi
del proprio essere (Dasein). Questa domanda si pone solo
nel salto e come salto, o non si pone affatto […]. Il salto,
proprio di questo domandare, fa sorgere (er–springt) a
se stesso il proprio fondamento, lo realizza nel salto. Un tale
salto capace di prodursi come fondamento lo chiamiamo un salto
originario (Ur–sprung) nel vero senso della parola: il
far sorgere a se stesso il proprio fondamento (das Sich–den–
Grund–er–springen).
Lettera sull’“umanismo”
Brief über den »Humanismus«, 1946
Edizione italiana: in Segnavia, Adelphi, Milano 1987
Noi non pensiamo ancora in modo abbastanza decisivo l’essenza
dell’agire. Non
si conosce l’agire se non come il produrre un effetto la cui
realtà è valutata in base alla sua
utilità. L’essenza dell’agire, invece, è il portare a compimento.
Portare a compimento
significa: dispiegare qualcosa nella pienezza della sua essenza,
condurre-fuori a questa
pienezza, pro-ducere.
Il pensiero, detto semplicemente, è il pensiero dell’essere. Il
genitivo vuol dire
due cose. Il pensiero è dell’essere in quanto, fatto avvenire
dall’essere, all’essere
appartiene. Il pensiero è nello stesso tempo pensiero dell’essere
in
quanto, appartenendo all’essere, è all’ascolto dell’essere [...].
Ma l’essere —
che cos’è l’essere? Esso “è” se stesso. Questo è quanto il
pensiero futuro deve
imparare a esperire e dire.
La metafisica si chiude di fronte al semplice fatto essenziale
che l’uomo si dispiega
solo nella sua essenza in quanto è chiamato dall’essere. Solo a
partire
da questo reclamo, l’uomo «ha» trovato dove la sua essenza abita.
Solo a partire
da questo abitare egli «ha» il «linguaggio» come dimora che
conserva alla
sua essenza il carattere estatico. Lo stare nella radura
(Lichtung) dell’essere, lo
chiamo e–sistenza dell’uomo. Solo all’uomo appartiene un tal modo
d’essere.
L’uomo è piuttosto «gettato» dall’essere stesso nella verità
dell’essere, in modo
che, così e–sistendo, custodisca la verità dell’essere, affinché
nella luce
dell’essere l’ente appaia come quell’ente che è. Se e come esso
appaia, se e
come Dio e gli dèi, la storia e la natura entrino nella radura
dell’essere, si presentino
e si assentino, non è l’uomo a deciderlo. L’avvento dell’ente
riposa
nel destino dell’essere. All’uomo resta il problema di trovare la
destinazione
con–veniente (das Schickliche) alla sua essenza, che
corrisponda a questo destino
(Geschick); perché, conformemente a questo destino,
egli, in quanto e–sistente, ha da custodire la verità
dell’essere. L’uomo è il pastore dell’essere.
La storia non accade anzitutto come accadere, e l’accadere non è
un trascorrere.
L’accadere della storia dispiega la sua essenza come destino
della verità
dell’essere a partire da questo […]. Solo finché la radura
dell’essere avviene, l’essere si trasmette all’uomo. Ma
che il «ci», la radura della verità dell’essere stesso, avvenga,
è destinamento
dell’essere stesso. L’essere è il destino della radura […].
L’essere si dirada all’uomo nel progetto estatico. Ma questo
progetto non crea
l’essere. Il progetto, del resto, è essenzialmente un progetto
gettato. Nel progettare,
chi getta non è l’uomo, ma l’essere stesso, il quale destina
l’uomo
nell’e–sistenza dell’esser–ci come sua essenza […]. Ma qui
compare l’enigma: l’uomo è nella condizione dell’essere–gettato
(Geworfenheit).
Ciò significa che l’uomo, come e–sistente controgetto
(Gegenwurf)
dell’essere, è più che animal rationale, proprio in
quanto è meno rispetto all’uomo
che si concepisce a partire dalla soggettività. L’uomo non è il
padrone dell’ente.
L’uomo è il pastore dell’essere. In questo «meno» l’uomo non
perde nulla, anzi ci
guadagna, in quanto perviene alla verità dell’essere. Guadagna
l’essenziale povertà
del pastore, la cui dignità consiste nell’esser chiamato
dall’essere stesso a custodia
della sua verità. Questa chiamata viene con il getto
(Wurf) da cui scaturisce
l’esser–gettato dell’esser–ci. L’uomo, nella sua essenza secondo
la storia dell’essere,
è quell’ente il cui essere, in quanto e–sistenza, consiste
nell’abitare nella
vicinanza dell’essere. L’uomo è il vicino dell’essere.
Il linguaggio
Die Sprache, 1950
Edizione italiana: in, In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1988
In che modo è e opera il linguaggio come linguaggio?
Rispondiamo: il linguaggio parla […]. Il riflettere sul
linguaggio esige pertanto che noi ci inoltriamo entro il parlare
del linguaggio per prendere dimora presso il linguaggio: nel suo
parlare, cioè, e non nel nostro. Soltanto così possiamo
raggiungere quel dominio entro cui può riuscire, come può anche
non riuscire, che il linguaggio ci riveli la sua essenza. È al
linguaggio che va lasciata la parola.
Il linguaggio parla. Ma come parla? Dove ci è dato cogliere tale
suo parlare? Innanzitutto in una parola già detta. In questa
infatti il parlare si è già realizzato. Il parlare non finisce in
ciò che è stato detto. In ciò che è stato detto il parlare resta
custodito. In ciò che è stato detto il parlare riunisce il modo
del suo perdurare e ciò che grazie ad esso perdura – il suo
perdurare, la sua “essenza” […]. Se pertanto dobbiamo cercare il
parlare del linguaggio in una parola detta, sarà bene, anziché
prendere a caso una parola qualsiasi, scegliere una parola pura.
Parola pura è quella in cui la pienezza del dire, che è carattere
costitutivo della parola detta, si configura come una pienezza
iniziante. Parola pura è la poesia.
Il nominare non distribuisce nomi, non applica parole, bensì
chiama entro la parola. Il nominare chiama. Il nominare avvicina
ciò che chiama […]. Si tratta di un chiamare a sé, in virtù del
quale, quel che ancora non era stato chiamato vien fatto vicino.
Solo che questo chiamare a sé è appello nella lontananza, nella
quale ciò che è chiamato permane come l’ancora assente. Chiamare
è chiamare presso. E tuttavia, quel che è chiamato non resta
sottratto alla lontananza, nella quale proprio quel cenno di
chiamata di lontano fa che permanga. Il chiamare è sempre un
chiamare presso e lontano; presso: alla presenza; lontano:
all’assenza […]. Cosa chiama la prima strofa? Chiama cose, dice
loro di venire. Dove? Non certo qui nel senso di farsi presenti
fra ciò che è presente […]. Il luogo dell’arrivo, che è con-
chiamato, nella chiamata, è una presenza serbata intatta nella
sua natura di assenza. È questo il luogo in cui quel nominante
chiamare dice alle cose di venire. Il chiamare è un invitare. È
l’invito alle cose ad essere veramente tali per gli uomini.
La caduta della neve porta gli uomini sotto il cielo che si
oscura inoltrandosi nella notte. Il suonare della campana della
sera li porta come mortali di fronte al Divino. Casa e tavola
vincolano i mortali alla terra. Le cose che la poesia nomina, in
tal modo chiamate, adunano presso di sé cielo e terra, i mortali
e i divini. I quattro costituiscono, nel loro relazionarsi,
un’unità originaria. Le cose trattengono presso di sé il quadrato
dei quattro. In questo adunare e trattenere consiste l’esser cosa
delle cose. L’unitario quadrato di cielo e terra, mortali e
divini, immanente all’essenza delle cose in quanto cose, noi lo
chiamiamo: il mondo. La poesia, nominando le cose, le chiama in
tale loro essenza. Queste, nel loro essere e operare come cose,
dispiegano il mondo […]. Le cose visitano di volta in volta i
mortali sempre e solo insieme col mondo. La prima strofa parla
dell’atto che dice alle cose di venire.
Come il chiamare, che nomina le cose, chiama presso e rimanda
lontano, così il dire, che nomina il mondo, è invito a questo a
farsi vicino e, al tempo stesso, lontano. Esso affida il mondo
alle cose e insieme accoglie e custodisce le cose nello splendore
del mondo. Il mondo concede alle cose la loro essenza. Le cose
fanno essere il mondo. Il mondo consente le cose.
Mondo e cose non sono infatti realtà che stiano l’una accanto
all’altra; essi si compenetrano vicendevolmente. Compenetrandosi
i Due passano attraverso una linea mediana. In questa si
costituisce la loro unità. Per tale unità sono intimi. La linea
mediana è l’intimità. Per indicare tale linea la lingua tedesca
usa il termine das Zwischen (il fra, il framezzo). La
lingua latina dice: inter. All’inter latino
corrisponde il tedesco unter. L’intimità di mondo e cosa
non è fusione. L’intimità di mondo e cosa regna soltanto dove
mondo e cosa nettamente si distinguono e restano distinti. Nella
linea che è a mezzo dei due, nel framezzo di mondo e cosa, nel
loro inter, in questo unter, domina lo stacco.
L’intimità di mondo e cosa è nello stacco (Schied) del
framezzo, è nella dif-ferenza (Unter-Schied).
La Dif-ferenza, di cui si parla, esiste solo come quest’una. È
unica. La Dif-ferenza regge – non però con essa identificandosi –
quella linea mediana, nel moto e nella relazione alla quale e
grazie alla quale mondo e cose trovano la loro unità […]. La
Dif-ferenza porta il mondo al suo essere mondo, porta le cose al
loro essere cose. Portandoli a compimento, li porta uno verso
l’altro. La composizione operata dalla Dif-ferenza non è qualcosa
che avvenga in un secondo momento, quasi la Dif-ferenza
sopraggiungesse recando una linea mediana e con questa
congiungesse mondo e cose. La Dif-ferenza, in quanto linea
mediana, media il realizzarsi del mondo e delle cose nella loro
propria essenza, cioè stabilisce il loro essere l’uno per
l’altro, di questo fondando e compiendo l’unità.
La Differenza tra mondo e cosa fa che le cose emergano come
quelle che generano il mondo, fa che il mondo emerga come quello
che consente le cose. La Dif-ferenza non è né distinzione né
relazione. La Dif-ferenza è semmai la dimensione di mondo e cose.
Ma in questo caso “dimensione” non significa una regione a sé
stante, dove questo o quello può prendere dimora. La Dif-ferenza
è la dimensione, in quanto misura nella sua interezza,
facendolo essere nella sua propria essenza, lo spazio di mondo e
cosa. Il suo instaurante misurare dischiude, evocandolo
all’essere, il vincolo di distacco e di indissolubilità tra mondo
e cosa. Tale evocante dischiudere è il modo secondo il quale qui
la Dif-ferenza misura nella loro interezza l’uno e l’altra. La
Dif-ferenza, come linea mediana, di mondo e cose, rappresenta,
generandola, la misura in cui mondo e cosa realizzano la loro
essenza. Nel nominare, che chiama cosa e mondo, quel che è
propriamente nominato è la Dif-ferenza.
Nella prima strofa l’invito è rivolto alle cose che, in quanto se
stesse, generano il mondo. Nella seconda l’invito è rivolto al
mondo che, in quanto se stesso, consente le cose. Nella terza
l’invito è alla linea framezzo mondo e cosa: a ciò che fonda e
compie l’intimità.
La soglia è l’impalcatura che regge il complesso della porta.
Essa costituisce il punto nel quale i Due, l’esterno e l’interno,
trapassano l’uno nell’altro. La soglia regge il framezzo. Alla
sua fidatezza si adatta ciò che nel framezzo entra ed esce. La
fidatezza di tale framezzo deve essere ferma e uguale in ogni
direzione. Il potere di reggere e comporre del framezzo esige
qualcosa che duri, e pertanto qualcosa di solido e valido. La
soglia, come quella che regge il framezzo, è dura, perché il
dolore l’ha pietrificata. Ma il dolore che si è fatto pietra, non
si è solidificato nella soglia, per irrigidirsi in essa. Il
dolore permane nella soglia come dolore. Ma che è il dolore? Il
dolore spezza. È lo spezzamento. Ma esso non schianta in schegge
dirompenti in tutte le direzioni. Il dolore, sì, spezza, divide,
però in modo che anche insieme tutto attira a sé, raccoglie in
sé. Il suo spezzare, in quanto dividere che riunisce, è al tempo
stesso quel trascinare, teso in opposte direzioni, che
diversifica e congiunge ciò che nello stacco è tenuto distinto.
Il dolore è ciò che congiunge nello spezzamento che divide e
aduna. Il dolore è la connessura dello strappo. Questa è la
soglia. La soglia regge il framezzo, il punto in cui i Due si
staccano e s’incontrano. Il dolore salda lo spezzamento della
Dif-ferenza. Il dolore è la Dif-ferenza stessa […]. L’intimità
della Dif-ferenza di mondo e cosa – questo sarebbe dunque il
dolore? Certamente […]. Il dolore ha fatto la soglia atta al
reggere che le compete.
L’originario chiamare, che si volge all’intimità di mondo e cosa
e a questa dice di venire, è l’autentico chiamare. Questo
chiamare è l’essenza del parlare. Nella parola della poesia
è il parlare. Questo è il parlare del linguaggio. Il
linguaggio parla. Parla dicendo a quel che chiama, cosa-mondo e
mondo-cosa, di venire nel framezzo della Dif-ferenza. Ciò che in
tal modo è chiamato, mentre è sollecitato a muovere dalla Dif-
ferenza (presso cui dimora) per portarsi qui, è insieme affidato
alla Dif-ferenza.
La Dif-ferenza è la Chiamata dalla quale soltanto ogni chiamare è
esso stesso chiamato, alla quale pertanto ogni possibile chiamare
appartiene. La Chiamata della Dif-ferenza ha già sempre raccolto
in sé ogni chiamare […]. Il chiamare che raccoglie in sé ogni
possibile chiamare, la Chiamata, identificandosi con la quale la
Dif-ferenza chiama mondo e cose, è il suono della quiete. Il
linguaggio parla in quanto la chiamata della Dif-ferenza chiama
mondo e cose alla semplicità della loro intimità. Il
linguaggio parla in quanto suono della quiete. La quiete
acquieta, portando mondo e cose alla loro essenza. Il fondare e
comporre mondo e cosa nel modo dell’acquietamento è l’evento
della Dif-ferenza. Il linguaggio, il suono della quiete,
è, in quanto Dif-ferenza è come farsi evento.
L’essere del linguaggio è l’e-venire della Dif-ferenza.
Il suono della quiete non è nulla di umano. Certo l’uomo è nella
sua essenza parlante. Il termine “parlante” significa qui: che
emerge ed è fatto se stesso dal parlare del linguaggio. In forza
di tale e-venire, l’uomo, nell’atto che è dalla lingua portato a
se stesso, alla sua propria essenza, continua ad appartenere
all’essenza del linguaggio, al suono della quiete. Tale evento si
realizza in quanto l’essenza del linguaggio, il suono
della quiete, si avvale del parlare dei mortali per
essere dai mortali percepita come appunto suono della quiete.
Solo in quanto gli uomini rientrano nel dominio del suono della
quiete, i mortali sono a loro modo capaci di un parlare
attuantesi in suoni […]. Il parlare dei mortali ha il suo
fondamento nel rapporto col parlare del linguaggio […]. Il modo
con cui i mortali, quando la Dif-ferenza li chiama a sé, a loro
volta parlano, è il cor-rispondere. Il parlare mortale presuppone
l’ascolto della Chiamata, identificandosi con la quale la quiete
della Dif-ferenza chiama mondo e cose nella cesura della sua
semplicità. Ogni parola del parlare mortale parla sul fondamento
di questo ascolto e solo come questo ascolto. I mortali parlano
in quanto ascoltano. Essi prestano attenzione al richiamo della
quiete della Dif-ferenza, anche quando non lo conoscono […]. Il
linguaggio parla. Il suo parlare chiama la Dif-ferenza, la quale
porta mondo e cose nella semplicità della loro intimità,
consentendo loro di essere se stesse […]. L’uomo parla in quanto
cor-risponde al linguaggio. Il cor-rispondere è ascoltare.
L’ascoltare è possibile solo in quanto legato alla Chiamata della
quiete da un vincolo di appartenenza.
Non ha alcuna importanza proporre una nuova concezione del
linguaggio. Quel che solo conta è imparare a dimorare nel parlare
del linguaggio. Perché ciò sia possibile, è necessario un
continuo esame di se stessi per vedere se e fino a che punto
siamo capaci di un autentico cor-rispondere: di prevenire la
Chiamata permanendo nel suo dominio.
La Cosa
Das Ding, 1950
Edizione italiana: in, Saggi e discorsi, Mursia, Milano 2014
Questi quattro, uniti di per se stessi, sono reciprocamente
connessi. Venendo prima di
ogni cosa presente, essi sono compresi in un'unica quadratura.
Terra e cielo, i divini e i mortali, sono reciprocamente
connessi, di per se
stessi uniti, a partire dalla semplicità dell’unica Quadratura.
Ognuno dei quattro
rispecchia a suo modo l’essenza degli altri. Così facendo, ognuno
si rispecchia
a modo suo in ciò che gli è proprio entro la semplicità dei
Quattro
[…]. Nessuno dei Quattro si irrigidisce in ciò che ha di
specificamente proprio.
Il riunirsi la nostra lingua, con un’antica parola, lo chiama
“thing” […]. La
cosa coseggia. Il coseggiare riunisce. Facendo avvenire la
Quadratura, raccoglie
il dimorare di essa ogni volta in un singolo durare: ora in
questa, ora in
quella cosa […]. Noi pensiamo ora questo nome a partire dal
pensiero
dell’essenza della cosa, a partire dal coseggiare inteso come il
riunente far
permanere che fa avvenire la Quadratura.
Costruire, Abitare, Pensare
Bauen, Wohnen, Denken, 1951
Edizione italiana: in, Saggi e discorsi, Mursia, Milano 2014
C’è una unità originaria entro la quale i quattro: terra e
cielo, i divini e i mortali, sono
una cosa sola.
Il modo in cui tu sei e io sono, il modo in cui noi uomini
siamo sulla terra è il
Buan, l’abitare. Essere uomo significa: essere sulla
terra come mortale, e
cioè: abitare […]. I mortali sono nella Quadratura in
quanto abitano. Ma il
tratto fondamentale dell’abitare è l’aver cura. I mortali abitano
nel modo
dell’aver cura della Quadratura nella sua essenza […]. Nel
salvare la terra,
nell’accogliere il cielo, nell’attendere i divini, nel condurre i
mortali avviene
l’abitare come il quadruplice aver cura della Quadratura. Aver
cura significa
custodire la Quadratura nella sua essenza.
Quando diciamo terra, pensiamo già insieme anche gli altri Tre,
ma non riflettiamo
ancora sulla semplicità dei Quattro […]. Quando diciamo cielo,
pensiamo già insieme anche
gli altri Tre, ma non riflettiamo ancora sulla semplicità dei
Quattro […]. Quando nominiamo
i divini, pensiamo già insieme anche gli altri Tre, ma non
riflettiamo ancora sulla semplicità
dei Quattro […]. Quando nominiamo i mortali, pensiamo già insieme
anche gli altri Tre, ma
non riflettiamo ancora sulla semplicità dei Quattro. Questa loro
semplicità noi la chiamiamo il Geviert, la
Quadratura.
La questione dell'essere
Zur Seinsfrage, 1955
Edizione italiana: in, Oltre la linea, Adelphi, 2010
Caro Signor Jünger […], il suo contributo Über die
Linie […] è una “valutazione della situazione” che mira
all’“attraversamento” della linea, ma che non si esaurisce nel
descrivere la situazione. La linea si chiama anche “meridiano
zero”. Lei parla di “punto zero”. Lo zero allude al niente, e
precisamente al niente vuoto. Dove tutto spinge al niente, lì
domina il nichilismo. Al meridiano zero il nichilismo si avvicina
al suo compimento […]. Come meridiano, la linea-zero ha la sua
zona. L’ambito del nichilismo compiuto costituisce il confine tra
due epoche del mondo. La linea che lo definisce è la linea
critica, dove si decide se il movimento del nichilismo finisce
nel niente vuoto oppure se esso è il passaggio nell’ambito di una
“nuova dedizione dell’essere” […]. La sua valutazione della
situazione guarda ai segni che permettono di riconoscere se e in
che misura noi attraversiamo la linea, uscendo così dalla zona
del nichilismo compiuto. Nel titolo del suo scritto Über die
Linie, “über” significa al di là
(hinüber), trans, metá. Le osservazioni che
seguono intendono invece l’“über” solo nel significato di de,
perí. Esse trattano “della” linea stessa, cioè della zona in
cui si compie il nichilismo […]. Per ora mi accontento di
presumere che il solo modo in cui potremmo meditare sull’essenza
del nichilismo sia quello di imboccare anzitutto la via che
conduce a una localizzazione dell’essenza dell’essere. Solo per
questa via è possibile localizzare la questione del niente.
Sennonché, la questione dell’essenza dell’essere si estingue
se essa non abbandona il linguaggio della metafisica, perché il
rappresentare metafisico impedisce di pensare la questione
dell’essenza dell’essere.
Lei scrive: “L’istante in cui la linea sarà passata porterà una
nuova dedizione dell’essere, e così comincerà a risplendere ciò
che realmente è” […]. La sua proposizione dice: “ciò che
realmente è”, dunque il reale, cioè l’ente, comincia a
risplendere perché l’essere di nuovo si dedica. Per questo, ora,
ci domandiamo più correttamente se l’“essere” è qualcosa di per
sé, e se, oltre a ciò, talvolta si dedica anche all’uomo.
Presumibilmente proprio questa dedizione è, ma in maniera ancora
velata, ciò che in modo assai imbarazzato e indeterminato
chiamiamo “l’essere”. Ma una tale dedizione non accade anch’essa
ancora, e in uno strano modo, sotto il dominio del nichilismo,
cioè in un modo tale che “l’essere” si distoglie e si sottrae
nell’assenza? Distoglimento e sottrazione, tuttavia, non è che
siano niente. Essi dominano per l’uomo in modo quasi più
opprimente, tanto da trascinarlo via, da risucchiare il suo
aspirare e il suo fare, e da inghiottirlo infine nel vortice che
si ritrae, e in modo tale che l’uomo può credere di non
incontrare ormai che se stesso. In verità, però, questo suo se
stesso non è più nient’altro che la consumazione della sua e-
sistenza nel dominio di ciò che lei connota come il carattere
totale del lavoro. Naturalmente, se prestiamo una sufficiente
attenzione, la dedizione (Zuwendung) e il distoglimento
(Abwendung) dell’essere non possono mai essere
rappresentati come se riguardassero l’uomo solo di quando in
quando e solo per qualche istante. Piuttosto l’essere dell’uomo
consiste nel fatto che ognora, in un modo o nell’altro, esso
perdura e dimora in questa dedizione e in questo distoglimento.
Dell’“essere stesso” diciamo sempre troppo poco se, dicendo
l’“essere”, tralasciamo il suo presentarsi (Anwesen)
all’essere dell’uomo (Menschenwesen), dando
così a vedere di non comprendere che proprio questo essere entra
a far parte dell’“essere”. Ma anche dell’uomo diciamo sempre
troppo poco se, dicendo l’“essere” (non l’essere-uomo),
poniamo l’uomo per se stesso e, dopo averlo così posto, lo
mettiamo in relazione all’“essere”. Diciamo invece anche troppo,
se pensiamo l’essere come qualcosa di onnicomprensivo, e ci
rappresentiamo l’uomo soltanto come un ente particolare tra gli
altri (vegetali, animali), per poi mettere i due in relazione tra
loro; infatti, già nell’essere umano è insita la relazione con
ciò che è determinato come “essere” attraverso il riferimento, il
riferirsi nel senso del fruire, e che così è sottratto al suo
presunto “in sé e per sé” […]. Parlando di una “dedizione
dell’essere” rimane allora un espediente, e del tutto
problematico, perché l’essere consiste nella dedizione, in modo
tale che questa dedizione non è mai soltanto qualcosa che può
aggiungersi all’“essere”. Essere-presente (“essere”) è sempre, in
quanto essere-presente, un essere-presente all’essere umano,
essendo l’essere-presente quell’ingiunzione che di volta in volta
chiama l’essere umano. In quanto tale, l’essere umano è disposto
all’ascolto, perché appartiene all’ingiunzione che chiama,
all’essere-presente (An-wesen). Questa cosa che ognora
si annuncia come la stessa, questa coappartenenza di chiamata e
ascolto, sarebbe allora l’“essere”? […]. In verità, allora, non
possiamo più nemmeno dire che “l’essere” e “l’uomo” “sono” la
stessa cosa nel senso che essi appartengono l’uno
all’altro, perché, dicendo così, continuiamo a lasciare
essere l’uomo e l’altro per sé.
Sono questioni, queste, che nell’andare “oltre la linea” rilevano
una particolare pungenza; perché questo andare si muove
nell’ambito del niente. Forse che col compimento o per lo meno
con l’oltrepassamento del nichilismo sparisce il niente?
Probabilmente questo oltrepassamento accade solo se, invece
dell’apparenza del niente nullo, arriva e trova accoglienza
presso di noi mortali l’essenza del niente da sempre affine
all’“essere”.
Se all’“essere” appartiene la dedizione in modo tale che quello
stia in questa, allora l’“essere” si risolve nella dedizione.
Quest’ultima diventa ora ciò che va domandato, e come tale d’ora
in poi viene pensato l’essere che si è ritirato nella sua essenza
e che in essa si è risolto. Corrispondentemente, lo sguardo del
pensiero che vede già in questo ambito può ormai scrivere
l’“essere” soltanto in modo seguente: l’essere. Questa barratura
a forma di croce difende innanzitutto dall’abitudine, quasi
inestirpabile, di rappresentare l’“essere”come un qualcosa che
sta di fronte e che sta per sé, e che poi talvolta si fa innanzi
all’uomo […]. Dopo quanto si è detto, però, il segno della
barratura a croce non può essere un segno meramente negativo di
cancellazione. Piuttosto esso indica le quattro contrade
dell’insieme dei Quattro (Geviert) e la loro riunione
nel luogo dell’incrocio […]. L’essere-presente (An-
wesen) si dedica come tale all’essere umano, e in questo
solamente si compie la dedizione, in quanto quello, l’essere
umano, è memore di questa. Nella sua essenza, infatti, l’uomo è
la memoria dell’essere, ma nel senso dell’essere.
Come l’essere, anche il niente dovrebbe essere scritto,
cioè pensato, così. Ciò significa che al niente appartiene, e in
modo non accessorio, l’essere umano che ne è memore. Pertanto, se
nel nichilismo il niente giunge a dominare in modo del tutto
particolare, allora l’uomo non solo è riguardato dal nichilismo,
ma vi prende essenzialmente parte. Ma allora anche l’intera
“sostanza” umana non sta da qualche parte, al di qua della linea,
per poi attraversarla e stabilirsi dall’altra parte presso
l’essere. È l’essere umano stesso ad appartenere all’essenza del
nichilismo e quindi alla fase del suo compimento. L’uomo, in
quanto essere che è fruito nell’essere, fa parte della
zona dell’essere e quindi nello stesso tempo di quella del
niente. Egli non è soltanto nella zona critica della linea. Egli
stesso, ma non per sé e ancor meno mediante se stesso soltanto, è
questa zona e perciò la linea. Pensata come segno che delimita la
zona del nichilismo compiuto, la linea non è in nessun caso
qualcosa che stia davanti all’uomo come un che di oltrepassabile.
Ma allora cade anche la possibilità di un trans lineam e
perciò di un suo attraversamento.
Nella fase del nichilismo compiuto sembra che non si dia qualcosa
come l’essere dell’ente, come se dell’essere non ne
fosse niente (nel senso del niente nullo). L’essere rimane
assente in un modo singolare. Si vela e si mantiene in una
velatezza che a sua volta si vela. In tale velatezza riposa
l’essenza della dimenticanza esperita in modo greco. In fondo,
cioè a partire dall’inizio del dispiegarsi della sua essenza,
questa dimenticanza non è niente di negativo, ma, in quanto
velamento-salvamento (Ver-bergung), è presumibilmente un
mettere in salvo che preserva qualcosa di non ancora svelato.
Ora, la dimenticanza, apparentemente distinta dall’essenza
dell’essere, non si limita a colpire quest’essenza. Essa
fa parte della cosa stessa dell’essere, domina come destino della
sua essenza. La dimenticanza rettamente pensata, il velamento del
non ancora svelato dispiegarsi dell’essenza (in senso verbale)
dell’essere, vela e mette in salvo tesori non ancora
scoperti ad è la promessa di un ritrovamento che attende solo una
ricerca adeguata.
La svelatezza riposa nella velatezza dell’essere-presente. A
questa velatezza, in cui si fonda la svelatezza
(Alétheia), è destinato il pensiero rammemorante. Esso
pensa e rammemora ciò che è stato, ma che non è passato, perché
rimane l’imperituro in ogni durare che di volta in volta l’evento
dell’essere concede.
Il superamento della metafisica è il superamento della
dimenticanza dell’essere […]. Il rappresentare che è proprio
delle scienze mira ovunque all’ente, e precisamente ad ambiti
separati dell’ente […]. Esse ritengono che tutto l’ambito di ciò
che si può ricercare e indagare si esaurisca nel rappresentare
l’ente, e che oltre all’ente non ci sarebbe “niente altro”. La
questione dell’essenza della metafisica tenta di raccogliere
questa opinione delle scienze e, apparentemente, di dividerla con
esse. Ma chiunque riflette deve già sapere che il domandare che
riguarda l’essenza della metafisica non può aver presente che
quell’unica cosa che caratterizza la meta-fisica, e cioè il
trascendimento: l’essere dell’ente. Invece,
nell’orizzonte del rappresentare scientifico che conosce solo
l’ente, ciò che non è assolutamente un ente (cioè l’essere) non
può offrirsi che come un ente. Perciò la Prolusione pone la
questione di “questo niente”. Essa non domanda in modo
arbitrario e indeterminato “del” niente. Essa domanda che ne è di
ciò che è tutt’altro rispetto a ogni ente, che ne è di ciò che
ente non è […]. La domanda “Che cos’è la metafisica?” tenta
questa sola cosa: condurre le scienze a riflettere sul fatto che
esse incontrano necessariamente, e perciò sempre e dappertutto,
il tutt’altro rispetto all’ente, il niente di ente. A
loro insaputa, esse stanno già in riferimento
all’essere. Solo dalla verità dell’essere di volta in volta
dominante esse ricevono una luce per poter vedere e considerare
come tale l’ente che esse si rappresentano. Il domandare
“Che cos’è metafisica?”, ossia il pensiero che ne deriva, non è
più scienza. Ma il pensiero, il trascendimento come tale, cioè
l’essere dell’ente, diventa ora degno di essere
interrogato relativamente alla sua essenza, e perciò non è mai
qualcosa di indegno e di nullo. “Essere”, questa parola
apparentemente vuota, è qui pensata sempre nella pienezza
essenziale di quella determinazione che, dalla Phýsis al
Lógos fino alla “volontà di potenza”, rinviano l’una
all’altra, rivelando ovunque un tratto fondamentale che in
Sein und Zeit si tenta di nominare col termine “essere-
presente”.
Alla luce di questa domanda appare che l’esserci dell’uomo è
“tenuto immerso” in “questo” niente, nel tutt’altro
rispetto all’ente. Detto in altri termini, questo significa e
poteva significare soltanto che “l’uomo è il luogo-tenente del
niente”. La frase vuol dire che l’uomo tiene libero il luogo per
il tutt’altro rispetto all’ente, in modo tale che nella sua
apertura possa darsi qualcosa come l’essere-presente (l’essere).
Questo niente, che non è l’ente, e che però si dà, non è
niente di nullo, ma appartiene all’essere-presente. Essere e
niente non si danno uno accanto all’altro, ma l’uno si adopera
per l’altro, in una sorta di parentela di cui non abbiamo ancora
pensato la pienezza essenziale.
L’essenza del nichilismo, che da ultimo si compie nel dominio
della volontà di volontà, sta nella dimenticanza dell’essere. A
questa dimenticanza sembra che corrispondiamo al meglio quando la
dimentichiamo, cioè quando la buttiamo al vento. Così facendo,
non prestiamo attenzione a che cosa significa dimenticanza in
quanto velatezza dell’essere. Se invece prestiamo
attenzione a ciò, allora esperiamo questa sconcertante necessità:
invece di voler oltrepassare il nichilismo, dobbiamo prima
raccoglierci nella sua essenza. Questo raccoglimento
(Ein-kehr) nella sua essenza è il primo passo mediante
il quale lasciamo il nichilismo alle nostre spalle. La via di
questo raccoglimento ha la direzione e la modalità di un ritorno
(Ruck-kehr). Non si tratta naturalmente di un ritorno ai
tempi trascorsi per tentare di restaurarli in una forma
artificiosa. Ritorno qui significa la direzione verso quella
località (la dimenticanza dell’essere) dalla quale la metafisica
ha ricevuto e continua ad avere la sua provenienza.
Identità e Differenza
Identität und Differenz, 1957
Edizione italiana: Adelphi, Milano 2009
Per noi la cosa del pensiero è lo Stesso,
dunque l’essere, però l’essere in riferimento
alla sua differenza dall’ente. Detto in modo
ancora più incisivo: per Hegel la cosa del
pensiero è il pensiero in quanto concetto
assoluto. Per noi invece, con una
denominazione provvisoria, la cosa del
pensiero è la differenza in quanto differenza
[…]. Non si tratta qui di un problema che ci è
stato tramandato ed è già stato posto, bensì
di ciò che lungo tutta la storia del pensiero
è rimasto ovunque inindagato. Provvisoriamente
noi non possiamo nominarlo che utilizzando il
linguaggio della tradizione e parliamo così
della differenza tra essere e ente.
L’essere nel senso del tramandamento che
svela, e l’ente in quanto tale nel
senso dell’avvento che si cela–salva, sono
essenzialmente come i distinti a
partire dallo Stesso, cioè dalla differenza. È
solo tale differenza che anzitutto
assegna e tiene distinto il “framezzo” in cui
tramandamento e avvento sono
mantenuti l’uno di fronte all’altro, cioè
portati a divergere l’uno dall’altro e a
volgersi l’uno all’altro. In quanto differenza
di tramandamento e avvento, la
differenza di essere ed ente è la svelante–
celante–salvante di–vergenza di entrambi.
Nella diavergenza domina la radura di ciò che,
nascondendo, si chiude — un dominare che
assegna il divergere–e–volgersi reciproco di
tramandamento
e avvento.
Con questa localizzazione della differenza tra
essere e ente nella diavergenza
in quanto luogo che precede la sua essenza,
viene in luce qualcosa di molto
comune che attraversa completamente il destino
dell’essere dall’inizio sino al
suo compimento.
I divergenti sono serrati nella diavergenza in
modo tale che non solo l’essere,
in quanto fondamento, fonda l’ente, ma anche
l’ente a sua volta — e a suo
modo — fonda l’essere, lo causa. L’ente può
fare ciò solo in quanto esso “è”
la pienezza dell’essere, cioè in quanto è
l’ente più essente.
Nella misura in cui l’essere è essenzialmente
come essere dell’ente, come differenza e come
divergenza, perdurano il divergere–e–volgersi
reciproco del
fondare e del dare fondazione: l’essere fonda
l’ente, e l’ente — in quanto è
l’ente più essente — dà fondazione all’essere.
L’uno si tramanda all’altro,
l’uno avviene nell’altro. Tramandamento e
avvento appaiono riflettendosi
scam–bievolmente l’uno nell’altro.
Detto a partire dalla differenza, ciò
significa: la divergenza è un movimento
circolare, ovvero il ruotare l’uno intorno
all’altro di essere e ente […]. Entro la
radura della divergenza il fondare stesso
appare come qualcosa che è,
dunque come qualcosa che, in quanto ente,
esige anch’esso la rispettiva fondazione da
parte dell’ente, vale a dire l’essere–causato
e, precisamente,
l’essere–causato dalla causa suprema.
Il cammino verso il linguaggio
Der Weg zur Sprache, 1959
Edizione italiana: in, In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1988
Ciò che fa essere il linguaggio come linguaggio è il Dire
originario (die Sage) in quanto Mostrare (die Zeige). Il
mostrare proprio di questo non si basa su un qualche segno, ma
tutti i segni traggono origine da un mostrare nel cui ambito e
per i cui fini [soltanto] acquistano la possibilità di essere
segni. Quando si guardi alla struttura del Dire originario, non è
possibile attribuire il mostrare né esclusivamente né
preminentemente all’operare umano. Il mostrarsi, in quanto
apparire, è il tratto distintivo dell’essere presente o assente
dell’essente quale che ne sia la specie o il grado. Perfino là
dove il mostrare si realizza grazie a un nostro dire, c’è sempre
un lasciarsi mostrare che precede questo nostro mostrare come
additare e rilevare. Solo quando si consideri il nostro dire in
tale prospettiva, è possibile una determinazione adeguata di quel
che è essenziale in ogni parlare.
Il parlare è insieme ascoltare […]. Il parlare è, per se stesso,
un ascoltare. È il porgere ascolto al linguaggio che parliamo.
Perciò il parlare è, non al tempo stesso, bensì prima un
ascoltare […].Ma cosa ascoltiamo? Ascoltiamo il parlare del
linguaggio. Il linguaggio parla in quanto dice, cioè mostra. Il
suo dire scaturisce dal Dire originario, sia per quanto s’è fatto
parola, sia per quanto è rimasto ancora inespresso, da quel Dire
originario che trapassa il profilo del linguaggio. Il linguaggio
parla nell’atto che, come Mostrare (als die Zeige),
raggiungendo tutte le contrade di ciò che può farsi presente, fa
che da esse appaia o dispaia quel che di volta in volta si fa
presente. Di conseguenza noi porgiamo ascolto al linguaggio in
modo da lasciarci dire da esso il suo Dire.
Se il parlare come ascolto del linguaggio lascia che il Dire
dica, questo “lasciare che” può avvenire e dar frutto solo nella
misura in cui il nostro proprio essere è immesso nel Dire
originario. Noi possiamo ascoltare tale Dire per il fatto che
rientriamo nel suo dominio. Solo a quelli che gli appartengono il
Dire originario accorda l’ascolto del linguaggio e,
conseguentemente, il parlare.
Questa realtà sconosciuta e nondimeno famigliare, da cui ogni
mostrare del Dire originario trae il proprio moto, è, per ogni
esser presente ed essere assente l’alba di quel mattino nel quale
soltanto può trovare inizio la vicenda del giorno e della notte:
alba che è insieme l’ora prima e l’ora più remota. Tale realtà
appena ci è dato nominarla: essa è l’Ort, che non
tollera Er-örterung: il luogo che non concede d’essere
raggiunto, perché luogo di tutti i luoghi e di tutti gli spazi
del gioco del tempo. Noi lo chiameremo con una parola antica e
diremo: Ciò che muove nel mostrare del Dire originario è lo
“Eignen”.
Lo Eignen adduce ciò che è presente e assente in quello
che gli è proprio così che, emergendone, la cosa presente e
assente si rivela nella sua vera identità e resta se stessa.
Questo Eignen, in virtù del quale le cose emergono nella
loro verità, questo Eignen, che muove il Dire originario
in questo suo mostrare, lo chiameremo Ereignen. Esso fa
essere il libero spazio della radura luminosa, alla quale
accedendo ciò che è presente può permanere come tale, e dalla
quale sfuggendo ciò che è assente può essere tale, senza cessare
di essere […]. L’Ereignendes [ciò che fa pervenire nel
proprio, ciò che rileva e serba le cose nella loro identità vera]
è l’Ereignis [evento, come appunto Ereignen:
rivelazione rivelante, cioè costituente e disvelante le cose
nella loro verità] stesso – e nulla al di fuori di questo.
Non c’è nulla, ad di fuori dell’Ereignis, cui
l’Ereignis possa essere ricondotto, in base a cui esso
possa essere spiegato. L’Ereignen non è il risultato
(Ergebnis) di qualcosa d’altro: esso è, al contrario, la
Donazione (die Er-gebnis). Solo il generoso dare di
questa può concedere qualcosa come quell’“es gibt”, del
quale “l’essere” ancora ha bisogno, per pervenire, come essere
presente, a ciò che gli è proprio.
L’Ereignis accorda ai mortali la dimora nel loro vero
essere e, con e per questa, la capacità d’essere i parlanti […].
L’appropriazione, che si viene così accordando dell’uomo come
ascoltatore al Dire originario, ha questo di caratteristico: essa
concede all’essere dell’uomo la libertà di accedere al luogo che
è suo, ma solo perché l’uomo – come l’essere che parla, che dice
– risponda al Dire originario, valendosi di quel che gli è
proprio. Il che è quanto dire: del suono della parola. Il dire
dei mortali è “rispondere” (das Antworten). Ogni parola
che si pronuncia è sempre “risposta”: un dire di rimando, un dire
ascoltando. L’appropriazione dei mortali al Dire originario fa
che l’essere dell’uomo entri in una servitù liberante, per la
quale l’uomo è addetto a trasferire il Dire originario, che non
ha suono, nel suono della parola […]. L’Ereignis
appropria a sé l’uomo per avvalersi di lui […].
L’Ereignis è l’evento che fa sorgere la via: la via che
conduce il Dire originario alla parola.
Non c’è alcun linguaggio naturale nel senso di linguaggio proprio
di una natura umana esistente per sé, fuori dal destino. Ogni
linguaggio è storico, anche là dove l’uomo non conosce la storia
nel significato che il termine ha assunto in Europa nell’età
moderna. Anche il linguaggio come informazione non è il
linguaggio in sé: pure esso è storico nel senso e nei limiti
propri dell’età contemporanea, la quale non inizia nulla di
nuovo, ma porta al suo estremo compimento l’antico, il già
prefigurato.
Eraclito
Seminario del semestre invernale 1966/67
Heraklit
Seminar Wintersemester 1966/67, con Eugen Fink
Edizione italiana: Edizioni Laterza, Bari 2010
Nel loro avvertire percettivamente, gli uomini non sono
riferiti soltanto a quel
che è immediatamente presente, a quel che si para loro dinnanzi.
Essi non sono
solamente assegnati al sopraggiungere di cose percepibili nel
mondo circostante,
bensì, nell’incontro con ciò che è presente, essi, in quanto
esseri che
agiscono nell’attesa, sono anticipatamente progettati
nell’avvenire […]. Questo
rapporto con l’avvenire l’uomo ce l’ha anche al di là della
soglia della
morte. Egli si tiene in rapporto non soltanto all’avvenire della
sua vita futura,
bensì anche al di là di questa, alla sua morte. Tutti gli uomini
tentato di popolare
e animare, nel pensiero, la terra oltre l’Acheronte. È con
un’esitante speranza
che essi vanno incontro al proprio essere morti.
Considerato come fenomeno naturale, il fulmine significa
l’irrompere del lampo
luminoso nell’oscurità della notte. Così come il fulmine riluce
nella notte in modo
repentino e, nel chiarore di un bagliore, mostra le cose
articolate nel loro contorno, allo
stesso modo, in un senso più profondo, il fulmine porta
all’apparire le molte cose nel loro
articolato raccogliersi […]. Avremmo così il seguente rapporto di
analogia: in una notte
senza luce, il fulmine lascia vedere, in un colpo solo, ogni cosa
singola nel suo contorno
definito, il che è, in un breve lasso di tempo, la stessa cosa
che accade, in modo costante,
nel pur aeízoon del fr. 30. Nel momento della chiarità è
pensato l’ingresso dell’essente
nella determinatezza. Nel fr. 64 si desume tà pánta dal
fr. 41 pánta dià pánton e dal fr. 1
ginoménon pánton katà tòn logón. In precedenza abbiamo
tentato di distinguere il
movimento dello sfolgorio del fulmine. Adesso possiamo dire che
esso è il movimento del
condurre all’apparire. Ma il condurre all’apparire, che il
fulmine porta a compimento nell’essente, è anche un intervento,
governante, nella motilità delle cose stesse […].
Voglio dire soltanto che il fulmine che squarcia l’oscurità della
notte e che nel suo
bagliore lascia vedere e rilucere tutto ciò che è nella propria
individualità, è anche, al
tempo stesso, il movimento della génesis nella modalità
del diá […]. In quanto luce che
apre con uno squarcio, in quanto fuoco nello stadio della
momentaneità, il fulmine
conduce all’apparire tà pánta, scontorna ogni cosa nella
sua figura e guida il movimento,
il cambiamento e il corso di tutto ciò che rientra in tà
pánta.
pánta tà ónta non indica un'enumerazione degli
ónta e non significa “tutti gli
essenti”, bensì che i pánta, i quali sono essenti, sono
posti in risalto nel contrasto, sono
distinti. Nel loro insieme, i pánta in quanto
ónta sono i correlati di una diágnosis.
L'elemento diagnostico di un distinguere viene acuito nella
prospettiva del fumo in quanto
fenomeno che occulta le distinzioni. Nel fr. 7, pertanto, i
pánta vengono portati allo
sguardo in quanto distinti […]. La gnõsis in riferimento
ai pánta, è possibile soltanto
nella misura in cui i pánta sono distinti in se stessi.
I pánta sono mossi in modo conforme
al lógos. Nel loro movimento, nel loro cambiamento e nel
corso che il fulmine governa,
essi sono contemporaneamente distinti in se stessi. Il movimento
del bagliore che irrompe
nello sfolgorio lascia che i pánta vengano fuori in
quanto distinti in se stessi […]. Per
chiarirsi l'unità riunente dello én si può assumere come
similitudine l'unità di un
elemento. Tuttavia non ci è lecito arrestarci a questo, bensì
dobbiamo ripensare l'unità che
riunisce in riferimento all'uno del fulmine, il quale, nel suo
bagliore, riunisce e raccoglie il
molteplice nel suo insieme, nel suo essere distinto.
Quando pensiamo in termini fisistici, parliamo del sole come
fonte luminosa e
dell’emissione dei suoi raggi. Di conseguenza, determiniamo
l’appartenenza del
diradamento alla luce in modo che il diradamento, in cui il sole
stesso viene visto, è
derivante dalla luce in quanto lo è dal sole. Tuttavia, dobbiamo
mettere in questione una
simile appartenenza in termini di derivazione. Non è la luce a
precedere il diradamento,
bensì, al contrario, è il diradamento che precede la luce. Una
luce è possibile, come
singola luce, soltanto perché, nel diradamento, si dà qualcosa di
singolo. Il sole viene
visto nella sua luce propria, di modo che ciò che è più
originario è il diradamento. Se noi
riconduciamo il chiarore soltanto alla fonte luminosa, saltiamo
il carattere fondamentale
del diradamento.
Nel fr.29 dobbiamo pensare la gloria con riguardo al fulgore. Ciò
che rifulge è l'igneo,
in opposizione a ciò che prediligono i molti e i cattivi. Il
migliore, che più di tutto ambisce
alla gloria, sta nella vicinanza con il pensatore, il cui sguardo
è indirizzato non soltanto ai
pánta, bensì allo én nella sua appartenenza ai
pánta […]. Come i migliori prediligono l'unica
cosa importante, cioè il fulgore della gloria rispetto a tutte le
altre cose, così il pensatore pensa
in direzione dell'uno riunente del fulmine, alla cui luce i
pánta vengono all'apparire, e non,
per così dire, ai pánta soltanto. E così come i molti
prediligono le cose transeunti rispetto al
fulgore della gloria, allo stesso modo gli uomini, i molti, non
comprendono lo én che riunisce,
che ricomprende insieme i pánta nel loro essere
distinti, bensi i pánta soltanto, le molte
cose.
athánatoi thnetoí, thnetoì athánatoi. Zõntes tòn ekeínon
thánaton, tòn dè ekeínon bíon tethneõtes […]. Se
interpretiamo athánatoi, nel senso abituale,
come dèi, e thnetoí come uomini, si tratta di un passo
interpretativo che non
possiamo sostenere con incondizionata sicurezza. Certamente, per
il mito
greco gli immortali sono gli dèi. Ma esistono anche essere
intermedi, gli eroi,
i quali, nati mortali, vengono elevati a semidèi e a immortali.
La cerchia di
immortali e mortali è riconosciuta con attendibilità e sicurezza?
Il problema è che cosa sia indicato con athánatoi e
thnetoí. In primo luogo, tuttavia, assumiamo
l’interpretazione mitologica e cogliamo gli immortali come dèi e
i
mortali come uomini. Nel fr. 62, anche gli dèi vengono
caratterizzati a partire
dalla morte. Gli immortali sono certamente sottratti alla morte,
non soccombono
ad essa, tuttavia sono aperti alla morte. In quanto immortali,
debbono
anche sapersi come quelli che guadagnano la loro propria
autocomprensione
nella negazione dell’essere mortale. Essi si sanno in quanto
quegli esseri
aperti alla morte, e tuttavia da essa non toccati, che
contemplano la morte degli
uomini e si fanno certi della loro propria incaducità alla vista
degli uomini
caduchi, che svaniscono. I mortali sono gli uomini che sanno il
loro essere
votati alla morte soltanto con riguardo agli dèi sempre essenti,
sottratti alla
morte. Thnetoí non è qualcosa come una designazione
oggettiva, detta a partire
da un punto di osservazione extraumano, bensì rinvia
all’autocomprensione
degli uomini nella comprensione del loro essere votati alla
morte, nella
misura in cui essi si sanno come morituri. Gli uomini si
sanno in quanto caduchi
nello sguardo levato in alto e nel riguardo agli dèi sempiterni,
sottratti
alla morte. Con gli immortali e i mortali è nominata la più
grande lontananza
intramondana tra esseri intramondani, l’arco della tensione tra
dèi e uomini,
che nondimeno, nella loro comprensione di sé e dell’essere, sono
riferiti gli
uni agli altri. I mortali sanno il loro proprio essere
evanescente nello sguardo
levato in alto e nel riguardo all’essere sempiterno degli dèi, e
gli dèi conseguono
il loro essere–sempre nel contrasto e nel confronto con gli
uomini costantemente
evanescenti nel tempo […]. E allo stesso modo […] gli uomini
muoiono in quanto transeunti, non soltanto nella misura in cui
hanno a che
fare con ciò che è transitorio. Essi non sono soltanto i più
evanescenti nel regno
dello svanire, bensì, comprendendo, sono aperti al tempo stesso
all’intransitorietà
degli dèi. All’appartenenza degli uomini a se stessi e a tutto
ciò
che li circonda pertiene un riferimento fondamentale a ciò che
non tramonta
mai.