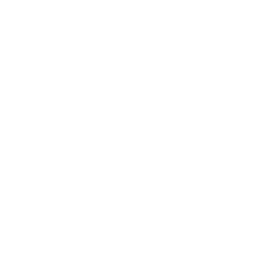Orizzonte Altro

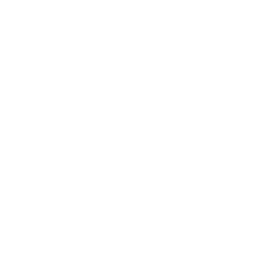
Antologia filosofica del 900
Max Scheler
Monaco di Baviera 1874 - Francoforte 1928
Secondo l'Ordine del Tempo
Morte e sopravvivenza
Tod und Fortleben, 1911-1914
Edizione italiana: Editrice Morcelliana, Brescia 2012
Tutto ciò che appartiene alla sfera della fede religiosa nasce, cresce, tramonta e muore nella storia. Non viene mai enunciato, dimostrato e poi confutato, come se fosse un teorema scientifico. L’opinione ancora oggi assai diffusa, secondo cui sarebbero state le confutazioni dell’Illuminismo intellettuale, della scienza e del suo progresso, ad avere demolito un sistema di credenze religiose, non è altro che un pregiudizio del razionalismo. Nessuna scienza e nessuna filosofia sarebbero mai state in grado di dissolvere e annientare la religione greca, se non fossero prima avvizzite le sue stesse radici nel contesto più generale in cui i greci vivevano e se non si fossero già formati, indipendentemente da qualsiasi scienza, i germi di un’altra forma di religione.
Per quanto […] il livello scientifico di un’epoca sia indipendente, rispetto al suo metodo e all’intrinseca correlazione tra le sue teorie, dal contenuto della visione del mondo suggerita dalla religione, esso è nondimeno determinato, rispetto ai suo fini, proprio dal contenuto della visione religiosa del mondo appartenente allo stesso periodo […]. Di solito si ammette questo fatto in relazione alla Scolastica […], ma lo si nega in relazione alla scienza moderna, che si preferisce pensare “libera” da ogni presupposto religioso. In realtà, però, fini e metodi della scienza moderna, ad esempio l’idea di ricondurre tutti i fenomeni a un meccanismo di movimenti, scaturiscono anch’essi da presupposti religiosi, che sono però di diverso tipo: un nuovo sentimento – a suo modo religioso – di distanza dal mondo e una smisurata volontà di manipolarlo e dominarlo.
Vediamo che negli ultimi secoli la fede nell’immortalità è andata via via declinando all’interno della civiltà europeo-occidentale. Qual è la causa? Molti ritengono che sia da vedersi in quello che chiamano il “progresso della scienza”. La scienza però è solita essere […] solo colei che sotterra la fede religiosa, ma non la causa della sua morte. Le religioni nascono, crescono e muoiono: esse non vengono né dimostrate, né confutate.
Se dunque cerchiamo le ragioni ultime che hanno portato al declino della fede nell’immortalità all’interno dei popoli appartenenti alla civiltà europeo-occidentale, dobbiamo togliere lo sguardo da tutti quei fenomeni che vengono illustrati nell’ambito di tutte quelle indagini di mero carattere scientifico […] perché essi rappresentano semplicemente i sintomi di tale declino. Dobbiamo soffermarci a guardare qual è l’idea che, in linea di principio, l’uomo moderno possiede della propria vita e della propria morte, e qual è la sua esperienza di esse. Emerge così un fatto a prima vista sorprendente: ciò che determina in primo luogo il declino della fede nella sopravvivenza non è per nulla il nuovo modo con cui l’uomo si rapporta alla questione di una sua possibile esistenza oltre la morte, domandandosi cosa vi sia dopo di essa e quale sarà il destino che l’attende, ma è piuttosto il rapporto dell’uomo moderno con la morte stessa. L’uomo moderno non crede più in una sopravvivenza, in cui la morte verrebbe per così dire superata, in quanto non vede più con chiarezza che la propria morte gli sta dinanzi, non “vive” più “al cospetto della morte”. Detto in modo più radicale, esso non crede più nella sopravvivenza in quanto, con il suo modo di vivere e di occuparsi delle faccende quotidiane, rimuove dalla chiara zona della coscienza un fatto intuitivo costantemente presente alla nostra stessa coscienza: che la morte è per noi certa; e questa rimozione prosegue fino al punto in cui non rimane altro che il puro sapere astratto di dovere un giorno morire. Laddove però la morte stessa non si presenta in forma immediata, laddove il suo sopraggiungere è dato semplicemente come un sapere che affiora occasionalmente in seguito ad un giudizio dell’intelletto, anche l’idea di una sopravvivenza al di là della morte non può che svanire. Il tipo “uomo moderno” non tiene in gran conto la sopravvivenza soprattutto perché in fondo nega il nucleo e l’essenza della morte stessa.
L’idea oggi più diffusa è che la nostra conoscenza della morte risulterebbe semplicemente dall’esperienza esterna che noi facciamo, per osservazione e induzione, del morire di altri uomini e degli esseri viventi che ci stanno attorno […]. Dobbiamo contestare decisamente l’idea secondo cui il concetto della morte sarebbe un concetto generale a cui si perverrebbe in modo puramente empirico a partire da una serie di casi singoli. Un uomo saprebbe comunque di essere un giorno colto dalla morte, anche qualora fosse l’unico essere vivente sulla terra, anche qualora non avesse mai visto alcun essere vivente subire quelle trasformazioni che portano al comparire del cadavere.
La certezza di dover un giorno morire […] si trova […] in ogni – per quanto piccola sia - “fase della vita” e nella sua struttura esperienziale […]. Quest’idea è uno degli elementi costitutivi non soltanto della coscienza di noi uomini, ma anche di ogni altra coscienza vitale.
La morte è un a priori per qualsiasi esperienza che noi facciamo (per osservazione o induzione) del contenuto mutevole di ogni reale processo vitale.
Il mutamento procede perciò in questa direzione: con la crescita dell’ampiezza del passato a spese dell’ampiezza del futuro e con una progressiva presa di coscienza della differenza che viene creandosi tra queste due dimensioni temporali: una differenza che è tutta a favore dell’ampiezza del passato. In questa struttura esperienziale tipica di ogni attimo vissuto dell’esistenza è proprio l’esperienza di tale direzione di mutamento a poter essere chiamata anche esperienza della direzione di morte. Questa è l’esperienza che ci porterebbe comunque ad avere la certezza di invecchiare, anche qualora non ce ne accorgessimo né attraverso la percezione esterna delle nostre rughe e dei nostri capelli grigi, né in seguito al cambiamento del nostro sentimento vitale.
La morte, dunque, non è una componente semplicemente empirica della nostra esperienza; appartiene, piuttosto, all’essenza stessa dell’esperienza di ogni vita, anche della nostra, l’essere in direzione della morte.
La morte, in quanto tale, non può per sua stessa natura venirci incontro nella forma di un’esperienza accidentale, di qualcosa in cui per così dire ci imbattiamo solo per caso, come fosse un muro contro cui andiamo a urtare camminando nel buio. Se dunque in certi periodi storici la morte sembra essere data effettivamente in questo modo, ciò non può essere considerato come un fatto radicato nella natura della coscienza stessa. Ma dev’esserci piuttosto una specifica causa, che rimuove dall’attenzione e dal giudizio la naturale coscienza della morte.
La morte reale si presenta sempre solo come conferma […] di una certezza intuitiva che è parte di ogni esperienza vissuta. La morte non assume l’aspetto di tale certezza nel punto in cui effettivamente finisce la vita […], ma piuttosto essa accompagna la vita intera come parte costitutiva di ogni suo momento.
Ora, se la certezza della morte è un elemento costante di ogni esperienza di vita, risulta però assai variabile il grado di chiarezza e di nitidezza con cui l’idea stessa della morte si presenta agli uomini, nonché il grado di interesse e di attenzione che essi rivolgono a questo contenuto. Rispetto al ruolo che l’idea della morte svolge effettivamente presso uomini, gruppo e periodi storici, vi sono infatti modi e livelli molto differenti […]. Soprattutto però vi sono ampi oscuramenti e rischiaramenti di questo sapere relativo alla morte – e questo avviene anche nella coscienza collettiva di intere epoche storiche. Se perciò l’evidenza della morte è un elemento costitutivo dell’esperienza di vita, la sua assenza – un fatto di cui si ha effettivamente riscontro – non può essere semplicemente una manchevolezza di tipo accidentale. Laddove ci imbattiamo in tale mancanza, bisogna piuttosto riconoscere una qualche causa positiva capace appunto di determinare l’oscuramento di tale certezza: si tratta della rimozione dell’idea di morte, dovuta al fatto di non riuscire a dominare questo pensiero, di non poter rassegnarsi alla morte stessa.
La rimozione naturale dell’idea di morte va ben distinta da un altro genere di rimozione: quella che fa parte dell’enorme immagine unitaria dell’“uomo europeo-occidentale moderno”,considerato come tipologia di massa. Questo tipo d’uomo, che è andato lentamente imponendosi a partire dalla fine del tredicesimo secolo fino ad arrivare all’età in cui il capitalismo ha raggiunto il suo stadio più evoluto, possiede una sua configurazione unitaria e ben definita […]. Tale tipo d’uomo è definito dalla “struttura della sua esperienza”. Da questa struttura d’esperienza tipica dell’uomo moderno estrapolo solo un aspetto: il lavoro e il profitto, attività che per la tipologia più antica di uomo erano volontarie, dettate in misura maggiore o minore da bisogni vitali, diventano invece per l’uomo moderno istintive e, in quanto tali, illimitate.
Per l’uomo moderno medio “pensare” corrisponde a “calcolare”, il “corpo vivente” diventa una mera realtà materiale tra le altre, una parte del meccanismo universale del mondo fisico […]. V’è la tendenza a subordinare tutti i valori vitali alla dimensione dell’utile e a ciò che è un meccanismo, sia in ambito morale che giuridico.
Il mondo è ora solo oggetto di eterna angoscia, non è più il “caso” colto con animo gioioso e audace. L’angoscia genera un modo di vivere dominato da uno spirito calcolatore.
Sono soprattutto questi nuovi, ormai divenuti istintivi, impulsi a lavorare e a fare profitti in modo smisurato ad essere alla base di una nuova e generale disposizione interiore nei confronti della morte.
L’uomo antico temeva la morte; questo nuovo tipo d’uomo non la teme più. Il suo smisurato impulso al lavoro e al profitto […] lo narcotizza […] rispetto al pensiero della morte. Gettarsi nel vortice degli affari avendo come fine questo stesso affaccendarsi […] rimuove dall’uomo moderno l’idea chiara e luminosa della morte, facendo sì che l’illusione di una continuazione infinita della vita divenga un atteggiamento fondamentale della sua esistenza. Non v’è alcun senso o scopo all’origine di questo “affaccendarsi” senza precedenti; ma è come se lo stato di agitazione in cui versa l’apparato psicomotorio dell’uomo moderno – conseguenza della profonda coscienza dell’indegnità d’essere e della disperazione metafisica di questo tipo umano – creasse solamente in seguito, quale senso apparente della sua stessa esistenza, l’istinto a un lavoro e a un profitto sena limiti, nonché il valore morale ad esso correlato, quello che diventa una sorta di “surrogato” della vita eterna, ovvero il cosiddetto “progresso”, un progresso senza scopo e senza senso, il cui unico senso – come ha dimostrato Sombart – diventa il progredire stesso! Per quanto l’uomo moderno “faccia i conti” con la morte “assicurandosi” in mille modi contro di essa, la morte stessa non è per lui un qualcosa di davvero evidente: egli non vive “al cospetto” della morte […]. La morte non fa più paura: poiché è la paura stessa a scansarla via, è l’angoscia vitale, la stessa che aveva portato a un modo di vivere dominato da uno spirito calcolatore, a scacciarla […]. Non c’è quindi da stupirsi se l’arrivo della morte non appare più come necessario compimento di un senso intrinseco della vita stessa […]. La morte sopraggiunge soltanto come una catastrofe.
Esiste un fenomeno assoluto della morte che è legato all’essenza del vivente e a tutte le sue forme di unità. Esiste così non solo una morte individuale, ma anche una morte delle razze e dei popoli. E ora, superata l’ondata darwinista, si comincia anche a riconoscere l’esistenza di una morte della specie, che non risale a una eliminazione dall’esterno, attraverso una selezione conseguente a mutate condizioni di vita, ma ad un esaurimento dall’interno degli agenti vitali che guidano la specie stessa.
La prima condizione della sopravvivenza dopo la morte è la morte stessa. La prima condizione per poter credere nella sopravvivenza è l’eliminazione delle forze che spingono l’uomo moderno a rimuovere l’idea della morte andando ben al di là di quanto richiederebbe il normale istinto di vita […]. “Sopravvivenza della persona intesa sia nella sua dimensione corporea che in quella spirituale”: queste parole acquistano senso soltanto di fronte al fenomeno della morte, di fronte all’esistenza e all’ineluttabilità del destino di ogni essere vivente.
Cominciamo a distinguere due cose: da una parte l’idea e la fede nella cosiddetta “eternità dello spirito”, e dall’altra l’idea e la fede nella “sopravvivenza della persona”. Mi rivolgo anzitutto al primo aspetto. Vedo chiaramente davanti a me la mia morte. Nel continuo processo di crescita di quanto esperisco come effetto del mio passato […]; nel continuo processo di restringimento di quella che, nell’atto dell’attesa immediata, percepisco come sfera del futuro; nella pressione sempre più forte a cui si trova sottoposta la dimensione del presente, schiacciato tra presente e futuro; in tutti questi casi avverto – di secondo in secondo – il progressivo avvicinarsi della morte […]. Ma mentre vedo la morte avvicinarsi come incontrovertibile destino di ogni possibile vita – e quindi anche della mia, anche della vita che pulsa in me –, in ogni momento di questo percorso sperimento e compio comunque atti il cui senso e le cui correlazioni di senso sono totalmente indipendenti da questa profonda e misteriosa esperienza […]. Di certo in questi atti trascendo ogni realtà relativa alla vita; posso dire che attraverso di essi il mio spirito entra a contatto con un regno, una sfera a cui appartengono unità di senso senza tempo ed eterne […]. Negli atti d’amore, esattamente come in quelli di pensiero, è presente un senso di eternità, di per sé indipendente dalla vita e dalla morte.
Tale dottrina dello spirito era già stata chiaramente formulata dagli antichi greci. Del resto essa può essere riconosciuta anche da chi nega ogni forma di sopravvivenza personale. Ma che dire della teoria in cui viene affermata la sopravvivenza personale?
V’è un’esperienza fondamentale che ritorna costantemente nell’attento esame filosofico di ogni ambito di intenzioni spirituali […], un’esperienza che a grandi linee fa però continuamente anche l’uomo naturale, ne abbia egli coscienza a livello riflessivo oppure no. Per descrivere quest’esperienza basta dire poco: anzitutto, la persona spirituale in ogni suo atto (percezione, ricordo, attesa, volere, potere, sentire) trascende ciò che le è “dato” come “limite” imposto al corpo, da questa realtà sempre correlata alle esperienze che va facendo (“limite” che può essere di tipo spaziale o temporale, ma anche relativo al contenuto qualitativo degli stati corporei della persona stessa); in secondo luogo, la quantità di contenuti di questi atti spirituali è sempre più grande rispetto alla quantità di stati corporei ad essi corrispondenti.
In tutti questi casi troviamo il medesimo fatto fondamentale, davvero costitutivo per lo spirito, per il suo essere e per la sua vita: pur avendo un legame con i mutevoli stati corporei e con i loro correlati oggettivi presenti nella struttura materiale di un corpo vivente – per quanto attiene alla scelta specifica di ciò che diventa contenuto delle intenzioni della persona –, l’essenza della persona stessa e di queste stesse intenzioni, la loro “correlazione di senso” e il loro rispettivo “contenuto essenziale”, non sono mai scindibili e suddivisibili in stati corporei o sensazioni, né in loro derivati o riproduzioni di tipo genetico, e così via. E a sua volta la persona stessa, con il suo mondo spirituale, è sempre qualcosa di più, possiede una maggiore pienezza eidetica rispetto a tutte le sue possibili intenzioni.
Se fa parte dell’essenza stessa dello spirito personale il fatto che esso, nell’esecuzione dei suoi atti, arrivi per così dire – e mi si permetta l’immagine – a scagliare dei dardi che travalicano i limite del corpo e i suoi diversi stati, allora possiamo domandare: quando nell’atto di morire il corpo vivente cessa di esistere, che cosa appartiene all’essenza della persona? […]. La mia risposta è questa: all’essenza della persona appartiene esattamente la stessa cosa che le apparteneva quando l’uomo era in vita, perciò niente di nuovo: come nel corso della vita i suoi atti “si protendevano” oltre gli stati corporei, così la persona stessa si spinge ora anche al di là dello sfacelo del suo corpo. E soltanto questo slancio, questo protrarsi e protendersi, questo atto dinamico che fa parte della sua essenza, costituirà e deve costituire, nel momento della morte, l’intera esperienza e l’intero essere della persona. In questo modo non si vuole dire che essa abbia soltanto l’intenzione o addirittura l’attesa della sopravvivenza. Sarebbe una sciocchezza […]. Quanto detto significa piuttosto che nell’attimo della morte la persona fa esperienza di continuare ancora a vivere. O più semplicemente: la persona sperimenta per il proprio essere quello che nel corso dell’esistenza aveva già chiaramente sperimentato per i propri atti e i loro contenuti: l’indipendenza del suo essere dal corpo. Chi sostiene che ciò avverrebbe soltanto nell’“intenzione” della persona, dimentica che l’intenzione e l’atto sono in concreto l’essenza della persona stessa, e che quest’ultima non è affatto una cosa o una sostanza che “avrebbe” o “perseguirebbe” un’intenzione. Ma in questo modo abbiamo detto tutto ciò che potevamo sapere da un punto di vista filosofico. Oltre questa “esperienza di slancio” al di là dei confini stabiliti dal corpo, non so nulla. Non posso affermare che la persona esista dopo la morte, né tanto meno posso dire come esista. Non potrebbe forse accadere che, attraverso una sorta di miracolo metafisico, la persona cessi di esistere proprio con questo suo ultimo slancio, spegnendosi definitivamente in “esso”? Non potrò mai sapere se la sua esistenza si interrompa. Non potrò mai sapere se la sua esistenza continui. L’unica cosa che, in considerazione delle leggi essenziali che appartengono alla persona, può essere vissuto in modo immediato, è questo slancio; esso appartiene all’esperienza che la persona fa di sé.
Ecco dov’è dunque il dato intuitivo essenziale che realizza l’idea della sopravvivenza nelle sue mille configurazioni, dalla fede dei primitivi fino alle raffinatissime concezioni di Kant e di Goethe: esso si trova nell’esperienza immediata dell’“eccedenza” di tutti gli atti spirituali della persona rispetto ai suoi stati corporei, che è al tempo stesso eccedenza dell’essenza “atto spirituale” rispetto all’essenza “stato corporeo”, come anche nell’esperienza, vissuta nell’atto della morte, di eccedenza della persona rispetto all’unità corporea. E ora è chiaro che questo fenomeno di eccedenza può manifestarsi chiaramente solo se e nella misura in cui sia effettivamente valida anche la prima delle considerazioni qui proposte, cioè se e nella misura in cui sia data la morte stessa, se e nella misura in cui l’uomo non soltanto sappia e giudichi che un giorno morirà, ma viva “al cospetto” della morte.
L’orientamento essenziale di ogni vita – contrapposta alla natura inorganica – è tale che essa passa da uno stato di massima libertà ad uno di massima costrizione, corrispondente – quest’ultimo – alla morte. Esattamente opposta è invece la direzione essenziale di sviluppo del nostro spirito: v’è qui un movimento che parte da uno stato di massima costrizione, dovuto alla necessità di soddisfare i proprio bisogni vitali, e giunge a una condizione di sempre maggiore affrancamento dalle esigenze della vita, ad un atteggiamento di dedizione ai puri contenuti delle cose, dei valori e delle persone.
Fin dove può protrarsi la sopravvivenza della persona nel corso dell’essere? La mia risposta è questa: fin dove continua a sussistere questa stessa eccedenza – l’eccedenza dello spirito sulla vita. Di più non so.
Credo però che la sua esistenza continui in quanto non ho motivo di ritenere il contrario e le condizioni essenziali di ciò in cui credo risultano chiaramente soddisfatte […]. Siamo giunti ad un punto limite. Sostenere l’esistenza della persona dopo la morte è un atto di pura fede; e qualsiasi domanda relativa al modo di tale sopravvivenza non è altro che ingiustificata e irriverente curiosità.
Il borghese
Der Bourgeois, 1914
Edizione italiana: in, Ascesa e declino della borghesia. Tre saggi sullo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2020
Tra i molteplici segni che ci indicano lo spegnersi di quell’ordine vitale sotto la cui forza e direzione ancora viviamo, non ne vedo alcuno che sia più convincente dell’estraneamento profondo che oggi riempie le teste migliori e i cuori più forti […] di fronte a questo ordinamento stesso […]. Gobineau, Nietzsche, Jakob Burckhardt, Stefan George: per diversi che siano questi uomini in tutto (e per l’uomo è essenziale), in una cosa hanno sentito e pensato allo stesso modo: che l’insieme delle forze che hanno costituito l’elemento caratteristico della totalità del nostro presente ordine vitale poteva poggiare soltanto su di una profonda perversione di tutte le forze spirituali essenziali, su di un delirante sovvertimento di ogni ordine significativo dei valori […]. Se poi qualcuno, di fronte ai nomi citati […] osserva che sempre e ovunque vi sono stati degli outsiders che combattevano la cultura dei loro giorni (come Fichte contro il periodo storico della “consumata peccaminosità” dell’Illuminismo), o si mostravano a essa indifferenti o superiori; ebbene questi dovrebbero riflettere su due aspetti: quell’“estraneamento” […] afferra sempre più fortemente anche i veri e propri figli del tempo, e non solo più i “poeti e i pensatori”, ma anche il grande uomo di commerci Walther Rathenau, e l’economo-politico Werner Sombart (che fa affidamento ed è penetrato nell’intimo dalle forze vitali della nostra vita economica) […]. L’estraneamento non riguarda perciò questo o quel singolo aspetto o gruppo del nostro ordine vitale, ma la sua totalità, e ciò che essa fa perché è diretta, in ultima analisi, contro il tipo d’uomo che finalmente garantisce l’esistenza e la continuità di questo ordine vitale […], un tipo determinato, particolarissimo, che ha portato al nascere e all’edificare l’ordine vitale capitalistico e che continua a portarlo.
Noi cerchiamo le prime tracce del “borghese” già nel XIII secolo, che in ogni terreno della scienza storica appare sempre più come la grande svolta cruciale dei tempi, nella quale un “uomo” nuovo si afferma e che, indipendentemente dalla sua specificazione nazionale, religioso-ecclesiastica, politica, riversa il suo spirito anche nelle più antiche istituzioni, per esempio la Chiesa cattolica.
Ci si dovrà chiedere se anzitutto vi è qualcosa come lo “spirito capitalistico” in quanto causa prima dell’ordinamento capitalistico. Tanto i sostenitori della visione economica della storia, quanto – in modo alquanto strano – molti dei nostri più qualificati storici, si preoccupano di negarlo. Quelli dicono che sì, vi sarebbe uno “spirito capitalistico” – ma che questo non è che una pura conseguenza delle forme capitalistico-economiche di organizzazione e delle forme tecniche di produzione, che si sarebbero “sviluppate” dalle più antiche con obiettiva necessità. Gli altri invece pensano che le motivazioni tipiche dell’uomo economico siano state nella storia sempre in fondo le stesse, che sempre per esempio vi sia stato un tendere alla ricchezza al di là della conservazione del proprio stato sociale, sempre un impulso al guadagno o al lavoro al di là del soddisfacimento del bisogno di una comunità ancora limitata, ecc., e vi sarebbero solo differenze di quantità, in parte, e in parte differenze d’ampiezza nella gradazione più forte di questi motivi in gruppi più grandi […]. Non i nuovi fondamentali atteggiamenti della vita impulsiva e il nuovo ethos – vorremmo dire, più che nuovo “spirito” – di un nuovo tipo d’uomo avrebbero prodotto il capitalismo, bensì soltanto fattori come il contraccolpo sugli uomini dei “rapporti economici” che si formavano attraverso una motivazione fondamentalmente uniforme, i progressi della scienza e della tecnica, l’incremento crescente della popolazione delle città avrebbero avuto, finalmente, per effetto cumulativo ciò che noi chiamiamo capitalismo. Ci sembra che il merito più indiscutibile di Sombart sia quello di aver rotto con questi punti di vista.
Io sono convinto che una serie di leggi di fondazione della causalità storica, che la concezione economica della storia afferma come valide per la storia universale, possiedano piena validità per il campo dell’essere e divenire storico delimitato dallo spirito del capitalismo. Leggi di questo tipo sono: che le formazioni di classi, unità dunque di interessi economici, solo secondariamente conducono a unità di status, a unità di costume, a unità di cultura […]; che la ricchezza anzitutto “conduce” al potere; che l’incremento demografico e il benessere degli stessi gruppi sono in proporzione inversa tra loro, e che i motivi economici determinato per primi la quantità e il genere della riproduzione; che l’applicabilità tecnico-economica dei risultati della conoscenza – del tutto al di là dell’intenzione soggettiva (anche se diretta alla pura “Verità”) del singolo ricercatore – ha determinato già i principi di scelta del vedere e dell’osservare, e inoltre le “forme di pensiero” e i metodi di pensiero, e con questo il carattere della scienza e della Weltanschauung del mondo moderno.
Per il processo storico dell’uomo pre-capitalistico non valgono affatto questi tipi di dipendenza degli elementi della realtà storica. Anzi, per alcuni di questi principi valgono proprio le regole opposte, per esempio che un ordine sociale, unificato da ascendenza e tradizione, acquista anche certe forme di diritto e di cultura, ma soprattutto perviene a una certa unità e uniformità qualitativa e quantitativa del possesso, dunque a una forma di “classe”. E così che anche ogni tendenza al guadagno del tipo pre-capitalistico è determinata, misurata e limitata dall’idea di “conservazione del proprio stato”. Allo stesso modo, è la posizione politica di potere a limitare e determinare ovunque la possibilità della formazione della ricchezza; non invece la ricchezza il potere e la sua estensione.
Il signore terriero […] non è divenuto tale per la sua ricchezza […]. Ovunque sono i privilegi politici dello status che […] hanno o possono avere per conseguenza la ricchezza, non viceversa, come sotto il dominio dello “spirito capitalistico”.
Alcuni storici […] non vedono la struttura del nuovo ethos – anche come nuova intenzione dell’economia. Vincolati essi stessi dalla struttura categoriale dell’esperienza che predomina nel loro proprio tempo, essi non possono veramente immedesimarsi nel tipo dell’uomo pre-capitalistico. E col far questo non possono vedere chiaramente neanche le peculiarità del tipo capitalistico. Perciò, in primo luogo, passano sopra al fatto che la modificazione degli ideali e dei progetti dominanti è anche qui molto più essenziale di quella della realtà dell’evento storico. Certo, anche nel periodo pre-capitalistico, vi sono stati dei singoli, anzi degli interi gruppi, il cui impulso al guadagno si spingeva di là dell’idea della conservazione del proprio stato. La cosa fondamentale è che ciò non veniva in genere sentito come normale e “giusto”, ma come una “manifestazione abnorme”, e che gli uomini in questione non vedevano nell’illimitato guadagno un “santo dovere”, ma si abbandonavano a questo impulso con “cattiva coscienza”. La novità è allora che l’abnorme è diventato normale e che viene intrapreso e rivestito di “buona coscienza”, anzi con la sanzione di una “doverosità”.
Già per il fatto che Sombart intitoli il suo libro Il borghese, dimostra che è lo spirito borghese quello al quale assegna il primato genetico nella formazione dello spirito capitalistico. Ciò che parla a favore di questa sua concezione è soprattutto il chiedersi come delle nature positive, forti e ardite, impegnate a organizzare, che concepivano e ponderavano vasti piani, che si mostravano qualificate all’“impresa” in grande stile, si rivolsero proprio alla vita economica e a questa, poi, nella sua dimensione ordinaria, vi riversarono addirittura le loro forze. Giacché è proprio qui il paradosso del capitalismo, che uomini dalle qualità di valore elevato (in senso biologico e spirituale), qualità che certo non li spingevano originariamente all’impegno nella vita di guadagno economico, divengano a questo punto proprio i capi della vita economica. La guerra, il servizio verso lo stato, il servizio della Chiesa, l’impresa coloniale, tutto ciò “si trova” originariamente assai più vicino a questo tipo di spirito che non il negozio, il commercio, l’industria […]. Perché queste forze fluirono nella vita economica? Come avvenne che dettero la loro anima bruciante, grande, tempestosa a questo ramo dell’attività umana disprezzato nell’antichità e nel Medioevo? Come fu spinto il tipo d’uomo eroico e geniale su un terreno la cui essenza è lavoro e calcolo arido e continuo? Si può soltanto pensare che quelle forze, le quali una volta presenti esigevano di essere messe in funzione, si rivolsero necessariamente al nuovo campo, e questo perché l’ordine della società, già lentamente trasformato dallo spirito borghese, la sua nuova morale, la sua nuova consapevolezza giuridica ecc., escludeva l’abbracciare campi più adeguati, anzi li stigmatizzava in parte come male e delitto (per esempio la morale commerciale, nei confronti della guerra), e con ciò spingeva quelle forze a divenire, sul piano dei nuovi fini economici, la forza motrice per il nuovo progresso. Le vecchie forze avevano perso la loro “morale” – e la nuova morale borghese le prese al suo servizio e le legò al suo carro. Non è dunque lo spirito di impresa la componente eroica del capitalismo, non il “regale commerciante” e organizzatore, ma il piccolo borghese risentito che ha sete di maggiore sicurezza vitale e di una maggiore prevedibilità nella sua vita angustiata (che costituisce, come Sombart così acutamente descrive, il nuovo sistema di valore e di virtù del borghese), a precedere nella formazione dello spirito capitalistico.
Che cosa è dunque questo speciale scherzo della natura che Sombart chiama “borghese”? […]. Non siamo ancora sufficientemente liberi dallo “spirito del capitalismo” da poter “comprendere” completamente il tipo d’uomo che lo ha introdotto. Dobbiamo ancora più o meno odiarlo, e ciò significa fraintenderlo. Ma verrà il tempo nel quale potremo anche amarlo. Allora egli assumerà forse, nel nuovo quadro, una forma più conciliante di quella che ne fa Sombart.
Il borghese e i poteri religiosi
Der Bourgeois und die religiösen Mächte, 1914
Edizione italiana: in, Ascesa e declino della borghesia. Tre saggi sullo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2020
Sombart concepisce i poteri etico-religiosi, che secondo lui hanno favorito il capitalismo, e cioè la teoria morale e la pratica della confessione in Tommaso d’Aquino e nella sua scuola, solo come cause derivate e retroattive per la formazione di questo spirito. Nella lenta vittoria dell’aspetto razionalistico dell’alta scolastica sullo spirito agostiniano della Chiesa più antica (in quella direzione cioè che tendeva a porre in rilievo il carattere e il valore particolare del “mondo” rispetto al “sopramondano”, dell’ambito di ragione e di natura rispetto a quello di rivelazione e di grazia), Sombart vede dunque una manifestazione concomitante del fatto che il tipo “borghese”, come tipo biologico già presente e vittorioso, si creò il suo analogo ideologico anche nell’ambito della religione cristiana e della Chiesa.
Max Weber mette in luce nel nuovo sistema di vita e dottrina protestanti, in primo luogo nella sua conformazione calvinista, uno dei momenti originari dell’illimitato tendere-al-lavoro […], e spiega che l’impulso di guadagno è solo come una semplice manifestazione concomitante al primario impulso di lavoro senza limiti e alla sua santificazione etico-religiosa come “dovere” valorizzato in senso ascetico. Sombart, invece, ritiene che l’impulso al guadagno sia un elemento originario rispetto al nuovo impulso al lavoro, e mostra che nel sistema dottrinale tomista viene data la prima giustificazione di una tendenza al guadagno puramente mondano, indipendentemente dalla ricerca di salvezza.
Quello che veramente importa, come una delle prime condizioni anticipatrici del sorgere del nuovo spirito capitalistico, è l’emancipazione, in via di principio, dello spirito della vita da qualsiasi ispirazione di una autorità spirituale etico-religiosa, e da ogni direzione sacerdotale.
Prescindendo dalle personalità-guida, che sono del tutto imprevedibili: capacità di accoglimento e diffusione di queste dottrine erano senza dubbio preparate e condizionate dal tipo vitale del “borghese”, che appunto giungeva al potere. Non il protestantesimo – neanche il calvinismo – ha “prodotto” lo spirito borghese, ma lo spirito borghese ruppe nel calvinismo, anche all’interno della sfera religiosa ed ecclesiastica, le barriere che la Chiesa cattolica, e Tommaso d’Aquino stesso, gli avevano posto.
L'avvenire del capitalismo
Die Zukunft des Kapitalismus, 1914
Edizione italiana: in, Ascesa e declino della borghesia. Tre saggi sullo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2020
Il capitalismo non è, in primo luogo, un sistema economico di distribuzione di possesso, ma un sistema complessivo di cultura e di vita. Questo sistema è sorto dalle finalità e dalle valutazioni di un determinato tipo bio-psichico d’uomo, del borghese, cioè, ed è portato avanti da questa tradizione. Se questa tesi, che noi condividiamo con Sombart, è esatta, ne consegue, secondo il principio cessante causa cessat effectus, e con l’altro non meno valido che solo con la modificazione (diminuzione) della causa è da attendersi una modificazione (diminuzione) dell’effetto, che anche solo mediante il fatto e nella misura che appunto questo tipo di uomo perda la sua autorità è da sperare un tramonto del capitalismo; sia per il fatto che egli porta nella sua propria natura e nella tendenza di sviluppo a esso immanente il principio della sua scomparsa, sia per il fatto che il suo ethos verrà provato del suo dominio dall’ethos di un diverso tipo d’uomo.
Già in base a questa impostazione del problema, che necessariamente si ottiene dai risultati dell’indagine sulle cause del capitalismo, è escluso attendersi la scomparsa del capitalismo dal successo della modificazione dell’attuale ordinamento della proprietà, della produzione, e distribuzione dei beni economici (come si aspettano ed esigono tutti i partiti socialisti).
Se questo tipo di risoluzione del problema […] poggia sull’errore causale che il tipo del borghese sia una manifestazione conseguente all’“ordinamento” capitalista (e non al contrario, come noi affermiamo, questo ordinamento una conseguenza dello “spirito borghese”); è d’altra parte chiaro che ognuna di tali modificazioni può divenire possibile soltanto nella misura in cui quel tipo d’uomo, unitamente al suo “spirito” perda la sua autorità.
Ma un tale evento non è da attendersi dal puro accrescersi numerico del proletariato come unità economica di classe, nonché dal corrispondente accrescersi della sua posizione politica giuridica e di potere, già per il fatto che lo spazio di classe del “proletariato” stesso presenta solo una modificazione determinata dell’ethos di quel tipo, nella misura almeno che, in quanto “proletario”, cioè in quanto unità vincolata da interessi di possesso gli siano propri atteggiamenti comuni: appunto quelli che si riferiscono alla sua posizione speciale di oppressione nello stato borghese e nella società borghese. Né il metodo rivoluzionario sindacale, né quello evoluzionista-parlamentare e di organizzazione economica del lavoro, in questo processo permettono un qualche decisivo successo, finché l’ethos borghese possiede per intero le diverse unità in conflitto, e finché le unità e i contrasti di interesse economico contro la minoranza detentrice del possesso e del potere danno la struttura – sempre all’interno delle possibilità di questo ethos, e non al di fuori di esso – in unità di lotta.
Giacché sempre e ovunque un numero necessariamente “piccolo” di dominanti determina quali sistemi di valorizzazione divengono dominanti. È anzitutto il fatto che i sistemi di valorizzazione eticamente e biologicamente inferiori sono divenuti quelli della minoranza dominante, a fare della “rivoluzione” stessa una direzione costante nel corso dello sviluppo moderno dello stato. L’essere lo stato (come realtà sociologica) caduto, in diversi popoli, in misura diversa, nelle mani del tipo vitale inferiore, o almeno delle sue valorizzazioni – e il cadervi sempre di più –, è la principale caratteristica di quella interiore, silenziosa trasformazione che si trova dietro a tutte le violente rivoluzioni e movimenti di massa. L’“idea” di un “diritto alla rivoluzione” – senza senso, dove la minoranza dominante è imbevuta dello spirito della nobiltà d’animo – acquista la sua giustificazione profonda solo sotto il dominio della borghesia.
Ancor più promettente per il futuro, però, ci sembra l’unità dei movimenti odierni che si consumano al di fuori della vita economica e che tendono a ridare una giusta misura al suo significato nella vita dell’uomo. In essi anzitutto leva il suo capo il nuovo tipo d’uomo – ancor timidamente, è vero – il tipo che era stato oppresso dall’epoca capitalistica […]. Questi mutamenti lasciano sperare proprio perché non sono limitati a determinate classi sociali o partiti, ma attraversano tutte le classi col loro nuovo spirito. Se si tratta, nel superamento del capitalismo, della rimozione di un tipo determinato e dei suoi ideali dal potere, anche da questi mutamenti – e non dalla vittoria di una “classe” o “partito” determinati – c’è da attendersi qualcosa di essenziale.
La posizione dell'uomo nel cosmo
Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928
Edizione italiana: Armando Editore, Roma 1998
Nessun ponte e nessun sentiero per quanto esiguo congiunge di fatto l’homo naturalis e la sua preistoria, ricostruita su ipotesi, con l’“uomo” della storia, che siamo in grado di comprendere in base alle leggi dei significati intellettuali, e nel cui passato possiamo guardare direttamente, indipendentemente da ogni tipo di “conclusioni causali”, grazie alla fonte, al monumento, al documento. Perciò non si deve assolutamente pensare che la “parola” e il linguaggio risultino in qualche modo composti dalla sensibilità e dall’intelletto. L’essenza, il nucleo della parola sono per l’appunto costituiti da quel passaggio, che si verifica nell’Erlebnis, da suono a significato, e questi fungono esclusivamente da punto di partenza e di arrivo per un movimento intenzionale dello spirito. Solo per questa ragione una parola può mutare, nel corso di una serie di sviluppi storici, sia la sua sostanza sonora sia il suo significato (modificazione fonetica e modificazione semantica), senza nondimeno perdere la sua identità e cessare di essere “questa parola”. L’elemento che permane identico è costituito per l’appunto da quel passaggio da suono a significato, che noi sperimentiamo e che costituisce proprio l’essenza della parola.
L’animale malato, l’animale intelligente e capace di costruirsi degli utensili – senza dubbio qualcosa di assai deforme – diviene subito magnifico, grande e nobile, quando si consideri la sua possibilità di trasformarsi in un essere che trascende ogni forma di vita, e nell’ambito di questa, anche se stesso, proprio in virtù di quell’attività che, relativamente alla “conservazione della vita” e ai suoi fini, appare estremamente risibile. L’“uomo”, inteso in questo senso del tutto nuovo, è l’intenzione e il gesto della “trascendenza” stessa […]. Questi è solo un “infra”, una “frontiera”, un “passaggio”, un “apparire di Dio nel corso della vita”, e un’eterna “trascendenza della vita stessa”.
Là ove il desiderio di Dio chiama prepotentemente alla riscossa tutto l’essere e tutto lo spirito contro ciò che è solo “mondo”, ecco l’homo bestia naturalis trasformarsi in homo […]. L’uomo, come homo naturalis è un animale, un breve sentiero laterale imboccato dalla vita, entro la classe dei vertebrati e, poi, dei primati. Dunque non si è affatto “evoluto” dal mondo animale, ma è stato animale, è animale e resterà sempre animale. Colui che cerca Dio, di contro, rientra con i suoi attributi sostanziali in una nuova classe eidetica oggettiva, in un regno di “persone”, che non si è affatto “evoluto”, così come i colori, i numeri, lo spazio e il tempo e altre essenze, dal mondo animale. Questo regno di “persone” si è schiuso ed è apparso in determinati punti del mondo vivente, e l’homo naturalis non può essere il risultato di un’evoluzione animale, appunto perché è stato, è, e resterà sempre un animale.
“Non esiste un’unità naturale dell’uomo”. Un quid nuovo, relativo all’essenza e alla specie – e non al grado – appare non nell’homo naturalis, ma solo nell’uomo “storico”, in relazione con Dio; in quell’uomo che acquista una sua unità solo in virtù di ciò che deve essere e diventare: e precisamente in virtù dell’idea di Dio, di una persona infinita e perfetta.
Non vi è nell’uomo né un moto, né un fenomeno, né una “legge” che non appaia anche in quella parte della natura che si trova al di sotto di lui, ovvero al di sopra di lui, nel regno di Dio, nel “cielo”: l’esistenza che egli possiede è esclusivamente un “trapasso” dall’uno all’altro regno, un “ponte” e un movimento tra di essi; e l’uomo non può – come intuì Pascal – sottrarsi all’alternativa di far parte dell’uno o dell’altro. Perché persino la non decisione si configura come decisione di essere un animale, e, come tale… un animale degenerato. Il fuoco, la passione di trascendersi – si chiami la méta, “superuomo” o “Dio” – costituisce l’unica sua vera umanità.
Per Nietzsche invece la “vita” significò un’energia che scorre nell’immenso e sollevandosi incessantemente in ondate colme di valori, forma con il suo apparire degli esseri che il suo declino irrigidisce in leggi: “solo là ove la volontà si irrigidisce, ecco ergersi la legge” […]. La vita non è qualcosa che si “adatta” o che viene “adattata”, ma è invece la tendenza a plasmare, a formare, a dominare, anzi a integrare la materia […]. La “vita” appare a Nietzsche, nelle sue manifestazioni più grandiose o in quelle più modeste, una sorta di impresa temeraria, un’“avventura” metafisica, uno slancio audace entro quelle possibilità ontologiche, che assumono nel successo quelle forme che diverranno possibile oggetto della scienza solo in un successivo momento […]. Pertanto originariamente la vita non è lotta per conservare l’esistenza individuale e specifica, e una siffatta definizione non fa che falsificare il vero concetto di vita. Quest’ultima è invece tendenza all’auto-accrescimento, qualcosa il cui “divenire” è già di per se stesso una “crescita” che comprende altresì l’integrazione della materia.
Nietzsche potrebbe addirittura definire la vita come un “divenire”, che può solo crescere o declinare, aumentare o diminuire, ma mai “mantenersi” in un moto uniforme alla maniera di un corpo che ubbidisce al principio di inerzia. Questo modo di concepire, che sta a fondamento delle scienze biologiche, è il risultato di un’analogia tratta dalla meccanica e applicata arbitrariamente a un quid essenzialmente a-meccanico […]. La convinzione che un certo tipo umano non potesse non falsare e misconoscere, anche nella sua attività di scienziato–biologo, il carattere più autentico della vita, nacque in lui dalla profonda intuizione che gli ideali e i valori dell’uomo moderno, del borghese, del capitalista, dello scienziato, dell’artista del suo tempo […] fossero i valori di un tipo d’uomo nel quale la “vita” declina anziché crescere. Poiché, evidentemente, le concezioni biologiche non possono essere migliori del tipo di scienziato che le elabora, sarà la sua morale – nel senso più lato di un ordinamento universale di valori – a determinare altresì gli ideali scientifici, i metodi, e le finalità della ricerca. Coll’affermare che lo scienziato moderno “appartiene al tipo plebeo”, Nietzsche intendeva gettar luce sui fondamenti della scienza moderna, chiarendo come la vita declinante, anche quando è ammantata da un’intelligenza obiettiva, non può non interpretare l’insieme della vita organica secondo i suoi propri valori di fondo. I quali valori, per l’uomo nato schiavo, arrendevole, spinto dalle paure verso il “calcolo”, la “prudenza”, l’“accortezza” e l’“economia”, si identificano con la capacità di garantire la “conservazione dell’esistenza” e la “facoltà dell’adattamento”. Nietzsche presentiva […] che la nuova biologia meccanicistica affonda le sue più profonde radici in una morale utilitaristica; che la teoria darwiniana della sopravvivenza di ciò che è “adatto” o “utile”, e per la quale l’organo sarebbe uno strumento utile, insieme alla sua premessa maltusiana per cui i quadri della vita organica sarebbero insufficienti, e a molte altre teorie del genere, non sono in fondo che una proiezione, nell’ambito della natura organica, di determinati valori e preoccupazioni plebei.
Il fatto che tutti i processi organici di crescita e di sviluppo non avrebbero nell’ambito dell’“evoluzione” individuale e generale la forza positiva di cause prime, ma sarebbero esclusivamente gli epifenomeni dei processi conservativi di quanto è accidentalmente utile, ai quali verrebbe poi ad aggiungersi l’attività del tutto negativa dell’eliminazione mediante selezione dell’inadattato: tutto ciò viene ad essere la conseguenza teorica di una concezione di fondo della natura organica dalla quale era partito Darwin, e che non era affatto il risultato né delle sue osservazioni di per sé eccellenti, né delle due dimostrazioni, bensì la conseguenza di un apriori implicito.
Nell’uomo di questo nuovo tipo, la volontà di lavoro costituisce il primum movens, per cui il mondo configurandosi come la condizione prima di esso, viene considerato insieme alla vita in maniera affatto meccanica. Dopo che il nuovo tipo umano, guidato da quegli istinti che lo trascinano alla morte nonostante il suo aspetto florido, ha optato per quanto è morto e calcolabile e quindi meno temibile, anziché per ciò che è vivente e imponderabile, e che è quindi tensione verso l’“improbabile”, come lo Auerbach ebbe felicemente a definire la vita; dopo essere diventato scettico, costituzionalmente scettico non solo nei confronti dell’audacia, del coraggio, della volontà di potenza e di conquista, ma anche nei confronti della disponibilità al sacrifico e cioè alla bontà e all’amore generosi e disinteressati; dopo tutto ciò, ome poteva questo nuovo tipo umano concepire la vita, se non secondo la definizione del signor Spencer? E cioè come un adattamento, come un caso limite particolarmente complesso e calcolabile secondo i principi della meccanica?
L’uomo contemporaneo non può valutare se stesso che secondo le strutture tipiche dell’Erlebnis del proprio tempo […]. Dilthey ha chiarito in maniera magistrale come la concezione moderna della vita psichica sia a sua volta condizionata dalla storia, e come essa sia sostanzialmente solo un elemento costitutivo della struttura dell’Erleben del mondo moderno.
La coscienza si determina infatti esclusivamente nella prima re-flexio della sensazione, e cioè sempre in occasione di una resistenza: ogni coscienza si fonda sulla sofferenza e tutti i gradi superiori della coscienza su una crescente sofferenza sperimentata nell’originario movimento spontaneo. Per quanto mi concerne, io rifiuto ambedue queste teorie, nell’atto di affermare che l’essenza dell’uomo, insieme con quella che possiamo definire la sua “posizione particolare”, trascendono ciò che chiamiamo intelligenza e facoltà di scelta, e non possono essere intese, neanche aumentando queste due facoltà quantitativamente all’infinito. Ma sarebbe altrettanto sbagliato considerare quell’elemento nuovo che rende l’uomo tale, esclusivamente come un grado essenziale […] di quella facoltà e funzioni pertinenti alla sfera psichica e vitale, e il cui studio rientrerebbe nell’ambito della psicologia e della biologia. Il principio nuovo si trova fuori da tutto ciò che noi possiamo definire nel senso più lato come “vita”.
Il principio nuovo si trova fuori da tutto ciò che noi possiamo definire nel senso più lato come “vita”. Ciò che fa sì che l’uomo sia veramente “uomo”, non è un nuovo stadio della vita —e neppure una delle sue manifestazioni, la “psiche” —, ma è un principio opposto a ogni forma di vita in generale e anche alla vita dell’uomo: un fatto essenzialmente e autenticamente nuovo che come tale non può essere ricondotto alla “evoluzione naturale della vita”; ma semmai, solo al fondamento ultimo delle cose stesse: a quello stesso fondamento dunque, di cui “vita” non è che una manifestazione. Già i greci affermarono l’esistenza di tale principio, chiamandolo “ragione”. Noi preferiamo usare, a proposito di questa X, un termine più vasto, un termine che, pur abbracciando il concetto di “ragione”, contenga altresì, accanto al “pensiero ideativo”, un certo genere di “intuizione”, quella cioè dei proto-fenomeni o dei contenuti essenziali, e inoltre una certa classe di atti emozionali e volitivi […]: noi preferiamo cioè usare il termine “spirito”. La caratteristica fondamentale di un essere spirituale, qualunque possa essere la sua costituzione psico-fisica, consiste nella sua emancipazione esistenziale da ciò che è organico, nella sua libertà, nella capacità che esso, o meglio il centro della sua esistenza, ha di svincolarsi dal potere, dalla pressione, dal legame con quanto è organico, dal legame con la “vita” e con quanto essa abbraccia, e quindi altresì dal legame con la propria “intelligenza” ancora sottomessa alla tendenza. Un essere “spirituale” non più legato alla tendenza e all’ambiente, ne è “libero”, e perciò “aperto al mondo”; un essere siffatto possiede un suo “mondo”, ed è altresì capace di trasformare quei centri di “resistenza” e di reazione del suo ambiente, che originariamente anch’egli possiede (i soli per l’animale che vi è immerso extaticamente) in “oggetti”.
Il decorso del comportamento animale presenta costantemente questa forma:
An (Animale) ⇔ Am (Ambiente)
Un essere che ha lo spirito è completamente diverso. Un essere siffatto – se e fin dove usufruisce, per così dire, del suo spirito – è capace di un comportamento il cui corso ha la forma esattamente opposta […]. La forma di siffatto comportamento è quella dell’“apertura al mondo” e del rovesciamento del potere dell’ambiente:
U (Uomo) ⇔ M (Mondo) ⇒ ⇒
L’uomo è perciò quell’X capace di comportarsi come un essere illimitatamente “aperto al mondo". Diventare uomini significa elevarsi, in forza dello spirito, fino a potersi aprire al mondo. L’animale non ha “oggetti”, esso vive solo extaticamente entro il suo ambiente, che porta strutturato in sé come la lumaca la sua conchiglia, ovunque vada, e non è in grado di oggettivare codesto ambiente. L’animale non sa quindi allontanare, distanziare l’“ambiente” in un “mondo” (o in un simbolo), come è in grado di fare l’uomo.
L’uomo possiede, preliminarmente, un proprio spazio […]. L’animale è privo di questa funzione centrale, che dà a uno spazio unico una forma fissa, prima ancora della percezione delle singole cose […]. L’animale ignora […] un vero e proprio “spazio mondiale” […] e non concepisce altresì quelle “forme vuote” di spazio e tempo, entro le quali l’uomo coglie originariamente le cose e gli avvenimenti […]. La radice dell’intuizione umana di spazio e tempo, che precede tutte le altre sensazioni esterne, risiede nella capacità organica di muoversi spontaneamente e di agire secondo un ordine preciso.
Solo l’uomo, in quanto persona, è in grado di elevarsi al di sopra di se stesso come essere vivente, e, partendo da un centro che trascenda il suo mondo spazio-temporale, è in gradi di trasformare ogni cosa, compreso se stesso, in oggetto di conoscenza. Così l’uomo, come essere spirituale, è posto al di sopra del suo stesso essere vitale e del mondo.
Noi non giungiamo a porre la realtà del mondo esteriore […] in base a un ragionamento; ciò che ci dà l’esperienza interna della realtà […] è l’impressione interiore di una resistenza. Se è vero che l’esistenza è “resistenza”, quest’atto fondamentale ascetico di derealizzazione può consistere solo nell’abolire e neutralizzare, appunto, quell’impulso vitale in rapporto al quale il mondo appare anzitutto come resistenza […]. L’uomo è perciò l’essere vivente che, in virtù del suo spirito, è in grado di comportarsi in maniera essenzialmente ascetica nei confronti della sua vita […]. Paragonato all’animale che dice sempre “sì” alla realtà effettiva — anche quando l’aborrisce e la fugge — l’uomo è “colui che sa dir di no”, l’“asceta della vita”, l’eterno protestatore contro quanto è soltanto realtà.
In ogni caso – comparato all’animale, la cui esistenza è un’incarnazione dello spirito borghese – l’uomo è l’eterno “Faust”, la bestia cupidissima rerum novarum, mai paga della realtà circostante, sempre avida di infrangere i limiti del suo essere “ora-qui-così”, sempre desiderosa di trascendere la realtà circostante: e con essa anche i limiti della propria realtà personale presente.
Solo nell’urto di questa violenta tempesta che è il “mondo”, può prodursi una reciproca penetrazione ontologica delle forme e dei valori con le potenze realmente attive […]. In altre parole, lo scopo e il fine dell’essere e del divenire finito sono al reciproca penetrazione dello spirito originariamente impotente e dell’impulso originariamente demonico, cieco cioè a tutte le idee e valori spirituali: la progressiva ideazione e spiritualizzazione delle forze oscure celate dietro le immagini delle cose e il simultaneo potenziamento vivificatore dello spirito.
Il risultato più soddisfacente del tentativo di descrivere il progressivo sviluppo della natura umana, a partire dai gradi di esistenza che le sono subordinati, consiste nel poter dimostrare la necessità intrinseca onde l’uomo, nel momento stesso in cuiè diventato “uomo”, per quella coscienza del mondo e di sé e per la oggettivazione della propria natura psico-fisica – che sono il segno fondamentale e specifico dello spirito – deve altresì cogliere l’idea più universale di un essere sovramondano, infinito, assoluto. Dopo essersi posto al di fuori della natura tutta e aver fatto di questa il proprio “oggetto” – atto che appartiene alla sua essenza e alla sua stessa apparizione –, l’uomo si volge sgomento attorno, chiedendosi: “Dove sono, dunque, io stesso? Qual è il mio posto?”. Invero egli non può dire: “Io sono una parte del mondo, e sono compreso in esso”, poiché l’essere attuale del suo spirito e della sua persona trascende le forme di questo “mondo” spaziale e temporale. Nel volgersi attorno, egli affonda necessariamente lo sguardo nel nulla, e scopre anzi la possibilità del “nulla assoluto”. Il che lo porta a chiedersi: “Perché vi è un mondo? Perché ci sono io?” […]. Nell’istante preciso in cui diviene cosciente del “mondo” e di se stesso, l’uomo deve scoprire con un’evidenza intuitiva, il caso singolare, il fatto contingente “che vi è un mondo anziché non esservi” e “che egli stesso è, anziché non essere”.
Il centro, quindi, di tale autorealizzazione, ovvero dell’autodivinizzazione che l’Essere-per-sé cerca, e per la quale si è legato il mondo come “storia”: questo centro è precisamente l’uomo, l’io umano, il cuore umano: essi costituiscono l’unico luogo a noi accessibile in cui Dio viene a formarsi, ma sono altresì una parte vera e propria di questo processo trascendentale.
A priori dunque, secondo la nostra convinzione, la formazione umana e quella divina sono correlative. Come l’uomo non può compiere il suo destino senza la consapevolezza di essere partecipe dei due attributi dell’Ente supremo e di essergli immanente; neanche l’Ens a sé può compiere il proprio senza la cooperazione dell’uomo. Lo spirito e l’impulso, i due attributi dell’Essere, non sono completi in sé senza una mutua progressiva penetrazione, nella quale è iscritto il loro fine; l’uno e l’altro sviluppano se stessi proprio manifestandosi nella storia dello spirito umano e nell’evoluzione della vita universale. Si obietterà, come in effetti è stato fatto, che per l’uomo non è sopportabile gravarsi del peso di un Dio incompiuto, di un Dio in divenire! Rispondo che la metafisica non è un istituto di rassicurazione per uomini deboli e bisognosi di sostegno. Essa presuppone già nell’uomo un senso di forza e di fiducia. Pertanto è anche comprensibile che è solo nel corso della sua evoluzione e della sua autocoscienza che l’uomo giunge a rendersi conto dell’azione e della lotta che ha in comune con la divinità.
Certo, esiste anche per noi un “sostegno”: ed è il sostegno formato da tutta l’opera di realizzazione dei valori nella storia universale trascorsa, per quel tanto che essa ha fatto progredire verso un “Dio” il divenire della “divinità”.