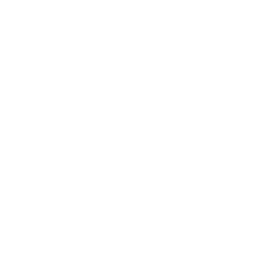Orizzonte Altro

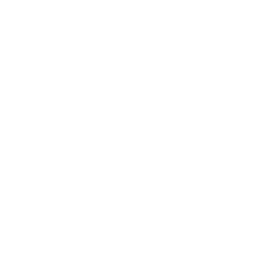
Antologia filosofica del 900
Oswald Spengler
Blankenburg 1880 - Monaco di Baviera 1936
Secondo l'Ordine del Tempo
Eraclito
Uno studio sui concetti energetici fondamentali della sua filosofia
Heraklit
Eine Studie Ber Den Energetischen Grundgedanken Seiner Philosophie, 1904
Edizione italiana: BookTime, Milano 2019
La filosofia greca del VI e V secolo […] raggiunge la sua vetta con lo ionico Eraclito. La Grecia non ha più prodotto uomini così straordinari, capaci di creare, uno dopo l’altro, con tratti magistrali, un quadro del cosmo che, per nulla critico e accompagnato dal proposito di soddisfare le esigenze della scienza rigorosa, abbraccia tuttavia con sguardo potente e in una intuizione suprema il senso del mondo, il suo passato e il suo futuro.
L’idea attraverso cui Eraclito diede una nuova interpretazione dell’essere cosmico è energetica: quella di un puro (immateriale) accadere conforme a leggi. La distanza di tale idea dall’intuizione degli altri e cioè, in egual misura, degli ionici, degli eleatici, degli atomisti, è straordinaria. Con essa Eraclito è rimasto, tra i Greci, in completa solitudine. Non esista una seconda concezione di tal genere. Tutti gli altri sistemi contengono il concetto di fondamento sostanziale.
Noi vediamo un uomo in cui tutto il sentire e il pensare sono sotto il dominio di un’irrefrenabile disposizione aristocratica, costituitasi vigorosamente per nascita ed educazione e sollecitata e accresciutasi grazie a ostacoli e delusioni. Qui è da ricercare la base primaria di ogni tratto della sua vita e ogni peculiarità dei suoi pensieri. nell’energica concentrazione del sistema, nell’evitare e sdegnare dettagli e questioni marginali, nella stesura di frasi brevi e intense solo a lui famigliari, riconosciamo la mano dell’aristocratico.
Fra i presocratici Eraclito è l’artista più significativo. Ne è testimonianza non solo il pathos intenso e policromo dello stile, ma anche la geniale plasticità delle rappresentazioni. Egli vede le sue idee, non le calcola […]. Per lui sono degne di riflessione solo idee grandi e fondamentali, mentre nutre una spiccata avversione nei confronti della vera e propria ricerca scientifica dei dettagli. Possiede una visione specifica, rigorosamente determinata di come si debba pensare. Non si deve voler sapere tutto, ma solo ciò che è grandioso e di valore: occorre scegliere poco ma, questo, penetrarlo. Vuole profondità, contenuto intrinseco, chiarezza, non la totalità del sapere.
L’idea fondamentale su cui Eraclito basò la sua intuizione del mondo è già interamente contenuta nel famoso παντα ρει. Il mero concetto dello scorrere (del mutamento) è però troppo indeterminato per far riconoscere le più fini e profonde sfumature di tale idea […]. Assunto un sostrato con l’unica determinazione della permanenza, il mutamento appare come il modo in cui il permanente esiste in ogni momento […]. Un portatore corporeo del movimento non è necessario alla rappresentazione dell’agire nello spazio, della “realtà”. In questo la teoria energetica proposta da Mach e Ostwald è molto più vicina alle idee di Eraclito […]. Ciò che è presente nello spazio è esclusivamente energia. “Se immaginiamo la materia senza i diversi tipi di energia, non rimane nulla, neppure lo spazio che essa occupava. Perciò la materia non è niente altro che un gruppo spazialmente ordinato di diverse energie e tutto quello che volessimo dire di lei lo diremmo di tali energie” (Ostwald [...]). A questa sostanza è però […] applicabile la […] determinazione kantiana secondo la quale essa stessa permane […] e cambia solo il suo modo di esistere (le “forme” di energia, luce, calore, elettricità). L’intuizione greca è sin dall’inizio un’altra. Il concetto di forza, sconosciuto ai Greci, appare solo con Galilei. Noi distinguiamo tra movimento ed energia. Il movimento (un concetto relativo) presuppone solo un mosso e nient’altro. L’energia (la causa sostanzialmente rappresentata dal movimento) è, essa stessa, una seconda grandezza accanto al mosso, anche se quest’ultimo deve essere di nuovo pensato come insieme di energie. Noi diciamo “la forza agisce in un punto”. Al contrario il monismo greco conosce solo cause immanenti e ideali del movimento […]. Gli atomi di Democrito si muovono grazie alla τυχη; l’atto del movimento è proprio della loro natura. Essi non hanno bisogno di una energia agente. Quindi per il monismo greco, ciò che è presente nello spazio […], in quanto sostanza unica e indecomponibile, diventa tutt’altra grandezza. Ebbene è questo il concetto di sostanza negato da Eraclito […]. Lo scetticismo assoluto nei confronti del concetto di sostanza è arduo. Parmenide osservò a ragione che tutto il pensiero si riferisce a un essere, che tutto ciò che è pensato riceve, in quel preciso momento, la proprietà della sostanzialità. Poiché il pensiero greco non conosce la separazione del movente dal mosso ed Eraclito sottolinea esplicitamente l’unità nell’accadere cosmico […], l’assunzione di un “divenire” puro, indiviso, continuo, che gli eleati negano, deve escludere in ogni senso il concetto di sostanza. Nell’esposizione di tale idea sorgono le estreme difficoltà linguistiche […]. Non possiamo, in modo adeguato, esprimere linguisticamente la negazione dell’essere […]. Il linguaggio è filosofia eleatica.
Eraclito non impiega mai il concetto di sostanza […]. Egualmente non conosce il concetto di spazio vuoto […]. Egli tentò di trovare un’espressione adeguata alla novità dei suoi pensieri […]. Nei frammenti 10 e 41 si scorge senza dubbio il tentativo di una formula energetica per esprimere il puro agire, non connesso a materia, nello spazio.
L’equilibrio dell’antagonismo dell’agire sarebbe l’eterna quiete […]. Dobbiamo pensare l’agire eterno come crescita e decrescita delle tensioni (opposti) […]. Tali immagini, secondo le quali l’agire nello spazio, quindi l’incremento e il decremento di tensioni opposte, si verifica nell’ininterrotta presenza di una tendenza all’equilibrio, l’energetica le conosce come legge di Helm: “ogni forma di energia possiede la tendenza a passare dai luoghi in cui è presente una maggiore intensità, ai luoghi in cui l’intensità è minore”.
Tutti questi tentativi di ottenere una nuova intuizione dell’accadere sorgono dalla negazione dell’essere permanente. Non si comprende tutto nel fluire – “tutto” sarebbe ancora un essere – il fondo dell’apparire è piuttosto da pensare come puro agire; se si vuole, come somma di tensioni.
Abbiamo appreso il concetto del puro movimento nella versione del παντα ρει. C’è ancora una seconda configurazione del medesimo pensiero, che si distingue solo per il diverso punto di vista dell’osservatore. Ci si può rappresentare l’intero processo di ciò che accade come unità; si ha allora l’impressione del senza-inizio e del senza-fine, della mancanza di un punto morto e di un punto di appoggio, si ha l’impressione del fluire in senso proprio. Possiamo poi considerare il medesimo processo riguardo alle sue singole fasi – contemporaneamente e in successione – e paragonare gli stati singoli formanti le serie, secondo i loro rapporti reciproci. Tali frammenti di divenire, tratti fuori soggettivamente dal continuo corso dell’accadere […] sono di specie diversa, si escludono e stanno in reciproca opposizione. In questo atto spirituale sta l’origine dell’opposizione; essa si genera dal conflitto.
Si afferma erroneamente che Eraclito avrebbe negato o dichiarato identici gli opposti […]. Al contrario egli ha accentuato le opposizioni; Eraclito era un aristocratico che possedeva il “pathos della distanza” in estremo grado e non gli sarebbe mai venuto in mente di attenuare le differenze o di volerle contestare. Perciò non parla mai di identità degli opposti – una contradictio in adjecto – bensì dell’identità di origine e del carattere relativo degli opposti. Non contesta l’opposizione ma la sua realtà oggettiva […]. Gli opposti sono necessari non solo per la propria alterna esistenza, essi possiedono un significato decisivo per l’intero processo cosmico. Senza la presenza delle differenze l’accadere (consistente nella tensione all’equilibrio) sarebbe impensabile.
La contraddizione degli opposti appare all’occhio artistico di questo elleno come αγων. Con ciò veniva nuovamente soddisfatto il suo impulso verso una configurazione non scientifica, ma tangibile, plastica e sublime del cosmo, e qui Eraclito è presente con tutto il suo cuore.
Eraclito concepisce il mondo come puro movimento. Il λογος è di conseguenza il suo ritmo, la misura del movimento. In tale sistema, che non conosce alcun essere permanente, risulta tanto più evidente la stima nei confronti della metrica. Ricordiamoci ancora una volta in che misura si è sviluppata nei greci la sottile sensibilità per le forme, essa non si limitava solo all’arte figurativa, tutte le manifestazioni della vita avvenivano spontaneamente nei limiti di una certa misura […]. Eraclito ha appunto messo in rilievo l’armonia all’interno della lotta degli opposti. Ed essa è armonia metrica […]. In un mondo senza alcuna qualità materiale, che non è null’altro che ininterrotta tensione di differenze contrapposte all’interno di un processo in movimento, ciò che maggiormente permane è la misura. Se tentiamo di determinare con precisione il rapporto della misura al movimento otteniamo la caratteristica della prima quale forma del moto, così esprimendo la sua incondizionata necessità rispetto a quest’ultimo. Il moto senza una forma si lascia tanto poco pensare quanto un corpo senza figura. Per tale principio, che considerala misura del divenire, la parola ritmo è la più adatta, essendo certo che Eraclito recepiva soprattutto l’aspetto artistico, musicale di tale rappresentazione e a esso voleva attenersi. Il greco esigeva la bellezza delle proporzioni da tutto ciò che è creato per l’occhio.
Il mondo concettuale di Eraclito, visto come tutto, appare un grandioso poema, una tragedia del cosmo; nella sua forza sublime degna di quella eschilea. Tra i filosofi greci, eccettuato forse Platone, Eraclito è il poeta più importante. L’idea di un’incessante contesa che dura dall’eternità, che forma il contenuto della vita nel cosmo nel quale domina una legge imperiosa e si conserva un’armoniosa regolarità, è una grande creazione dell’arte greca cui questo pensatore è riuscito ad avvicinarsi molto più della vera e propria scienza naturale.
Anni della decisione
Jahre der Entscheidung, 1933
Edizione italiana: OAKS Editrice, 2018
Il grande giuoco della politica mondiale non è giunto alla fine. Le più importanti mosse vengono compiute solo ora. Per ciascuno dei popoli viventi si tratta della grandezza o dell’annientamento.
Quelli in cui viviamo sono decenni violenti, vale a dire spaventosi e sfortunati. Grandezza e felicità sono due condizioni che si alternano ed a noi non è concessa la scelta. Nessuno che oggi vive in una qualsiasi parte del mondo sarà felice; ma a molti è possibile il cammino degli anni secondo la volontà personale, in grande od in piccolo. Invece, chi vuole soltanto benessere non merita di vivere su questa terra.
Se tuttavia qui deve essere posto il fondamento duraturo di un grande avvenire, sul quale le future generazioni possano costruire, occorre ricordare che questo non sarebbe stato possibile senza l’azione costante delle antiche generazioni. Ciò che abbiamo nel sangue dei nostri padri, idee senza parole, è l’unica cosa che garantisce la solidità dell’avvenire.
Per poter servire una idea, dobbiamo dominare noi stessi, essere preparati per convinzione a sacrifici interiori.
Noi viviamo un’èra fatale. Questa drammatica epoca storica è iniziata non soltanto con la faustiana cultura dell’Europa occidentale e la sua straordinaria dinamica, ma proprio col dipanarsi della storia universale tutta, più grande e molto più terribile che ai tempi di Cesare e Napoleone.
Così poco sa l’uomo degli eventi futuri, solo la forma generale delle realtà future ed il loro sviluppo nel tempo, che egli può desumere dal confronto con le altre culture, così è certo che le potenze creatrici dell’avvenire non sono altro che quelle del passato: la volontà del più forte, i sani istinti, la razza, la volontà di possedere e di potenza: e così vacillano i sogni senza forma e che rimarranno sempre sogni: giustizia, felicità e pace.
È l’arroganza dello sradicato spirito cittadino, non più accompagnato da alcun forte istinto, che guarda con disprezzo dall’alto il pensiero carico di sangue del passato e la saggezza delle antiche generazioni di contadini.
L’ottimismo superficiale del filisteo della cultura comincia a non temere più le realtà elementari della storia, ma anzi le disprezza.
Questo cattivo sentimentalismo che pesa su tutte le correnti teoretiche di questi due secoli, il liberalismo, il comunismo, il pacifismo, sopra tutti i libri, discorsi e rivoluzioni, nasce dallo smarrimento spirituale, dalla debolezza personale, dalla mancanza di disciplina formata da una antica e severa tradizione. Esso è “borghese” o “plebeo”, per quanto queste parole suonino offesa. Vede le cose umane, la storia, il destino politico ed economico dal basso, in maniera piccola e gretta, dalla finestra della cantina, dal vicolo, dal caffè dei letterati, dal comizio popolare, non dall’alto e da lontano. Ogni tipo di grandezza, tutto ciò che si innalza, domina, sovrasta, gli è odioso.
Noi viviamo, dunque, in un’epoca forte. È la più grande che la cultura dell’Occidente abbia mai sperimentato e mai più sperimenterà; la stessa che il mondo antico ha vissuto tra Canne ed Anzio; la stessa nella quale risplendono i nomi di Annibale, Scipione, Gracco, Mario, Silla, Cesare. La guerra mondiale è stata per noi solo il primo lampo e tuono della nuvola tempestosa che passa gravida di destino su questo secolo. L’aspetto del mondo viene oggi radicalmente trasformato come avvenne allora per opera dell’incipiente Imperium Romanum, senza tener conto della volontà e dei desideri “dei più” e senza considerare i sacrifici, che ogni simile decisione richiede […]. L’epoca è forte, ma gli uomini sono tanto più piccoli. Non sopportano più alcuna tragedia, né sulla scena né nella realtà. Essi vogliono, miseri e stanchi come sono, l’happy end dei romanzi superficiali. Ma il destino che li ha gettati dentro questi decenni, li afferra per il collo e fa con loro, che essi lo vogliano o no, ciò che deve essere fatto. La vile sicurezza della fine del secolo scorso si è conclusa. La vita pericolosa, la vera vita della storia, entra di nuovo nel suo diritto.
Chi non può vivere e tollerare la tragedia non può neanche essere una figura di efficacia universale. Chi non vive la storia, come realmente essa è, vale a dire tragica, squassata dal destino, senza un senso obiettivo e morale agli occhi degli adoratori dell’utile, quello non è neanche in grado di fare della storia.
Quanto più profondamente noi procediamo dentro il cesarismo del mondo faustiano, tanto più chiaramente si deciderà chi, da un punto di vista etico, è destinato a diventare soggetto e chi oggetto dello svolgimento storico. La triste processione dei riformatori del mondo che fin da Rousseau trotterellò attraverso questi secoli e. come unico ricordo della sua esistenza, lasciò per strada montagne di carta stampata, è alla fine. Al suo posto vengono i Cesari.
Noi siamo entrati nell’epoca delle guerre mondiali. Inizia nel XIX secolo e durerà per quello attuale e forse anche per il successivo. Significa il passaggio dal mondo degli Stati del XVIII secolo all’Imperium mundi. Corrisponde ai due secoli tremendi tra Canne ed Anzio che condussero dagli Stati del mondo ellenistico, comprese Roma e Cartagine, all’Impero Romano. Come quest’ultimo abbracciò la sfera della civiltà antica e delle sue irradiazioni, vale a dire il mondo mediterraneo, nello stesso modo quello nuovo dominerà per un periodo di tempo sconosciuto il destino del globo terrestre.
Quello che noi oggi riconosciamo come “ordinamento” e codifichiamo nelle costituzioni liberali, non è altro che una anarchia divenuta consuetudine. Noi la chiamiamo democrazia, parlamentarismo, autogoverno del popolo, ma in effetti è soltanto la mancanza di una autorità consapevole della propria responsabilità, di un governo e di conseguenza di un vero Stato […]. Una repubblica moderna è nient’altro che la rovina di una monarchia, che si è arresa.
La stampa, nata come organo dell’opinione pubblica, serviva da tempo chi la pagava; le elezioni una volta espressione di questa opinione, portavano alla vittoria il partito, dietro il quale stavano i più facoltosi elargitori di denaro.
Uno dei segni più gravi della decadenza della dignità dello Stato sta nel fatto che nel corso del XIX secolo predomina la convinzione che l’economia sia più importante della politica […]. Nella storia, sino a quando essa si svolse in una certa “forma” e non in mezzo a tumulti e rivoluzioni, il condottiero economico non è mai stato signore delle decisioni. Egli obbediva alle considerazioni politiche, le serviva con i mezzi che aveva nelle mani. Senza una politica energica non vi è mai stata, ed in nessun posto, una economia sana, nonostante che la teoria materialistica insegni il contrario.
Negli Stati Uniti […] la vita è esclusivamente plasmata in maniera economica e perciò priva di profondità, tanto più quanto le manca l’elemento della vera tragedia storica, il destino grandioso che durante i secoli ha approfondito ed educato l’animo dei popoli occidentali.
Sallustio aveva ben ragione: per il vile danaro, del quale erano avidi nella stessa misura sia la plebe che i ricchi speculatori, sono andati in rovina l’onore e la grandezza di Roma, la sua razza, la sua idea.
La scena di questa rivoluzione della vita, la sua “base” e nello stesso tempo la sua espressione è la grande città, quale essa incomincia a formarsi nell’epoca tarda di tutte le culture. In questo mondo di pietra si raccoglie in misura sempre crescente una popolazione sradicata, che viene sottratta alla campagna, “massa” nel senso peggiore, sabbia umana priva di forma, con la quale si possono impastare delle figure artificiali e perciò evanescenti, partiti, organizzazioni, formati secondo programmi e ideali, nei quali sono del tutto spente le forme di un accrescimento naturale, saturo di tradizione attraverso il susseguirsi delle generazioni, e prima di tutto la naturale fecondità di ogni vita, l’istinto per la durata della famiglia e della razza […], l’istinto di sopravvivere nel sangue dei discendenti, nelle cure creatrici per essi, nella durata del proprio nome.
Questo modo di vivere inglese e materialistico, che si era sviluppato sin dai tempi di Adam Smith, a causa del crescente razionalismo, e quasi cento anni fa venne trasferito da Marx in un sistema piatto e cinico, non diventa più giusto solo perché si è fatto valere e in questo momento domina il pensiero tutto, le prospettive e i desideri dei popoli bianchi. Esso è un segno della decadenza della società e niente di più.
È il punto di vista dei proletari e dei parvenus, che nella loro intima essenza sono dello stesso ceppo: la stessa pianta del lastricato delle grandi città, dal ladro ed agitatore di piazza fino allo speculatore di borsa ed al politicante di partito.
Tra i proprietari delle piantagioni dell’America del Sud spagnola e di quelle dell’America del Nord inglese si era formata da lungo tempo una vera aristocrazia sul modello dei Grandi di Spagna e dei Lords inglesi. Essa fu annientata nella guerra civile del 1861-65, e sostituita dai parvenus di New York e Chicago con il peso dei loro miliardi.
Una povertà sopportata in maniera dignitosa ed umile, silenzioso compimento del dovere, sacrificio in funzione di un compito o di una convinzione, grandezza nel sopportare il destino, fedeltà, onore, responsabilità, dedizione, tutto ciò è continuo rimprovero per gli “umiliati ed offesi”. Poiché, sia detto ancora una volta, il contrario di distinto non è povero, ma volgare […]. Ogni essere razionale possiede e domina una forma, ci si sente dentro a suo agio, mentre l’uomo volgare la sente come un legame, nel quale non si muoverà mai liberamente; mentre il fatto che il tatto, il buon gusto, il senso della tradizione, sono cose che appartengono al patrimonio di culture superiori e presuppongono una educazione, come anche il fatto che esistano ambienti nei quali il sentimento del dovere e la rinuncia non sono ridicoli, ma conferiscono distinzione, tutto questo riempie il nichilista di una cupa ira, che nei tempi passati si annidava negli angoli e là sfogava là sua bile nella maniera di Tersite, ma oggi si allarga e si estende su tutti i popoli bianchi sotto la forma di opinione universale […]. La plebe è ormai quella che dà il tono.
Un volto distintamente plasmato, un piede sottile che si solleva leggero e grazioso dal lastricato, contraddicono ogni democrazia.
È questa la tendenza del nichilismo: non si pensa di elevare la massa all’altezza della vera cultura; ciò è faticoso e scomodo, e forse mancano determinate premesse. Al contrario: la struttura della società deve essere livellata fino al basso gradino della plebe. L’uguaglianza generale deve dominare: tutto deve essere egualmente volgare. Lo stesso modo di procurarsi denaro e la stessa specie di divertimenti per spenderlo: panem et circenses. Non occorre di più, né si capisce di più. Superiorità, maniera, gusto, ogni tipo di dignità interiore sono delitti. Le idee etiche, religiose, nazionali, il matrimonio, la famiglia, la dignità dello Stato sono passati di moda e sono “reazionari”.
Io parlo del patrimonio in quanto esso ha in sé la tradizione di una cultura. Esso significa intima superiorità; esso distingue classi intere di uomini. Non occorre molto: una piccola fattoria ben tenuta, un solido mestiere di buona fama, un minuscolo giardino nel quale si vede l’amore con cui viene curato, la casa pulita di un montanaro, un paio di libri o riproduzioni di antiche opere d’arte. La cosa necessaria è che si trasformino queste cose in un modo personale, e che le stesse vengano penetrate dalla personalità di chi le possiede. Il vero patrimonio è spirituale e di conseguenza vera cultura. Apprezzarlo secondo il suo valore in danaro è qualcosa di simile ad un equivoco o ad una profanazione.
La mèta venne indicata nel 1848, quando si ebbero le prime esperienze rivoluzionarie, tipo dittatura del proletariato, che allora avrebbe potuto essere chiamata dittatura della borghesia, in quanto il liberalismo non vuole essere altro. Questo è il significato ultimo delle costituzioni delle repubbliche e del parlamentarismo.
Il “capitalismo” non è affatto una forma della economia o un metodo “borghese” per fare soldi. Esso è un modo di vedere le cose.
“Capitalismo” e “socialismo” hanno la stessa età, sono intimamente uniti, sono sorti da una identica mentalità e sono gravati dalle medesime tendenze. Il socialismo non è nient’altro che il capitalismo della classe inferiore. La dottrina libero-scambista manchesteriana di Cobden ed il sistema comunistico di Marx sono sorti entrambi intorno al 1840 in Inghilterra.
Entrambe [le armi teoretiche di finanzieri e sindacati socialisti] rappresentano il principio dell’“internazionale”, che è puramente nichilistico e negativo: esso si erge contro le forme storiche e circoscritte – ogni forma, ogni figura è limitazione – della nazione, dello Stato, dell’economia nazionale, di cui “l’economia mondiale” non è che la somma. Queste forme ostacolano sia le mire dell’alta finanza, sia quelle dei rivoluzionari di professione. Perciò vengono negate e devono essere distrutte.
Il socialismo operaio in ogni forma […] è di origine inglese ed è sorto intorno al 1840, insieme al potere assoluto sul capitale azionario, come forma vittoriosa del capitale finanziario cosmopolita. Ambedue sono espressioni del liberalismo commerciale manchesteriano; questo bolscevismo “bianco” è capitalismo dal basso, capitalismo da salari, così come il capitale della finanza speculatrice, secondo i suoi metodi, è socialismo dall’alto e proviene dalla Borsa. Ambedue hanno la stessa radice intellettuale, il pensare al danaro, il trattare di affari sui marciapiedi delle città di tutto il mondo se per aumento dei salari o per aumento dei costi, non ha alcuna importanza. Tra il liberalismo economico e il socialismo non vi è alcun contrasto. Il mercato del lavoro è la Borsa del proletariato organizzato.
Siamo ancora lontani dal prendere in sufficiente considerazione il carattere catastrofico ed espropriatore dei pacchetti di azioni e delle partecipazioni azionarie, la separazione del semplice “avere” dalla direzione responsabile dell’imprenditore, il quale non sa neanche più a chi veramente appartenga la sua impresa. L’economia produttiva è alla fine niente altro che un oggetto privo di volontà nelle manovre di Borsa.
Questi socialisti della finanza e magnati dei trust, come Morgan e Kreuger, corrispondono esattamente ai capi delle masse dei partiti operai ed ai commissari russi dell’economia: nature di negozianti con eguali gusti da arricchiti. Da ambedue le parti, oggi come al tempo dei Gracchi, vengono combattute le potenze conservatrici dello Stato, dell’esercito, della proprietà, dei contadini come degli imprenditori.
L’idea prussiana è contro il liberalismo della finanza come contro il socialismo operaio […]. Prima di tutto si pone contro la debolezza dello Stato e l’avvilente abuso che dello Stato si fa a favore di determinati interessi economici.
È un bisogno del popolo, quello di simpatizzare, di agire con gli altri. Invece lo stile prussiano è un rinunciare per libera decisione, il ripiegarsi di un forte Io di fronte ad un grande dovere od un grande compito, un atto dell’individualismo, per quel che oggi è umanamente possibile. La “razza” celtico-germanica è la più forte per volontà che il mondo abbia mai visto. Ma questo “Io voglio” - Io voglio! – che riempie tutta l’anima faustiana e spiega il senso ultimo del suo essere e domina ogni espressione della cultura faustiana, nel pensiero, nell’azione, nelle immagini e negli Stati, risvegliò la consapevolezza della perfetta solitudine dell’Io nello spazio infinito. Volontà e solitudine sono in fondo la stessa cosa.
Occorre precisare che quando qui si parla di razza, essa non deve essere intesa in quel senso darwinistico, e più esattamente materialistico, che è oggi di moda tra gli antisemiti d’Europa e d’America. Unità di razza è una parola grottesca, di fronte al fatto che da secoli tutte le stirpi e le popolazioni si sono mescolate, e che proprio le generazioni guerriere, e quindi da sempre sane e ricche d’avvenire, hanno incorporato volentieri uno straniero, se egli era di “razza”, ed a quale stirpe egli appartenesse, non aveva alcuna importanza. Chi parla troppo di razza, proprio questi non ne possiede più. Quello che importa non è la purezza, ma la forza della razza che un popolo ha in sé.
L’uomo vuole avere dei figli validi, che possano, dopo la propria morte, conservare nel futuro il suo nome e le sue azioni, allo stesso modo di come egli si sente erede della fama e dell’opera dei suoi antenati. Questo è il concetto nordico dell’immortalità. Questi popoli non ne hanno mai conosciuto né voluto un altro. Su di esso si basa l’ardente desiderio di gloria, il desiderio di sopravvivere tra i discendenti con un’opera propria, di vedere il proprio nome eternato sopra i monumenti, o almeno di riportare un onorato ricordo nelle future generazioni. Perciò il concetto dell’eredità non è separabile dal matrimonio germanico. Se l’idea della proprietà cade, il senso della famiglia si dissolve nel nulla.
Il declino della famiglia bianca, inevitabile effetto dell’esistenza delle metropoli, coinvolge oggi, finendo per distruggerla, la “razza” delle nazioni. Il significato di uomo o di donna si va perdendo insieme alla volontà di perpetuarsi. Si vive solo per se stessi, non per l’avvenire delle generazioni. La nazione come società, originariamente un organico complesso di famiglie, oggi, con la “grande” città, minaccia di dissolversi in una somma di atomi privati, ognuno dei quali vuol trarre dalla propria vita e da quella degli altri la maggiore quantità possibile di piaceri.
L’emancipazione femminile del tempo di Ibsen non vuole la libertà dall’uomo, ma dai figli, dal peso dei figli, e la contemporanea emancipazione maschile quella dai doveri verso la famiglia, il popolo e lo Stato.
La lotta per il nostro pianeta è incominciata. Se vogliamo vivere ancora, il pacifismo del secolo liberale deve essere superato […]. Il bisogno di una tranquillità del tipo fellah, di una assicurazione contro il destino in ogni suo aspetto, sembra volere questo: una specie di Mimikry [mimetismo] di fronte alla storia mondiale, il fingersi morti come gli insetti umani alla vita del pericolo, lo happy-end di una esistenza vuota, attraverso la cui noia, la musica jazz e le danze negre, possano celebrare la marcia funebre di una grande civiltà. Ma questo non può e non deve essere. L’uomo non può ingannare l’uomo. L’individuo di colore trafigge con lo sguardo quello bianco, quando quest’ultimo parla di “umanità” e di pace perpetua. Egli fiuta l’incapacità e la scarsa volontà di difendersi […]. Non ci possiamo permettere di essere stanchi. Il pericolo batte alla porta. Gli uomini di colore non sono pacifici. Essi non solo attaccati ad una vita di cui la lunghezza è l’unico valore. Raccoglieranno loro la spada, se noi la deporremo. Una volta essi temevano l’uomo bianco, ora lo disprezzano.
Il destino, una volta concretizzatosi in forme significative ed in grandi tradizioni, rifarà la Storia, oggi nascosta sotto l’aspetto di singole forze prove di forma. Le legioni di Cesare si risvegliano. Forse, già entro questo secolo le definitive decisioni attendono il loro Uomo. Di fronte ad esse le piccole mète ed i piccoli concetti della politica odierna sprofonderanno nel nulla. Colui che con la sua spada riporterà allora la vittoria, sarà signore del mondo. Eccoli, i dadi dell’immane giuoco. Chi oserà gettarli?